
Nuove Indicazioni Nazionali: innovazione o rivoluzione?

Da tempo si va sviluppando un intenso dibattito a proposito delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo. Tutto ha preso avvio da un’intervista rilasciata qualche mese fa dal ministro Valditara al quotidiano Il Giornale, nella quale, oltre ad annunciare la prossima presentazione del nuovo testo, il ministro ha lasciato cadere qualche anticipazione (una maggior valorizzazione della lingua italiana, una maggior attenzione alla grammatica, la riproposizione del latino, un nuovo modo di insegnare la storia…).
A questo discutere, confrontarsi o litigare manca, al momento, un elemento fondamentale: la possibilità di leggere il testo di cui si discute. Non sembra un buon inizio, per affrontare una questione così importante. Le Indicazioni nazionali rappresentano il documento di riferimento più autorevole per gli insegnanti, perché propone l’idea di scuola che sono chiamati a realizzare. Modificare o cambiare il testo in vigore interessa tutti, insegnanti, famiglie, associazioni, stakeholder. Non si capisce, perciò, perché tanto ritardo nel mettere a disposizione almeno la bozza sulla quale si intende avviare il confronto.
In attesa che il testo venga al più presto reso pubblico, c’è, però, una domanda che è importante farsi. Siamo di fronte a una revisione/aggiornamento delle Indicazioni attuali, o a un cambiamento radicale?
Scegliere la prima strada significa porsi in continuità con quanto finora era stato chiesto alla scuola, introducendo quei cambiamenti ritenuti indispensabili per fronteggiare le nuove sfide che la società oggi pone. È, questa, la strada dell’innovazione, che deve essere continua, rapida, attenta all’evoluzione del Paese e del mondo; che procede senza strappi e rotture, in modo non ideologico, considerando la scuola come bene comune e non proprietà della parte al momento vincente.
Scegliere, all’opposto, la strada della riscrittura indica, invece, la volontà di fare ‘punto e a capo’. La tentazione della rivoluzione è sempre molto forte, in chi prende il potere. Quello che preme cambiare non è un singolo aspetto di questa o quella disciplina ritenuto obsoleto, non è introdurre qualche nuovo insegnamento, ma è riscrivere la cornice culturale, le idee basilari che reggono la significatività complessiva del testo, il senso della missione della scuola.
Discutere le frammentarie anticipazioni finora diffuse vuol dire animare un confronto inevitabilmente fragile, spesso lanciando come novità cose che nuove non sono (vale per la musica come per il latino, tanto per citare due temi ricorrenti), oppure promettendo modifiche di tipo didattico che esorbitano dalla natura di un testo che dovrebbe orientare il curricolo, non sostituirlo (si possono prescrivere filastrocche o poesie da imparare a memoria?).
Ma, al di là dei frammenti di informazione finora elargiti, resta nell’ombra ciò che è più importante.
Quale è la cornice culturale che farà da sfondo alle future Indicazioni? Sarà ancora quella attuale, sia pure con eventuali aggiornamenti, o sarà un’altra? E per quali ragioni, eventualmente, si deciderà di cambiarla? Che cosa c’è che non convince, nell’idea di scuola che le attuali Indicazioni propongono, e che gli insegnanti, in questi anni, hanno mostrato di capire e condividere? E chi è a non essere convinto e a pretendere una profonda modifica?
Forse questa esigenza è emersa dalle audizioni a suo tempo fatte dalla commissione incaricata? Perché non è stato dato di conoscere quanto hanno detto i vari soggetti ascoltati?
Su tale terreno, soprattutto, si verificherà l’intenzione politica: innovazione, in una linea di continuità culturale e pedagogica o rivoluzione, in una logica alternativa, di punto e a capo?
In altre parole, non sarà il latino, o la Bibbia, o la grammatica a dirci quale sarà la scuola delle nuove Indicazioni, ma la visione culturale che la ispira, nella quale i piccoli o grandi cambiamenti verranno ad inserirsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA









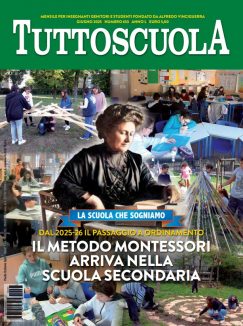




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via