
Matteotti e la ‘Cultura del Popolo’ 100 anni dopo

Nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, deputato dal 1919 e segretario del Partito Socialista Unitario Italiano, nato dopo l’espulsione dei riformisti turatiani dal Partito Socialista Italiano a maggioranza massimalista (ottobre 1922), molte sono state le celebrazioni e gli omaggi resigli in quanto “eroe e martire dell’antifascismo”, ma pochi coloro che hanno evidenziato la sua /parallela e contestuale condanna del comunismo – di quello sovietico come di quello italiano – che gli costò, da parte di Antonio Gramsci, l’epiteto di “pellegrino del nulla”, contenuto in un articolo non firmato ma a lui attribuito, intitolato “Il destino di Matteotti”, pubblicato su “Stato operaio“, il settimanale del Pcd’I.
Bene ha fatto perciò la Fondazione Kuliscioff, promotrice della mostra su “Milano per Matteotti. L’idea che non muore”, in corso al Museo del Risorgimento di Milano fino al prossimo 29 dicembre, a recuperare e ristampare il documento del 1923 (numero 3 della “Biblioteca di propaganda”, pubblicata dal giornale “La Giustizia”), intitolato “Direttive del PSUI” in vista delle elezioni del 1924.
Se ne è parlato sabato 30 novembre a Milano in un dibattito promosso dalla stessa Fondazione, coordinato da Antonio Carioti (Corriere della Sera), nel quale sono intervenuti storici e studiosi di storia del socialismo tra i quali (a distanza) anche Orazio Niceforo che ha fatto notare come il documento programmatico del 1923 si concluda con un paragrafo, intitolato “La Cultura del Popolo”, nel quale si sostiene che “Il primo elemento necessario per una migliore produzione” (non per la conquista del potere da parte di una élite rivoluzionaria, come in quel periodo teorizzava Gramsci sulle orme di Lenin) “è senza dubbio l’istruzione, la cultura del popolo, (…) quella diffusa in tutta la massa”, “strumento primo della loro (dei lavoratori) emancipazione, condizione prima dell’albeggiare della loro coscienza di classe”, “coefficiente ed impulso di ulteriori conquiste economiche e sociali per la classe lavoratrice” e premessa della sua progressiva legittimazione a governare in una società “migliore per solidarietà e giustizia”.
Una visione dell’istruzione, compresa quella tecnica e professionale, come bene popolare e diffuso, antitetica a quella aristocratica e selettiva di Gramsci, che non a caso considerava il liceo classico come la scuola ideale per la formazione della nuova classe dirigente rivoluzionaria: una ristretta minoranza di illuminati chiamata ad esercitare la propria “egemonia” sulla società.
© RIPRODUZIONE RISERVATA








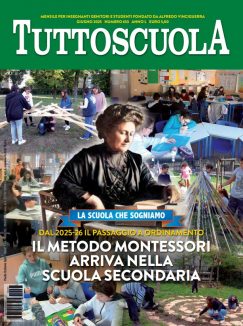




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via