
Do you know Cicerone?
“Yes, of course”, potrebbe essere la risposta che il candidato a insegnare latino potrebbe dare a una delle due domande in inglese che troverà nella prova scritta del prossimo concorso.
Due domande (due e non una, come proposto dal neonato CSPI)? “Yes, of course” era stata anche la risposta data dalla ministra Giannini a chi le chiedeva conferma sul numero dei quesiti in inglese (due su otto: il 25%), apparso a molti eccessivo.
Alle accuse, non nuove, di esterofilia e provincialismo (se ne erano ascoltate di simili anche quando il Politecnico di Milano aveva deciso per primo, qualche anno fa, di far svolgere solo in inglese i corsi per la laurea magistrale), si sono aggiunte anche obiezioni di carattere giuridico come quella avanzata da Pino Turi, segretario della Uil scuola, che dopo aver osservato che “la lingua straniera è un requisito nuovo, finora mai richiesto per diventare insegnante”, ha aggiunto che “non si cambiano le carte in tavola”, lasciando capire che potrebbe esserci spazio anche per ricorsi, in quanto lo studio della lingua straniera nella quasi totalità dei percorsi universitari non è obbligatorio.
Cosa succederà se un concorrente a un posto di docente di latino che avesse tenuto una splendida lezione in italiano per trentacinque minuti, capitasse di fare un errore di inglese rispondendo a una domanda in inglese rivoltagli da un membro della commissione d’esame nei dieci minuti di colloquio che seguono la lezione? Sarà penalizzato per questo rispetto a un altro concorrente un po’ meno bravo di lui nella lezione simulata ma più bravo in inglese? Forse potrebbe essere accordata una preferenza (non un punteggio aggiuntivo) a chi mostra di conoscere l’inglese all’impegnativo livello B2, ma solo a parità di valutazione della lezione svolta in italiano.
Va bene l’apertura internazionale, ma anche le novità vanno gestite con equilibrio. Cicerone (anzi Plinio il Vecchio, per la precisione) direbbe “cum grano salis”.


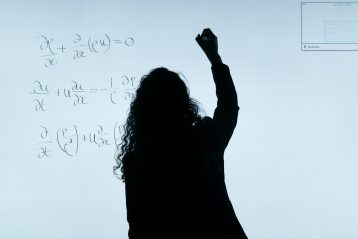










Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via