TRA RIFORMA E SRIFORMA
Tempo di bilanci per l’avventura governativa di Letizia Moratti, che dopo aver presentato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Milano, si appresta ad abbandonare la guida del MIUR a ridosso della scadenza naturale della legislatura, forse nel mese di febbraio 2006. Si può dunque provare a riflettere sull’azione complessivamente svolta in questi quasi cinque anni da quella che molti hanno definito la “lady di ferro” del governo Berlusconi, paragonandola addirittura a Margaret Thatcher, protagonista (nel 1988) di una riforma epocale del sistema educativo inglese.
Il paragone con la Thatcher, per la verità, si regge più sotto il profilo formale che su quello sostanziale, come si mostra più avanti. Però non c’è dubbio che rispetto ai ministri di lunga durata che l’hanno preceduta in viale Trastevere (Gui, Gonella, Malfatti, Falcucci, Berlinguer) la Moratti, che si colloca finora al quarto posto, si è distinta per uno stile di governo più solitario e decisionista, meno incline, anzi per nulla incline alle mediazioni di tipo sia politico che sindacale.
I 10 ministri dell’istruzione più longevi in età repubblicana
1° Luigi Gui 6 anni e 4 mesi (1962-1968)
2° Guido Gonella 5 anni (1946-1951)
3° Franco Maria Malfatti 4 anni e 9 mesi (1973-1978)
4° Letizia Moratti 4 anni e 8 mesi (2001-feb. 2005?)
5° Franca Falcucci 4 anni e 8 mesi (1983-1987)
6° Luigi Berlinguer 4 anni (1996-2000)
7° Riccardo Misasi 3 anni e 5 mesi (1970-72 e 1991-92)
8° Antonio Segni 2 anni e 6 mesi (1951-1954)
9° Guido Bodrato 2 anni e 1 mese (1980-1982)
10°Giovanni Galloni 2 anni (1987-1989)
A livello politico si contano sulle dita di una mano le “riunioni di maggioranza” formalmente convocate per concordare le linee dell’azione governativa e quella dei gruppi parlamentari sui principali temi della politica scolastica, tanto che alcuni dei responsabili scuola dei partiti (Valditara per AN, Brocca per l’UDC, e perfino Mario Mauro per Forza Italia) hanno più volte preso le distanze, o apertamente criticato, alcune scelte che maturavano a livello governativo: si ricorda, per esempio, la bocciatura del primo progetto di riforma, con i licei quadriennali, presentato in occasione dei cosiddetti “Stati generali” della scuola (dicembre 2001), e le forti richieste di inserire gli istituti tecnici nell’area liceale, in forma di licei “vocazionali”.
Anche a livello sindacale la Moratti si è sempre mostrata selettiva e riservata, per nulla disponibile agli interminabili “confronti” di altri tempi e ministri. Alla fine le sue mediazioni e concessioni ha finito per farle. Però facendole un po’ calare dall’alto, o con brusche accelerazioni e conclusioni improvvise, che ne hanno accentuato il “look” decisionista e giustificato, almeno dal punto di vista comportamentale, l’accostamento alla figura di Margaret Thatcher.
Ma Letizia non è Margaret
Sul piano sostanziale, però, un confronto tra Letizia Moratti e Margaret Thatcher è del tutto improponibile. Intanto perché la Thatcher, prima di assumere la leadership dei conservatori e del governo inglese (1978), aveva già accumulato una consistente esperienza politica e anche governativa (era stata ministro dell’Educazione in un governo Heath), mentre la Moratti è nata, ed è rimasta, un ministro eminentemente “tecnico”. E poi, e soprattutto, perché la portata innovativa della riforma della scuola avviata dalla Thatcher (non parliamo in questa sede di università e di ricerca) è stata di gran lunga superiore a quella che può, o meglio potrebbe, derivare dalla riforma Moratti, anche se portata a compimento in tutte le sue parti.
Per avere conseguenze paragonabili per rilevanza (non, ovviamente, per contenuti) a quelle verificatesi in Gran Bretagna con l’introduzione del National Curriculum e delle altre riforme realizzate a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, la riforma Moratti avrebbe dovuto avere almeno alcune delle seguenti caratteristiche:
– assicurare una effettiva pari dignità socio-culturale e consistenza organizzativa all’istruzione liceale e a quella tecnico-professionale (almeno 50 e 50%, con un solo liceo economico e un solo liceo tecnologico);
– definire in forma standardizzata, riferita alle prestazioni degli allievi, i risultati attesi a conclusione dei diversi cicli e percorsi, liberalizzando le modalità organizzative e didattiche, rimesse all’autonomia delle scuole;
– prevedere esami finali da parte di commissioni esclusivamente esterne;
– sviluppare l’autonomia delle scuole statali fino al punto di consentire a ciascuna di esse (o almeno a un campione significativo di esse) di reclutare i docenti, il dirigente scolastico e quello amministrativo;
– ridefinire lo stato giuridico dei docenti prevedendone l’articolazione tra diverse figure a professionalità (e retribuzione) progressivamente arricchita nel corso della carriera;
– promuovere un robusto sistema nazionale di valutazione indipendente, sul modello ISTAT;
– creare un grande e ramificato servizio ispettivo a sostegno dell’innovazione, indipendente dal potere burocratico.
Per la verità, va anche detto che la Thatcher realizzò le sue riforme non da ministro dell’educazione ma da premier, e dopo un certo numero di anni. Ma Letizia Moratti, conclusa l’esperienza governativa, sembra avviata a fare scelte diverse, che non le offriranno l’opportunità di tornare ad occuparsi di riforme scolastiche (sempre che non diventi premier, back from Milan…).
La valutazione complessiva della sua attività, pertanto, non può che coincidere largamente, per quanto riguarda la scuola, con quella della legge n. 53 e dei suoi strumenti applicativi.
Tra accelerazioni e mediazioni
Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri degli ultimi due decreti legislativi (n. 226 e 227, 17 ottobre 2005, sul filo di lana della scadenza della delega), Letizia Moratti ha comunque portato a termine un’impresa straordinaria, mai riuscita finora ad un ministro dell’istruzione italiano in età repubblicana (con l’eccezione di Luigi Berlinguer, la cui riforma rimase però sulla carta): quella di riordinare complessivamente l’intero sistema scolastico e formativo del nostro Paese, dalla scuola dell’infanzia ai licei, passando anche per la riforma della formazione professionale iniziale.
Detto questo, si deve anche registrare il fatto che l’impresa ha comportato una serie di mediazioni e di aggiustamenti, rispetto alla forte discontinuità del progetto iniziale, e che il cantiere della riforma resterà aperto ancora a lungo: le norme sul primo ciclo, sul sistema di valutazione e sul prolungamento a 12 anni del diritto-dovere di istruzione e formazione, già operative, richiedono un non breve periodo di assestamento; quelle sull’alternanza scuola-lavoro e sulla formazione dei docenti hanno bisogno di essere sperimentate e ulteriormente testate; quelle sul secondo ciclo infine sono per ora solo virtuali, perché entreranno in vigore non prima del 2007-2008, e richiederanno una vasta concertazione tra lo Stato e le Regioni, titolari dal 2001 – a prescindere dunque dalla “devolution” – non solo del “sistema di istruzione e formazione” (sul quale hanno competenza esclusiva) ma anche della programmazione dell’intera offerta formativa.
Come prima accennato, il cantiere è in piena attività, ma mentre i lavori riguardanti il primo ciclo e altri aspetti della riforma sono a buon punto, altrettanto non si può dire per il secondo ciclo che il ministro ha dovuto in pratica riprogettare rispetto al modello prefigurato nella legge: lo dimostra, in particolare, il progressivo processo di ricostituzione di una ben precisa e visibile area tecnica (o “vocazionale”, un anglicismo che significa letteralmente “professionale”) all’interno del sistema di istruzione, approdato ad un esito che un anno fa – all’inizio del confronto sulla struttura e sui contenuti degli otto licei previsti dalla legge n. 53/2003 – sarebbe stato imprevedibile.
I DECRETI LEGISLATIVI DELLA LEGGE N. 53
D. Lgs. n. 59/2004 – Norme generali sull’attuazione del primo ciclo
D. Lgs. n. 286/2004 – Norme generali sul sistema nazionale di valutazione
D. Lgs. n. 76/2005 – Norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
D. Lgs. n. 77/2005 – Norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro
D. Lgs. n. 226/2005 – Norme generali sull’attuazione del secondo ciclo e sui livelli essenziali delle prestazioni del sistema educativo di istruzione e formazione
D. Lgs. n. 227/2005 – Norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento
Da una prima ipotesi (ottobre 2004) che contemplava in pratica la non articolazione in indirizzi del liceo tecnologico (e anche di quello economico), in nome della piena e compiuta licealizzazione di questi percorsi, si è passati a un modello intermedio (maggio 2005) che prevedeva per il liceo tecnologico otto indirizzi, con un’area di discipline tecniche specifiche di 330-363 ore annue nel triennio, per poi passare, nell’ultima e definitiva versione (ottobre 2005), a nove indirizzi (è stato aggiunto quello grafico, inserito all’interno del liceo informatico e della comunicazione), con un eclatante incremento dell’area tecnica, salita fino a 561 ore annue. E senza quelle alternative opzionali che comparivano nella versione intermedia, e che la rendevano più flessibile e personalizzabile. In questo modo, vista l’ampiezza dell’area “vocazionale” all’interno del sistema liceale, si ha l’impressione che la partita della interpretazione della legge si sia conclusa con una soluzione sostanzialmente continuistica, e che per il “sistema di istruzione e formazione” rimanga uno spazio residuale, non molto diverso, nella quantità e nella qualità, da quello occupato dalla ex formazione professionale regionale.
Sul destino della legge peserà molto l’esito delle prossime elezioni politiche, perché una parte dell’attuale opposizione chiede a gran voce che tutta la legge n. 53 sia “abrogata”, sic et simpliciter. A nostro avviso, anche in caso di successo dell’Unione, sarebbe tuttavia di fatto impossibile “azzerare” le parti della riforma già attuate, a partire da quelle relative al primo ciclo, e non sarebbe facile neppure rimettere radicalmente in discussione l’architettura del secondo ciclo, che per molti aspetti – compresa la struttura dei futuri licei, a partire dagli indirizzi tecnologici ed economici – è poco innovativa ma anche molto realista, e non è lontana dal modello “unitario” cui si ispirava la legge n. 30/2000, la riforma Berlinguer-De Mauro.
A noi sembra in ogni caso che si debba guardare al futuro partendo dal presente e dalle sue complessità. Quindi dal cantiere Moratti, qualunque sia l’esito della consultazione politica. Costruire sulle macerie è molto più difficile che completare ed eventualmente ristrutturare un edificio che ha comunque una sua solidità, testimoniata anche dalla vitalità della “scuola reale”, dalla sua disponibilità all’innovazione. Se si vuole seriamente investire nella e sulla scuola, la prima regola sarà quella di non sprecare risorse, magari per disfare ciò che altri hanno fatto. Per fortuna, sembra che questa considerazione di fondo sia ampiamente condivisa, al di là delle ricorrenti ma contingenti polemiche politiche.
Chi vuole la “sriforma”?
C’è tuttavia, anche nell’ambito dell’attuale maggioranza (Forza Italia), e perfino all’interno della stessa compagine ministeriale (sottosegretario Aprea), chi ritiene che il tasso di innovatività della riforma sia stato eccessivamente sacrificato in sede di adozione degli strumenti di attuazione della legge. Questa sembra essere anche la valutazione Giuseppe Bertagna, a lungo considerato dai media il “padre” della legge n. 53 (ma a chiamarlo così, lui si arrabbia…), secondo il quale non di riforma ma addirittura di sriforma si dovrebbe parlare se in sede di applicazione della legge n. 53 finisse per non trovare spazio la costruzione, in termini paritari e competitivi con i licei, del “sistema di istruzione e formazione”.
Un compito che spetta alle Regioni, sottolinea il corsivo che introduce una ampia sezione del numero 3/2005 del mensile “Nuova Secondaria” dedicata alla riforma. Sottolineatura alquanto maliziosa, verrebbe da dire, perché scaricherebbe sulle Regioni, in grande maggioranza governate dal centro-sinistra dopo le ultime elezioni regionali, la responsabilità del fallimento della riforma nel suo punto più difficile e qualificante, quello della costruzione di due “sistemi” di pari dignità in uscita dal primo ciclo.
I LICEI DELL’AREA “VOCAZIONALE” – MODELLI A CONFRONTO
Legge n. 30/2000
(Berlinguer)
Ipotesi iniziale
(2003-2004)
Confindustria/AN
(fine 2004)
Decreto legislativo 226
17 ottobre 2005
Liceo tecnico e tecnologico
Indirizzo gestione e servizi per la produzione di beni Liceo tecnologico Liceo tecnologico
Indirizzo elettronica, meccanica e automazione Liceo tecnologico:
Indirizzo meccanico-meccatronico
Ind. gestione e servizi per l’economia Liceo economico Ind. energia e impianti Ind. elettrico-elettronico
Ind. gestione e servizi per l’ambiente e il territorio Ind. informatica e comunicazione Ind. informatico, grafico e della comunicazione (con 2 percorsi)
Ind. gestione e servizi per le risorse naturali ed agro-ambientali Ind. Chimica, biologia Ind. chimico e materiali
Ind. gestione e servizi alla persona e alla collettività Ind. tessile, moda, calzature ed accessori Ind. tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda
Ind. gestione e servizi relativi al turismo Ind. risorse agroalimentari ed ambientali Ind. produzioni biologiche e biotecnologie alimentari
Ind. edilizia e territorio Ind. costruzioni, ambiente e territorio
Ind. trasporti, intermodalità e logistica Ind. logistica e trasporti
Liceo Economico
Ind. amministrazione e controllo Liceo economico
Ind. economico aziendale
Ind. comunicazione e marketing Ind. economico-istituzionale
Ind. gestione e servizi per il turismo
Ma si sa (Bertagna lo sa) che proprio nella contestazione di questo punto – e non sul primo ciclo o su altri aspetti della riforma – il pur litigioso centro-sinistra trova il suo momento di massima convergenza. In negativo. E dunque la sfida che la rivista di Bertagna lancia alle Regioni assume in sostanza la forma di un interrogativo retorico: “sapranno (le Regioni) raccogliere la sfida di costituire un sistema dell’istruzione e formazione professionale di pari dignità e interconnesso con il sistema dei licei e non semplicemente residuale?” Se le Regioni si sottrarranno a questo compito, avverte Bertagna, la prospettiva per il Paese sarà quella di andare verso un gran numero di licei “bulimici”, cui si affiancherà un sistema di istruzione e formazione “anoressico”, formato in pratica dagli attuali corsi sperimentali triennali e quadriennali. “Ma in questo caso sarà una sriforma più che una riforma”. La fonte di questo giudizio è autorevole, ma forse non tiene conto del fatto che l’insieme delle Regioni non è apparso complessivamente né interessato (anche per ragioni politiche) né preparato a gestire in termini davvero competitivi il sistema di istruzione e formazione, e che ciò ha favorito il compattamento in capo al sistema liceale di quasi tutta l’attuale istruzione secondaria superiore, con un singolare effetto di ritorno al modello panlicealista che caratterizzava la legge n. 30/2000 (Berlinguer), pur abrogata dalla riforma Moratti.
Il nodo del personale: Letizia non è Gordio. Però…
Il metodo sarà stato autocratico e decisionista, l’atteggiamento nei rapporti umani, specialmente con i sindacati, freddo e distante, l’approccio ai problemi fin troppo managerial-tecnocratico, ma non si può dire che Letizia Moratti non abbia provato ad affrontare alcuni dei nodi strutturali che da sempre (da quando si fanno le valutazioni comparative internazionali) caratterizzano il nostro sistema scolastico. Soprattutto uno: il doppio squilibrio derivante dalla sovrabbondanza di personale docente e non docente, a parità di allievi, da una parte, e dall’appiattimento verso il basso della condizione professionale e retributiva dello stesso personale dall’altra.
Questa situazione perdura da tempo in Italia, e finora nessun governo è riuscito ad affrontarla con successo, come ha dovuto constatare a sue spese l’ex ministro Berlinguer, che pure si era procurato un vasto, anche se labile, consenso preventivo dei sindacati alla effettuazione di un concorso meritocratico che avrebbe premiato il 20% dei docenti.
Non ha torto quindi Letizia Moratti a protestare con quei giornali – soprattutto la “Repubblica” ma anche il “Corriere della Sera”, ai quali ha inviato lettere di puntigliose precisazioni – che hanno riproposto dati recenti (però riferiti al 2003) e anche meno recenti, che ignorano lo sforzo da lei intrapreso in questi anni per migliorare la situazione, dal miglioramento della percentuale dei giovani diplomati (80% nella fascia 18-24 anni: cinque anni fa era il 70%) all’incremento della spesa per la scuola statale (+ 13%, con aumenti di 274 euro mensili per gli stipendi negli ultimi 4 anni), dall’ingresso in ruolo di 130.000 nuovi insegnanti, che ha svecchiato l’età media dei docenti, al miglioramento del rapporto docenti allievi rispetto alla situazione di 1 a 10 del 2001 (ultimo dato OCSE), derivante dagli “interventi di razionalizzazione” tanto criticati a livello politico e sindacale (ma su questo dato la Moratti non entra in dettagli).
Al di là delle polemiche e delle strumentalizzazioni, ci sembra di poter dire che il quadro generale della nostra scuola, almeno a livello macroscopico e macroeconomico, sia comunque un po’ migliorato in questi anni, con fatica e contraddizioni, anche a seguito della caparbia iniziativa di Letizia Moratti. Ma solo un po’. E pagando lo scotto di un ulteriore arretramento nelle classifiche comparative internazionali, dovuto al ritardo non tanto della riforma in generale quanto di specifiche misure mirate al miglioramento del rapporto insegnamento/apprendimento ai diversi livelli. Certo è che nessun futuro governo, qualunque sia l’esito delle prossime elezioni, potrà permettersi di eludere le molte sfide che attendono la scuola italiana sul piano della sua efficacia-efficienza e su quello della qualità dei risultati.
N.B BOX DA INSERIRE A PAG. 20 E 24
MORATTI DA EMENDARE
Fiorella Farinelli, responsabile scuola della Margherita
“L’ordinamento è importante, ma non è tutto. E’ anche per questo che non siamo d’accordo con chi chiede l’abrogazione della legge Moratti. Non solo perché sarebbe irresponsabile stressare ulteriormente il nostro sistema educativo con ulteriori attese messianiche e relative tensioni. Ma soprattutto perché un pensiero riformista deve dimettere l’idea inguaribilmente vecchia secondo cui le politiche dipendono esclusivamente da una ridefinizione complessiva, organica, definiva dell’ordinamento. Le politiche sono processi, che muovono da più parti (in questo caso dall’autonomia scolastica, dalle Regioni e dagli Enti locali, dai rapporti tra sistemi e attori sociali, economici, culturali), che hanno bisogno di verifiche e aggiustamenti in itinere, e che perciò preferiscono sistemi regolati sì sulla base di standard e di criteri nazionali, ma flessibili, declinabili sulle esigenze della domanda e ancorati al territorio, che possono, sulla base di verifiche scientifiche dei risultati e della concertazione tra gli attori, essere riadattati e rinnovanti in itinere”.
Andrea Ranieri, responsabile scuola dei DS
“Il nostro progetto di scuola è alternativo a quello del centro-destra, ma noi dell’Unione, se vinceremo, non intendiamo perseguirlo a colpi di maggioranza. Apriremo un dibattito che coinvolga tutti, a differenza di quanto ha fatto la Casa delle Libertà. Scuola e università non possono vedere messo in discussione il loro futuro a ogni cambio di maggioranza.
Io non sono affatto convinto che lo strumento di una legge, come fu anche la riforma Berlinguer-De Mauro, sia il migliore. Penso invece a una serie di interventi mirati, semplici e efficaci, capaci di scardinare alla base la logica della riforma voluta dalla Moratti. Sarebbe anche un modo per evitare di rimettere tutto in discussione”.
MORATTI DA ABROGARE
Movimento “Fermiamo la Moratti” – Comitato di Firenze
“Il punto di partenza per una politica scolastica alternativa a quella dell’attuale governo deve essere chiaro; deve essere una legge di un solo articolo: ‘la legge n. 53/00 ed i decreti attuativi sono abrogati’ “.
Proposta di disegno di legge per l’abrogazione delle leggi Moratti
“ART. 1
1 – La Legge 28 marzo 2003 n°53, con eccezione dell’art. 7, comma 12 (comma che dispone l’abrogazione della legge n. 30/2000, nrd), ed i relativi decreti attuativi sono abrogati.
2 – Nella prospettiva del riordino dell’ordinamento scolastico, per effetto dell’abrogazione di cui al precedente comma hanno efficacia tutte le disposizioni del D.Lgs 16 Aprile 1994 n°297, abrogate dalla 10 febbraio 2000 n. 30 e dalla Legge. 28 marzo 2003 n°53 e dai decreti legislativi di cui al precedente comma.
3 – L’obbligo scolastico di cui all’art. 34 Cost. si realizza esclusivamente nelle istituzioni scolastiche ed a partire dall’anno scolastico 2006-2007 e comunque entro l’anno scolastico 2010-2011 è gradualmente elevato fino a 18 anni di età.
ART. 2
Gli oneri derivanti dal precedente articolo sono coperti con la corrispondente riduzione delle spese militari previste nel relativo capitolo di bilancio.
ART. 3
La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.



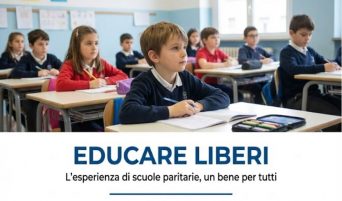
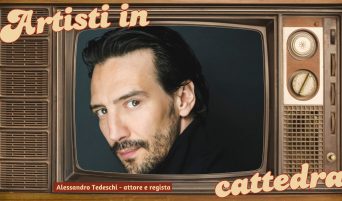
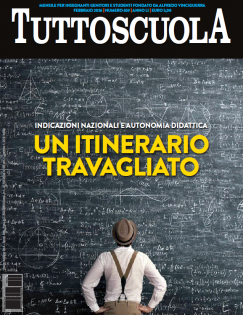




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via