
Recensione. Matricola 623. L’ambiente scolastico dell’adolescente Maria Montessori

di Gianni Russo e Marianna Russo
Cosa succede se, invece di guardare a Maria Montessori come alla pedagogista già consacrata, la osserviamo da adolescente, tra i banchi di scuola, immersa nella Roma postunitaria che stava costruendo una nuova identità culturale e politica? È questa la domanda di fondo che attraversa il volume Matricola 623, firmato da Gianni e Marianna Russo, secondo titolo della collana Proposte e ricerche della Fondazione Chiaravalle Montessori.
L’idea di fondo è semplice ma potentissima: tornare agli archivi. Non tanto per inseguire il pettegolezzo delle pagelle o il voto di matematica della futura pedagogista, quanto per restituire spessore e voce a un contesto che, altrimenti, rischierebbe di svanire nella polvere delle biblioteche. Da vecchi registri, relazioni ministeriali e annuari scolastici riemerge così un mondo fatto di docenti autorevoli, regole scolastiche minuziose, fermenti culturali e dibattiti politici che segnarono la formazione di un’intera generazione.
Il libro è anche un viaggio nella Roma dopo il 1870, quando la città, divenuta da poco capitale del Regno d’Italia, si confrontava con sfide urbanistiche, sociali e culturali di portata enorme. La scuola diventa il laboratorio di questo cambiamento: nascono istituti femminili professionali, si aprono nuove scuole tecniche, cresce la presenza ebraica nei banchi e nelle cattedre, in un clima di modernizzazione contrapposto a resistenze conservatrici.
Il Regio Istituto Tecnico, dove Maria Montessori studia tra il 1886 e il 1890, appare come una fucina di esperimenti didattici, a metà strada tra il modello tedesco della Realschule e le aspirazioni italiane a un’istruzione che sappia dialogare con il mercato del lavoro.
Il vero colpo di teatro del volume è l’attenzione agli adulti che Maria incontrò e ai suoi compagni di classe. Non solo i professori, di cui vengono ricostruite biografie e orientamenti, ma anche figure istituzionali come Guido e Augusto Baccelli, protagonisti della politica scolastica nazionale. È un affresco corale che mostra come il destino della giovane Montessori non si sia giocato in solitudine, ma dentro una rete di relazioni dense di stimoli e contraddizioni.
Anche i compagni di scuola diventano personaggi di una storia collettiva: le loro carriere, le loro scelte, i loro intrecci con i grandi eventi del tempo restituiscono l’immagine di un ambiente formativo vivo, complesso, ricco di incroci inattesi.
Ma il libro non si ferma alla cronaca storica. In più punti, gli autori dialogano con i testi montessoriani sull’adolescenza, ricollegando quelle pagine di archivio alla riflessione pedagogica più matura. Ne emerge l’idea dell’adolescenza come “età delle rivelazioni interiori”, una fase fragile ma costruttiva, in cui l’ambiente scolastico può fare la differenza tra dispersione e crescita armoniosa.
Non è un caso che, parafrasando Augusto Scocchera, venga ribadita la necessità di garantire agli adolescenti un contesto “liberante e costruttivo”, capace di sostenere la crisi senza reprimerla. Il richiamo al presente è implicito ma forte: la scuola di oggi, spesso in difficoltà nell’ascoltare i ragazzi, può trarre da queste pagine un invito a ripensarsi come spazio di fiducia e di responsabilità condivisa.
Lo stile del libro alterna rigore e vivacità. Alla precisione delle fonti si accompagna la volontà di raccontare, di rendere accessibile al lettore un patrimonio documentale che non è più solo “burocratico elenco di nomi”, ma tessuto vivo di storie. È questo il vero valore aggiunto: Matricola 623 non è soltanto un saggio di storia dell’educazione, ma anche una narrazione capace di emozionare, mostrando la giovane Maria Montessori come parte di un mondo concreto, quotidiano, fatto di regole severe, passeggiate didattiche, compagni e maestri con cui confrontarsi.
Un tratto distintivo del libro è l’attenzione al contesto politico-sociale della Roma postunitaria, descritta come città popolata da “ferventi massoni ed ebrei illuminati”, in contrasto con le resistenze reazionarie ancora legate all’ombra del potere papale.
Non è un dettaglio folkloristico: la presenza di logge massoniche, di intellettuali ebrei emancipati e di circoli laici modernisti costituì il terreno fertile su cui maturò l’apertura culturale di cui Maria Montessori sarebbe stata erede. In quel crocevia, la scuola diventava non solo luogo di istruzione tecnica, ma anche laboratorio di laicità e di modernizzazione, in opposizione a una visione confessionale e conservatrice dell’educazione.
La massoneria, con il suo impegno nella costruzione di una scuola pubblica, gratuita e moderna, appare qui come sfondo silenzioso ma determinante. Un dato che rende più comprensibile la spinta della giovane Montessori verso una pedagogia emancipatrice, attenta all’autonomia del bambino e, in prospettiva, alla libertà della donna.
La narrazione si arricchisce ulteriormente se letta in controluce con il successivo periodo fascista. Anche se il libro si concentra sugli anni giovanili di Maria, le pagine dedicate al contesto mostrano già la fragilità di un equilibrio che di lì a qualche decennio sarebbe stato travolto.
Il fascismo, infatti, non poté tollerare fino in fondo un metodo educativo fondato sulla libertà e sulla responsabilità individuale. Se da un lato Mussolini inaugurò scuole montessoriane e le sostenne per ragioni di prestigio internazionale, dall’altro il regime impose disciplina, gerarchia, obbedienza: principi inconciliabili con la pedagogia montessoriana. Non a caso, dal 1934, il metodo fu progressivamente emarginato in Italia, e solo nel dopoguerra ritrovò spazio nelle istituzioni scolastiche.
Il contrasto tra l’ambiente laico-progressista in cui la giovane Montessori si formò e il clima autoritario imposto dal regime fascista segna uno spartiacque che aiuta a leggere la sua opera in prospettiva: pedagogia della libertà da una parte, educazione all’obbedienza dall’altra.
Il pregio del libro sta nell’unire storia minuta e grandi processi: le regole scolastiche dell’epoca, le statistiche di frequenza femminile alle università, le biografie dei professori, ma anche il respiro largo di un’epoca segnata da massoneria, modernizzazione, emancipazione femminile e, più tardi, repressione fascista.
Matricola 623 non è dunque soltanto un contributo storiografico, ma anche una lente che permette di osservare come l’ambiente sociale e politico lasci tracce indelebili nelle traiettorie individuali.
Il volume lascia al lettore la sensazione di aver aperto una porta. Non chiude, non esaurisce: invita a continuare, a scavare ancora negli archivi, a interrogare nuove fonti, a ripensare la biografia di Montessori come storia collettiva di una generazione.
È, in definitiva, un libro che unisce passato e presente. Al tempo stesso ricerca storica e riflessione pedagogica, omaggio alla scuola di ieri e invito a prendersi cura di quella di oggi.
Un tassello prezioso, dunque, non solo per gli studiosi montessoriani, ma per insegnanti, genitori e lettori curiosi che vogliano capire da dove nasce – anche attraverso un’adolescenza concreta, tra compiti, regole e sogni – la forza rivoluzionaria del pensiero di Maria Montessori.
Il lettore chiude il volume con la sensazione di aver conosciuto una Maria Montessori nuova: non più icona immobile della pedagogia, ma adolescente immersa in un mondo complesso, fatto di modernità e resistenze, di aperture e chiusure, di libertà cercate e libertà negate.
E soprattutto con la consapevolezza che la scuola – allora come oggi – è il campo in cui si gioca la partita tra emancipazione e autoritarismo, tra autonomia e disciplina cieca. Una lezione che attraversa i secoli e che rende questo libro non solo interessante, ma necessario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA








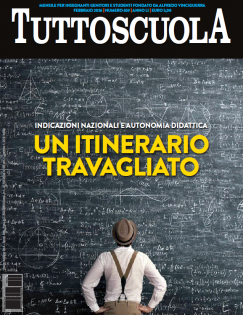




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via