
Nuove linee guida per l’Educazione Civica: punti di forza e criticità

di Franca Da Re
Con il Decreto n. 183 del 7 settembre 2024, il Ministro per l’Istruzione e il Merito ha emanato le nuove Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, che sostituiscono quelle emanate con il D.M. n. 35 del 2020.
Le Linee Guida entrano in vigore con l’a.s. 2024/25 e assolvono al dettato della Legge 92/19, che prescriveva al Ministero di fornire alle scuole “specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento” (art. 3, comma 1).
Come si ricorderà, il D.M. 35, non senza qualche contraddizione, non intendeva indicare traguardi e obiettivi nazionali per l’educazione civica, lasciando transitoriamente tale onere alle scuole.
Nuove linee guida per l’Educazione Civica: punti di forza
Le Linee guida del 7 settembre prevedono dodici traguardi per il primo ciclo che sono sostanzialmente ripresi con analoghe o simili formulazioni nelle dodici competenze generali per il secondo ciclo di istruzione. I traguardi e le competenze generali sono distribuiti nei tre nuclei:
- Costituzione (quattro traguardi/competenze);
- Sviluppo economico e sostenibilità (cinque traguardi/competenze);
- Cittadinanza digitale (tre traguardi/competenze).
Ciascuno dei traguardi/competenze è declinato in obiettivi specifici di apprendimento per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e per il secondo ciclo di istruzione. C’è lo sforzo di indicare obiettivi operativi e concreti, pur con qualche cedimento a formulazioni vaghe, non osservabili, più adatte ai traguardi e alle competenze generali. In più di un’occasione, specie per la scuola secondaria di primo e secondo grado, vengono indicati non singoli, ma gruppi di obiettivi differenti, anche se appartenenti al medesimo ambito concettuale. Nella Premessa si specifica, opportunamente, che negli obiettivi di apprendimento sono contenute conoscenze e abilità che gli alunni dovrebbero conseguire e maturare nel tempo. Sono presenti molti obiettivi di conoscenza (“Conoscere…”) anche se si rintraccia lo sforzo di unire le abilità di spiegare i fenomeni, contestualizzarli nell’esperienza, individuare comportamenti coerenti.
La scelta di prevedere le stesse o simili formulazioni nei traguardi per il primo ciclo e nelle competenze per il secondo ci sembra assai opportuna e feconda, nella prospettiva evolutiva a lungo termine che è propria della competenza come dimensione della persona che apprende lungo tutto l’arco della vita.
Nella Premessa, a nostro parere, sono molto apprezzabili i richiami alla trasversalità dell’insegnamento e l’impegno che tutti i docenti devono riservare nel suo sviluppo, anche nei casi – solo nel secondo ciclo – in cui la titolarità sia affidata al docente di materie giuridiche ed economiche. Coerente con tutto ciò, appare l’orientamento a pianificare percorsi didattici condivisi che vedano l’apporto di più discipline per approfondire questioni e problemi e a considerare come in tutto il curricolo sia possibile sempre reperire concetti e questioni di rilevanza civica.
A proposito di contitolarità, le nuove linee guida, come le precedenti, affidano l’insegnamento a tutti i docenti del team/consiglio di classe; solo nelle classi del secondo ciclo dove sia presente nel quadro orario l’insegnamento di discipline giuridico-economiche la titolarità è affidata al docente delle stesse, pur essendo impegnato tutto il consiglio di classe, come si diceva, a condividere l’insegnamento dell’educazione civica.
A proposito di valutazione, si ponga l’attenzione che le linee guida specificano che il coordinatore dell’insegnamento propone, in sede di scrutinio, la valutazione da assegnare all’educazione civica secondo la normativa vigente nei diversi gradi, dopo avere raccolto dai tutti i colleghi “elementi conoscitivi”. In nessun caso si parla di voti o livelli da assegnare in itinere e da consegnare al coordinatore, ma in altro passaggio si menziona l’utilizzo di “strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione”, che maggiormente si prestano a riscontri di tipo descrittivo.
Le indicazioni metodologiche sono opportunamente orientate ad una didattica che valorizzi riflessione, esperienze contestualizzate nella realtà, laboratori, progetti di servizio e di impegno nella comunità. Sono le metodologie più efficaci per affrontare questioni educative, in particolare se si tratta di educazione civica.
Molto apprezzabile anche il paragrafo riservato alle attività nella scuola dell’infanzia, saldamente ancorato alle Indicazioni Nazionali e alle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui al D.M. n. 334 del 22.11.2021.
Nuove linee guida per l’Educazione Civica: elementi di criticità
Nel testo delle Linee guida sono presenti alcuni passaggi che a nostro avviso rappresentano aspetti critici da trattare con attenzione nella didattica, per non trascurarne le complessità intrinseche. Anche sotto l’aspetto tecnico e formale vi sono degli enunciati che sarebbe opportuno migliorare.
Il secondo nucleo è quello che contiene quelli che, ai nostri occhi, rappresentano aspetti critici, a partire dalla denominazione: Sviluppo economico e sostenibilità. L’Agenda 2030 sulla sostenibilità viene nominata solo in una piccola nota a piè di pagina. A noi pare di ravvisare che la sostenibilità sia in qualche modo subalterna rispetto allo sviluppo economico. È vero che si afferma che esso deve essere rispettoso della sicurezza, dell’equità, della salute, dell’ambiente, ecc., ma tutto lo sviluppo del nucleo, in diversi obiettivi, lasciano intendere una certa gerarchia dei due concetti, a vantaggio dell’economia. Bisogna, tuttavia, ricordare che i rischi ambientali e climatici rappresentano costi economici sempre più rilevanti e si tradurranno presto comunque in costi sociali e umani altrettanto importanti. Non è più questione di scegliere tra sviluppo economico e sostenibilità, ma semplicemente operare per uno sviluppo che sia sostenibile. L’Agenda 2030 parla di sostenibilità come ambientale, sociale ed economica, considerando i tre aspetti come inscindibili e compenetrati. La mancanza di sostenibilità ambientale si traduce in dissesti sociali e in costi economici, a livello locale e globale. Negli obiettivi del primo e secondo ciclo si parla in più passaggi di conoscere lo sviluppo economico nazionale ed europeo, di conoscere le conseguenze della crescita economica ai fini del miglioramento della vita e della lotta alla povertà. È innegabile che lo sviluppo economico e tecnologico hanno determinato miglioramenti nella salute, nell’istruzione, nel tenore di vita delle popolazioni, ma bisogna avere cura, specie nelle scuole del secondo ciclo, di esaminarne criticamente anche le storture a carico non solo dell’ambiente, ma anche in termini di diseguaglianze nella società e di sperequazioni planetarie, che tra l’altro influiscono, insieme ai dissesti climatici, nei flussi migratori. Peraltro, anche alcuni dissesti climatici sono aggravati da politiche di sfruttamento del suolo e dei mari che rispondono alle medesime logiche di sperequazione.
A proposito di educazione finanziaria, nella Premessa, tra le altre cose si legge: “L’educazione finanziaria va intesa inoltre come momento per valorizzare e tutelare il patrimonio privato.”
Tra gli obiettivi della Competenza n. 8 del secondo ciclo compaiono i seguenti:
“Riconoscere il valore dell’impresa individuale e incoraggiare l’iniziativa economica privata.
Conoscere le forme di accantonamento, investimento, risparmio e le funzioni degli istituti di credito e degli operatori finanziari. Amministrare le proprie risorse economiche nel rispetto di leggi e regole, tenendo conto delle opportunità e dei rischi delle diverse forme di investimento, anche al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio privato.
Individuare responsabilmente i propri bisogni e aspirazioni, in base alle proprie disponibilità economiche, stabilire priorità e pianificare le spese, attuando strategie e strumenti di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio.”
Consideriamo l’educazione finanziaria irrinunciabile proprio perché i cittadini possano tutelare se stessi e le proprie sostanze da truffe e speculazioni messe in atto anche da operatori finanziari. Riteniamo, però che essa sia altrettanto importante per educare all’etica pubblica, alla messa in atto di comportamenti economici etici ad ogni livello, proprio per contribuire, per quanto possibile, a ridurre il numero degli speculatori, degli avventurieri finanziari e dei truffatori. Non dimentichiamo che le crisi finanziarie a partire da quella del 2008 sono state spesso determinate da scarsa etica nell’esercizio dell’economia e della finanza. Non da ultimo, nell’etica pubblica, rientra sempre il dovere di contribuzione. Ci pare, insomma, che la questione dell’etica pubblica venga contemplata, ma resti sempre più in ombra rispetto all’interesse privato.
In merito al Traguardo n. 9, l’obiettivo per la scuola primaria recita:
“Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza. Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto. Conoscere il valore della legalità.”
Ci pare che con ragazzi tanto giovani, conoscere il valore della legalità si possa sviluppare solo a partire dall’esperienza diretta e quotidiana del valore del rispetto delle regole di convivenza nell’ambiente e nelle comunità di vita. Devono certamente essere sviluppate riflessioni su fatti di cronaca riguardo a eventi criminosi che fatalmente colpiranno l’interesse anche dei piccoli, ma l’educazione al comportamento corretto e rispettoso nella quotidianità come garanzia di una buona convivenza ci paiono scelte più oculate in questo grado di scuola. La maturazione fin da piccoli di condotte sempre corrette potrà contribuire a ridurre in età successive quei comportamenti di piccola e grande illegalità diffusa purtroppo presenti nelle nostre comunità. Una comunità tollerante verso le piccole illegalità è più vulnerabile, a nostro avviso, alle grandi illegalità.
In sintesi, le Linee Guida, a nostro parere, sono un testo che presenta aspetti condivisibili e buone potenzialità didattiche. Sugli aspetti che a nostro avviso presentano criticità, l’esercizio dell’approfondimento, dell’utilizzo critico delle fonti, della consultazione di esperti autorevoli, può aiutare a trasformare anche i rischi in opportunità.
Questo è solo un estratto delle riflessioni di Franca Da Re, uno dei tanti approfondimenti esclusivi che riserviamo ai nostri abbonati.
Puoi ottenere il documento integrale IN OMAGGIO
abbonandoti ai nostri servizi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

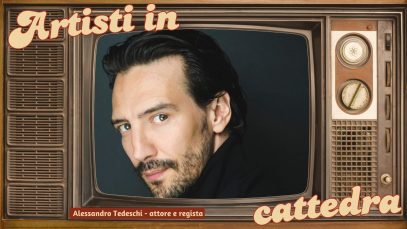
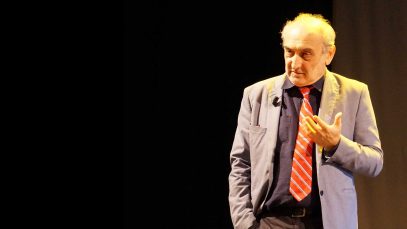
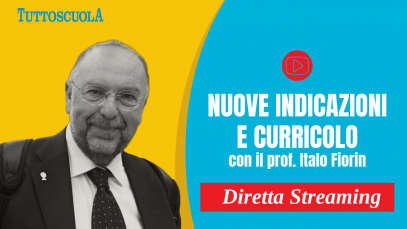




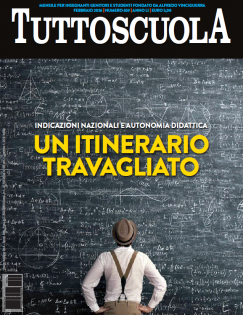




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via