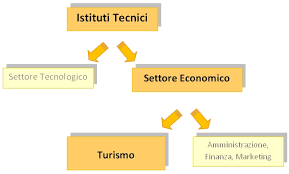
Liceo classico, e se fosse inserito tra i beni immateriali dell’umanità?
Ascrivere il liceo classico alla lista dei beni immateriali patrimonio dell’umanità. Come la pizza, secondo la recente proposta della commissione italiana dell’Unesco con il supporto di 200 mila firme. È stata questa una delle più evocative tra le proposte giunte nel corso del convegno dedicato a “Il futuro del liceo classico”, organizzato da Elena Centemero, responsabile Scuola e Università di Forza Italia, per sottrarre questo percorso di studi a un apparente futuro di declino.
E poi una richiesta pressante: cambiare la seconda prova dell’esame finale, affiancando alla traduzione un commento e un’analisi filologica e culturale.
All’introduzione della parlamentare di Forza Italia, di cui abbiamo dato conto nella precedente notizia, incentrata sugli obiettivi del convegno, la comprensione delle ragioni del declino del liceo classico e le vie possibile per ridargli vita, hanno fatto seguito gli interventi degli altri partecipanti.
Il direttore di Tuttoscuola Giovanni Vinciguerra, che ha moderato l’incontro, ha proposto come ipotesi di lavoro l’individuazione di due modelli di liceo classico, uno tradizionalista, e l’altro aperto a integrazioni e contaminazioni con le scienze sociali e quelle naturali: “Il secondo modello, quello per così dire integrato, presenta il vantaggio, rispetto al primo, di consentire un certo grado di flessibilità e personalizzazione dei piani di studio: valorizza maggiormente le inclinazioni e i talenti individuali. Ma si può dire che questa versione integrata del liceo classico ne rispetti davvero l’identità profonda? Quanto tempo e impegno vengono sottratti al blocco delle discipline umanistiche? È bene che questo accada? D’altra parte se si tornasse (o restasse, non esercitando alcuna opzione) al modello più tradizionale, si farebbe davvero l’interesse degli studenti? E’ proponibile oggi una scuola senza (o quasi senza) matematica e informatica? E senza una minima formazione di carattere economico e giuridico?”
Queste domande hanno aperto gli interventi dei relatori, il primo dei quali, Alessio Turazza, consulente di editoria scolastica, ha illustrato la tesi che, dai flussi delle iscrizioni nei percorsi liceali, fermo restando che il liceo scientifico “tiene”, è il liceo linguistico il percorso di studi che sta sottraendo studenti al liceo classico.
Il calo degli iscritti al liceo classico (al primo anno, dai 65mila del 2007 ai 31mila del 2014) si giustifica con una serie di percezioni errate su questo tipo di scuola: che sia poco concreta rispetto allo sforzo che richiede, che porti ragazzi più impreparati a un eventuale accesso a facoltà scientifiche, che risponda peggio di altre scuole alla crisi economica, che dia minori opportunità di accesso al mondo del lavoro.
In realtà, ha spiegato Turazza, dal punto di vista delle competenze, lo studio delle lingue classiche è un valore, specie se l’apprendimento si va ad incentrare, almeno nel biennio iniziale, più sullo studio degli elementi della civiltà classica che sulla grammatica.
Il liceo classico, ha concluso il consulente di editoria scolastica, fornisce un approccio vincente per il futuro, di sintesi e critica della realtà. ma deve aprire la didattica a nuove esperienze.
Paolo Corbucci, dirigente scolastico, della Direzione Generale Ordinamenti scolastici del MIUR, che ha portato il saluti del direttore generale Carmela Palumbo, ha insistito sugli elementi di presunta debolezza del liceo classico, e ha ricordato che nelle iscrizioni a questo percorso di studi, ci sono regioni che tengono (per esempio, Lazio e Calabria, che si attestano attorno al 10%), mentre in altre i numeri sono molto bassi (in Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, gli iscritti sono tra il 3% e 4%).
Corbucci – che ha annunciato un monitoraggio del Miur sulla scuola secondaria superiore a cinque anni dalla riforma – ha concluso l’intervento con diverse domande: fermo restando che la preoccupazione di molti docenti è “non riuscire a terminare il programma”, è necessario un riordino degli ordinamenti o basta semplicemente rifarsi con più attenzione alle Indicazioni Nazionali? E, fermo restando che il 5% dei liceali non si iscrive all’università (e nei 2-3 anni successivi, molte delle matricole abbandonano gli studi), come è possibile disegnare dei percorsi credibili di alternanza scuola-lavoro anche nei licei classici?
Carla Guetti della Direzione Generale Ordinamenti scolastici e Valutazione del Sistema nazionale d’Istruzione del MIUR, dopo aver portato i saluti di Luigi Berlinguer (con il quale ha scritto il recente volume “Ri-creazione. Una scuola di qualità per tutti e per ciascuno“), ha insistito sul tema della limitatezza della contrapposizione corrente tra sapere umanistico e sapere scientifico, all’interno di una società caratterizzata dalla mondializzazione dei saperi.
Vincenzo Di Rienzo, dirigente scolastico Liceo Classico Statale “Bartolomeo Zucchi” di Monza e coordinatore della rete www.reteliceimonzabrianza.it , ha difeso la tesi di un liceo classico che deve sapere stare al passo con i tempi: come è vero che ragazzi, diventati in media più alti, devono avere banchi più alti, anche i licei classici devono proporre esperienze pratiche, rinnovare lo statuto dei docenti, promuovere una formazione obbligatoria dei docenti che faccia parlare loro il linguaggio del XXI secolo.
Mario Bonini, dirigente scolastico Liceo Classico Statale “Enrico Medi” e “Scipione Maffei” di Verona, ha rappresentato lo sforzo del suo liceo di reinventarsi, nell’intento non di dare ai ragazzi teste piene, ma “teste ben fatte” (Montaigne). Secondo Bonini, è necessario riscrivere le Indicazioni Nazionali, rendendole meno rigide, e occorre scegliere la strada delle valutazioni “a canne d’organo”.
Bonini ha inoltre introdotto per primo un’idea, che ha avuto sviluppi molto fertili nel prosieguo del dibattito, di superare la forma della seconda prova scritta della maturità, evolvendola dalla riduttiva traduzione di un brano di latino o greco, verso il modello del “certamen” (caratterizzato sì da una traduzione, ma anche da un commento e un’analisi filologica e culturale del testo).
Patrizia Concetti ed Ernestina Monaco, docenti del Liceo Classico Statale “Torquato Tasso” di Roma, hanno raccontato delle brillanti esperienze di didattica laboratoriale teatrale nella loro scuola, che hanno condotto alla creazione di una compagnia teatrale stabile cui partecipano anche gli ex alunni.
Sofia Gallo De Maio e il prof. Rovinetti, rispettivamente dirigente scolastico e docente del Liceo Classico Statale “Luigi Galvani” di Bologna, hanno illustrato le attività specialmente di potenziamento linguistico, condotte nel loro istituto, che portano ogni anno decine di studenti ad ottenere la prestigiosa (e lavorativamente spendibile) certificazione Cambridge, con un notevole incremento nelle iscrizioni.
Graziano Stirpe e Francesco Pelargonio, rispettivamente docente e dirigente scolastico e docente del Liceo Classico Istituto Paritario “A. Ruiz” di Roma, hanno raccontato le esperienze di alternanza scuola-lavoro nella loro scuola.
Da ultimo, la prof.ssa Mariarosa Mortillaro, del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma, dopo avere ripreso il tema dei luoghi comuni attorno al liceo classico, la lanciato l’idea di ascrivere il liceo classico alla lista dei beni immateriali dell’umanità, intesa, come ha chiosato Vinciguerra nella moderazione conclusiva, come uno dei tanti esempi possibili “per non rassegnarsi al declino”.





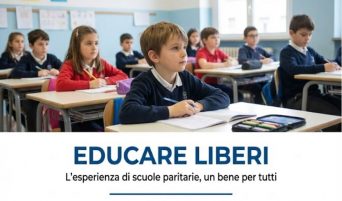
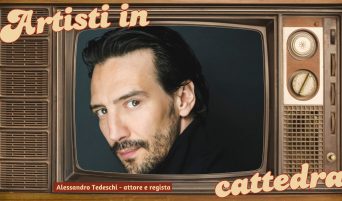
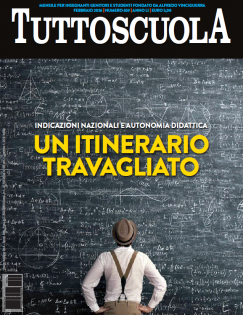




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via