
Tuttoscuola legge le ‘Favole al telefono’ di Rodari: gli audio da far ascoltare ai più piccoli. I disegni dei bambini

Durante il lockdown, milioni di studenti sono stati costretti a rimanere in casa. Per aiutare i genitori e, magari, anche qualche insegnante della scuola dell’Infanzia a organizzare dei momenti con i bambini a distanza, Tuttoscuola ha pensato in quell’occasione di realizzare delle audio fiabe da far ascoltare ai più piccoli. All’interno di questo articolo possiamo quindi ascoltare il nostro Sergio Govi leggere le “Favole al telefono” di Gianni Rodari.
Sfoglia i disegni che ci hanno mandato i bambini
Abbiamo aggiunto a questa raccolta anche la lettura del “Le Favolette di Alice” di Gianni Rodari, lette da Sergio Govi. Clicca qui per leggerle e ascoltarle
Ascolta le “Favole al telefono” di Gianni Rodari lette da Sergio Govi
Giacomo di cristallo
Ascolta la favola
Una volta, in una città lontana, venne al mondo un bambino trasparente. Attraverso le sue membra si poteva vedere come attraverso l’aria e l’acqua.
Era di carne e d’ossa e pareva di vetro, e se cadeva non andava in pezzi, ma al più si faceva sulla fronte un bernoccolo trasparente. Si vedeva il suo cuore battere, si vedevano i suoi pensieri guizzare come pesci colorati nella loro vasca. Una volta, per sbaglio, il bambino disse una bugia, e subito la gente poté vedere come una palla di fuoco dietro la sua fronte: ridisse la verità e la palla di fuoco si dissolse. Per tutto il resto della sua vita non disse più bugie.
Un’altra volta un amico gli confidò un segreto, e subito tutti videro come una palla nera che rotolava senza pace nel suo petto, e il segreto non fu più tale.
Il bambino crebbe, diventò un giovanotto, poi un uomo, e ognuno poteva leggere nei suoi pensieri e indovinare le sue risposte, quando gli faceva una domanda, prima che aprisse bocca.
Egli si chiamava Giacomo, ma la gente lo chiamava «Giacomo di cristallo», e gli voleva bene per la sua lealtà, e vicino a lui tutti diventavano gentili.
Purtroppo, in quel paese, salì al governo un feroce dittatore, e cominciò un periodo di prepotenze, di ingiustizie e di miseria per il popolo.
Chi osava protestare spariva senza lasciar traccia.
Chi si ribellava era fucilato.
I poveri erano perseguitati, umiliati e offesi in cento modi.
La gente taceva e subiva, per timore delle conseguenze.
Ma Giacomo non poteva tacere. Anche se non apriva bocca, i suoi pensieri parlavano per lui: egli era trasparente e tutti leggevano dietro la sua fronte pensieri di sdegno e di condanna per le ingiustizie e le violenze del tiranno.
Di nascosto, poi, la gente si ripeteva i pensieri di Giacomo e prendeva speranza.
Il tiranno fece arrestare Giacomo di cristallo e ordinò di gettarlo nella più buia prigione.
Ma allora successe una cosa straordinaria.
I muri della cella in cui Giacomo era stato rinchiuso diventarono trasparenti, e dopo di loro anche i muri del carcere, e infine anche le mura esterne.
La gente che passava accanto alla prigione vedeva Giacomo seduto sul suo sgabello, come se anche la prigione fosse di cristallo, e continuava a leggere i suoi pensieri.
Di notte la prigione spandeva intorno una grande luce e il tiranno nel suo palazzo faceva tirare tutte le tende per non vederla, ma non riusciva ugualmente a dormire.
Giacomo di cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è più forte di qualsiasi cosa, più luminosa del giorno, più terribile di un uragano.
Il Paese senza punta
Ascolta la favola
Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore.
Viaggia e viaggia, una volta capitò in un paese dove gli spigoli delle case erano rotondi, e i tetti non finivano a punta ma con una gobba dolcissima.
Lungo la strada correva una siepe di rose e a Giovannino venne lì per lì l’idea di infilarsene una all’occhiello.
Mentre coglieva la rosa faceva molta attenzione a non pungersi con le spine, ma si accorse subito che le spine non pungevano mica, non avevano punta e parevano di gomma, e facevano il solletico alla mano.
– Guarda, guarda, – disse Giovannino ad alta voce.
Di dietro la siepe si affacciò una guardia municipale, sorridendo.
– Non lo sapeva che è vietato cogliere le rose?
– Mi dispiace, non ci ho pensato.
– Allora pagherà soltanto mezza multa, – disse la guardia, che con quel sorriso avrebbe potuto benissimo essere l’omino di burro che portava Pinocchio al Paese dei Balocchi.
Giovannino osservò che la guardia scriveva la multa con una matita senza punta, e gli scappò di dire:
– Scusi, mi fa vedere la sua sciabola?
– Volentieri, – disse la guardia. E naturalmente nemmeno la sciabola aveva la punta.
– Ma che paese è questo? – domandò Giovannino.
– Il Paese senza punta, – rispose la guardia, con tanta gentilezza che le sue parole si dovrebbero scrivere tutte con la lettera maiuscola.
– E per i chiodi come fate?
– Li abbiamo aboliti da un pezzo, facciamo tutto con la colla. E adesso, per favore, mi dia due schiaffi.
Giovannino spalancò la bocca come se dovesse inghiottire una torta intera.
– Per carità, non voglio mica finire in prigione per oltraggio a pubblico ufficiale. I due schiaffi, semmai, dovrei riceverli, non darli.
– Ma qui usa così, – spiegò gentilmente la guardia, – per una multa intera quattro schiaffi, per mezza multa due soli.
– Alla guardia?
– Alla guardia.
– Ma è ingiusto, è terribile.
– Certo che è ingiusto, certo che è terribile, – disse la guardia. – La cosa è tanto odiosa che la gente, per non essere costretta a schiaffeggiare dei poveretti senza colpa, si guarda bene dal fare niente contro la legge. Su, mi dia quei due schiaffi, e un’altra volta stia più attento.
– Ma io non le voglio dare nemmeno un buffetto sulla guancia: le farò una carezza, invece.
– Quand’è così, – concluse la guardia, – dovrò riaccompagnarla alla frontiera.
E Giovannino, umiliatissimo, fu costretto ad abbandonare il Paese senza punta.
Ma ancor oggi sogna di poterci tornare, per viverci nel più gentile dei modi, in una bella casetta col tetto senza punta.
Il topo dei fumetti
Ascolta la favola
Un topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e desideroso di cambiare il sapore della carta con quello del formaggio, spiccò un bel salto e si trovò nel mondo dei topi di carne e d’ossa.
“Squash!” esclamò subito, sentendo odor di gatto.
“Come ha detto?” bisbigliarono gli altri topi, messi in soggezione da quella strana parola.
“Sploom, bang, gulp!” disse il topolino, che parlava solo la lingua dei fumetti.
“Dev’essere turco,” osservò un vecchio topo di bastimento, che prima di andare in pensione era stato in servizio nel Mediterraneo. E si provò a rivolgergli la parola in turco.
Il topolino lo guardò con meraviglia e disse: “Ziip, fiish, bronk”.
“Non è turco”, concluse il topo navigatore.
“Allora cos’è?”
“Vattelapesca”.
Così lo chiamarono Vattelapesca e lo tennero un po’ come lo scemo del villaggio.
“Vattelapesca”, gli domandavano, “ti piace di più il parmigiano o il groviera?”
“Spliiit, grong, ziziziir”, rispondeva il topo dei fumetti.
“Buona notte”, ridevano gli altri.
I più piccoli, poi, gli tiravano la coda apposta per sentirlo protestare in quella buffa maniera:
“Zoong, splash, squarr!”
Una volta andarono a caccia in un mulino, pieno di sacchi di farina bianca e gialla. I topi affondarono i denti in quella manna e masticavano a cottimo, facendo: crik, crik, crik, come tutti i topi quando masticano.
Ma il topo dei fumetti faceva: “Crek, screk, schererek”.
“Impara almeno a mangiare come le persone educate”, borbottò il topo navigatore.
“Se fossimo su un bastimento saresti già stato buttato a mare. Ti rendi conto o no che fai un rumore disgustoso?”
“Crengh”, disse il topo dei fumetti, e tornò a infilarsi in un sacco di granturco.
Il navigatore, allora, fece un segno agli altri, e quatti quatti se la filarono, abbandonando lo straniero al suo destino, sicuri che non avrebbe mai ritrovato la strada di casa. Per un po’ il topolino continuò a masticare. Quando finalmente si accorse di essere rimasto solo, era già troppo buio per cercare la strada e decise di passare la notte al mulino.
Stava per addormentarsi, quand’ecco nel buio accendersi due semafori gialli, ecco il fruscio sinistro di quattro zampe il cacciatore. Un gatto!
“Squash!” disse il topolino, con un brivido.
“Gragrragnau!” rispose il gatto. Cielo, era un gatto dei fumetti!
La tribù dei gatti veri lo aveva cacciato perché non riusciva a fare miao come si deve.
I due derelitti si abbracciarono, giurandosi eterna amicizia e passarono tutta la notte a conversare nella strana lingua dei fumetti.
Si capivano a meraviglia.
Il paese con l’esse davanti
Ascolta la favola
Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, capitò nel paese con l’esse davanti.
“Ma che razza di paese è?” domandò a un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero.
Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò bene aperto sul palmo della mano.
“Vede questo?”
“E’ un temperino”
“Tutto sbagliato. Invece è uno stemperino, cioè un temperino con l’esse davanti. Serve a far ricrescere le matite, quando sono consumate, ed è molto utile nelle scuole”.
“Magnifico”. disse Giovannino. “E poi?”
“Poi abbiamo lo staccapanni”.
“Vorrà dire l’attaccapanni”.
“L’attaccapanni serve a ben poco, se non avete il cappotto da attaccarci. Col nostro staccapanni è tutto diverso. Lì non bisogna attaccarci niente, c’è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto andate lì e lo staccate. Chi ha bisogno di una giacca, non deve mica andare a comprarla: passa dallo staccapanni e la stacca. C’è lo staccapanni d’estate e quello d’inverno, quello per uomo e quello per signora. Così si risparmiano tanti soldi”.
“Una vera bellezza. E poi?”
“Poi abbiamo la macchina fotografica, che invece di fare le fotografie fa le caricature, così si ride.
Poi abbiamo lo scannone.
“Brr, che paura”.
“Tutt’altro. Lo scannone è il contrario del cannone e serve per disfare la guerra”.
“E come funziona?”
“È facilissimo, può adoperarlo anche un bambino.
Se c’è la guerra, suoniamo la stromba, spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta”.
Che meraviglia il paese con l’esse davanti.
Tonino l’invisibile
Ascolta la favola
Una volta un ragazzo di nome Tonino andò a scuola che non sapeva la lezione ed era molto preoccupato al pensiero che il maestro lo interrogasse.
«Ah, – diceva tra sé, – se potessi diventare invisibile…»
Il maestro fece l’appello, e quando arrivò al nome di Tonino, il ragazzo rispose: – Presente! – ma nessuno lo sentì, e il maestro disse: – Peccato che Tonino non sia venuto, avevo giusto pensato di interrogarlo. Se è ammalato, speriamo che non sia niente di grave.
Così Tonino comprese di essere diventato invisibile, come aveva desiderato. Per la gioia spiccò un salto dal suo banco e andò a finire nel cestino della carta straccia.
Si rialzò e si aggirò qua e là per la classe, tirando i capelli a questo e a quello e rovesciando i calamai. Nascevano rumorose proteste, litigi a non finire.
Gli scolari si accusavano l’un l’altro di quei dispetti, e non potevano sospettare che la colpa era invece di Tonino l’invisibile.
Quando si fu stancato di quel gioco Tonino uscì dalla scuola e salì su un filobus, naturalmente senza pagare il biglietto, perché il fattorino non poteva vederlo.
Trovò un posto libero e si accomodò.Alla fermata successiva salì una signora con la borsa della spesa e fece per sedersi proprio in quel sedile, che ai suoi occhi era libero. Invece sedette sulle ginocchia di Tonino, che si sentì soffocare.
La signora gridò: – Che tranello è questo? Non ci si può più nemmeno sedere? Guardate, faccio per posare la borsa e rimane sospesa per aria. La borsa in realtà era posata sulle ginocchia di Tonino.
Nacque una gran discussione, e quasi tutti i passeggeri pronunciarono parole di fuoco contro l’azienda tranviaria.
Tonino scese in centro, si infilò in una pasticceria e cominciò a servirsi a volontà, pescando a due mani tra maritozzi, bignè al cioccolato e paste d’ogni genere.
La commessa, che vedeva sparire le paste dal banco, diede la colpa a un dignitoso signore che stava comprando delle caramelle col buco per una vecchia zia.
Il signore protestò: – Io un ladro? Lei non sa con chi parla. Lei non sa chi era mio padre. Lei non sa chi era mio nonno!
– Non voglio nemmeno saperlo, – rispose la commessa.
– Come, si permette di insultare mio nonno!
Fu una lite spaventosa. Corsero le guardie.
Tonino l’invisibile scivolò tra le gambe del tenente e si avviò verso la scuola, per assistere all’uscita dei suoi compagni. Difatti li vide uscire, anzi, rotolare giù a valanga dai gradini della scuola, ma essi non lo videro affatto.
Tonino si affannava invano a rincorrere questo e quello, a tirare i capelli al suo amico Roberto, a offrire un leccalecca al suo amico Guiscardo.
Non lo vedevano, non gli davano retta per nulla, i loro sguardi lo trapassavano come se fosse stato di vetro.
Stanco e un po’ scoraggiato Tonino rincasò.
Sua madre era al balcone ad aspettarlo.
– Sono qui, mamma! – gridò Tonino.
Ma essa non lo vide e non lo udì, e continuava a scrutare ansiosamente la strada alle sue spalle.
– Eccomi, papà, – esclamò Tonino, quando fu in casa, sedendosi a tavola al suo solito posto.
Ma il babbo mormorava, inquieto: – Chissà perché Tonino tarda tanto. Non gli sarà mica successa qualche disgrazia?
– Ma sono qui, sono qui! Mamma, papà! – gridava Tonino.
Ma essi non udivano la sua voce.
Tonino ormai piangeva, ma a che servono le lacrime, se nessuno può vederle?
– Non voglio più essere invisibile, – si lamentava Tonino, col cuore in pezzi.
– Voglio che mio padre mi veda, che mia madre mi sgridi, che il maestro mi interroghi! Voglio giocare con i miei amici! È brutto essere invisibili, è brutto star soli.
Uscì sulle scale e scese lentamente in cortile.
– Perché piangi? – gli domandò un vecchietto, seduto a prendere il sole su una panchina.
– Ma lei mi vede? – domandò Tonino, pieno d’ansia.
– Ti vedo Sì. Ti vedo tutti i giorni andare e tornare da scuola.
– Ma io non l’ho mai visto, lei.
– Eh, lo so. Di me non si accorge nessuno. Un vecchio pensionato, tutto solo, perché mai i ragazzi dovrebbero guardarlo? Io per voi sono proprio come l’uomo invisibile.
– Tonino! – gridò in quel momento la mamma dal balcone.
– Mamma, mi vedi?
– Ah, non dovrei vederti, magari. Vieni, vieni su e sentirai il babbo.
– Vengo subito, mamma, – gridò Tonino pieno di gioia.
– Non ti fanno paura gli sculaccioni? – rise il vecchietto.
Tonino gli volò al collo e gli diede un bacio. – Lei mi ha salvato, – disse.
– Eh, che esagerazione, – disse il vecchietto.
Il palazzo da rompere
Ascolta la favola
Una volta, a Busto Arsizio, la gente era preoccupata perché i bambini rompevano tutto.
Non parliamo delle suole delle scarpe, dei pantaloni e delle cartelle scolastiche: rompevano
i vetri giocando alla palla, rompevano i piatti a tavola e i bicchieri al bar, e non rompevano i muri solo perché non avevano martelli a disposizione.
I genitori non sapevano più cosa fare e cosa dire e si rivolsero al sindaco.
– Mettiamo una multa? – propose il sindaco.
– Grazie tante, – esclamarono i genitori, – e poi la paghiamo con i cocci.
Per fortuna da quelle parti ci sono molti ragionieri. Ce n’è uno ogni tre persone e tutti ragionano benissimo. Meglio di tutti ragionava il ragionier Gamberoni, un vecchio signore che aveva molti nipoti e quindi in fatto di cocci aveva una vasta esperienza.
Egli prese carta e matita e fece il conto dei danni che i bambini di Busto Arsizio cagionavano
fracassando tanta bella e buona roba a quel modo.
Risultò una somma spaventevole: millanta tamanta quattordici e trentatre, – Con la metà. di questa somma, – dimostro il ragionier Gamberoni, – possiamo costruire un palazzo da rompere e obbligare i bambini a farlo a pezzi: se non guariscono con questo sistema non guariscono più.
La proposta fu accettata, il palazzo fu costruito in quattro e quattro otto e due dieci.
Era alto sette piani, aveva novantanove stanze, ogni stanza era piena di mobili e ogni mobile zeppo di stoviglie e soprammobili, senza contare gli specchi e i rubinetti.
Il giorno dell’inaugurazione a tutti i bambini venne consegnato un martello e un segnale del sindaco le porte del palazzo da rompere furono spalancate.
Peccato che la televisione non sia arrivata in tempo per trasmettere lo spettacolo.
Chi l’ha visto con i suoi occhi e sentito con le sue orecchie assicura che pareva – mai non sia! – lo scoppio della terza guerra mondiale.
I bambini passavano di stanza in stanza come l’esercito di Attila e fracassavamo a martellate quanto incontravano sul loro cammino. I colpi si udivano in tutta la Lombardia e in mezza Svizzera. Bambini alti come la coda del gatto si erano attaccati ad armadi grossi come incrociatori e li demolirono scrupolosamente fino a lasciare una montagna di trucioli.
Infanti dell’asilo, belli e graziosi nei loro grembiulini rosa e celesti, pestavano diligentemente i servizi da caffè riducendoli in polvere finissima, con la quale si incipriavano il viso.
Alla fine del primo giorno non era rimasto un bicchiere sano. Alla fine del secondo giorno scarseggiavano le sedie. Il terzo giorno i bambini affrontarono i muri, cominciando dall’ultimo piano, ma quando furono arrivati al quarto, stanchi morti e coperti di polvere come i soldati
di Napoleone nel deserto, piantarono baracca e burattini, tornarono a casa barcollando e andarono a letto senza cena.
Ormai si erano davvero sfogati e non provavano più gusto a rompere nulla, di colpo erano diventati delicati e leggeri come farfalle e avreste potuto farli giocare al calcio su un campo di bicchieri di cristallo che non ne avrebbero scheggiato uno solo.
Il Rag. Gamberoni fece i conti e dimostrò che la città di Busto Arsizio aveva realizzato un risparmio di due stramilioni e sette centimetri.
Quello che restava in piedi del palazzo da rompere, il Comune lasciò liberi i cittadini di farne quel che volevano.
Allora si videro certi signori con cartella di cuoio e occhiali a lenti bifocali – magistrati, notai, consiglieri delegati – armarsi di martello e correre a demolire una parete o a smantellare una scala, picchiando tanto di gusto che ad ogni colpo si sentivano ringiovanire.
– Piuttosto che litigare con la moglie, – dicevano allegramente, – piuttosto di spaccare i portacenere e i piatti del servizio buono, regalo della zia Mirina… E giù martellate.
Al ragionier Gamberoni, in segno di gratitudine, la città di Busto Arsizio decretò una medaglia con un buco d’argento.
(da “Favole al telefono” di Gianni Rodari)
L’omino di niente
Ascolta la favola
C’era una volta un omino di niente. Aveva il naso di niente, la bocca di niente, era vestito di niente e calzava scarpe di niente. Si mise in viaggio su una strada di niente che non andava in nessun posto. Incontrò un topo di niente e gli domandò: — Non hai paura del gatto?
— No davvero, – rispose il topo di niente, – in questo paese di niente ci sono soltanto gatti di niente, che hanno baffi di niente e artigli di niente.
Inoltre, io rispetto il formaggio. Mangio solo i buchi. Non sanno di niente ma sono dolci.
— Mi gira la testa, – disse l’omino di niente.
— È una testa di niente: anche se la batti contro il muro non ti farà male.
L’omino di niente, volendo fare la prova, cercò un muro per batterci la testa, ma era un muro di niente, e siccome lui aveva preso troppo slancio cascò dall’altra parte.
Anche di là non c’era niente di niente.
L’omino di niente era tanto stanco di tutto quel niente che si addormentò.
E mentre dormiva sognò che era un omino di niente, e andava su una strada di niente, e incontrava un topo di niente e mangiava anche lui i buchi del formaggio, e il topo di niente aveva ragione: non sapevano proprio di niente.
(da “Favole al telefono” di Gianni Rodari)
L’apollonia della marmellata
Ascolta la favola
A Sant’Antonio, sul Lago Maggiore, viveva una donnina tanto brava a fare la marmellata, cosí brava che i suoi servigi erano richiesti in Valcuvia, in Valtravaglia, in Val Dumentina e in Val Poverina. La gente, quand’era la stagione, arrivava da tutte le valli, si sedeva sul muricciolo a guardare il panorama del lago, coglieva qualche lampone dai cespugli, poi chiamava la donnina della marmellata:
– Apollonia!
– Che c’è?
– Me la fareste una marmellata di mirtilli?
– Eccomi.
– Mi aiutereste a fare una buona marmellata di prugne?
– Subito.
L’Apollonia, quella donnina, aveva proprio le mani d’oro, e faceva le migliori marmellate del Varesotto e del Canton Ticino.
Una volta capitò da lei una donnetta di Arcumeggia, cosí povera che per fare la marmellata non aveva neanche un cartoccio di ghiande di pesca, e allora, strada facendo, si era riempito il grembiule di ricci di castagne.
– Apollonia, me la fareste la marmellata?
– Coi ricci?
– Non ho trovato altro…
– Pazienza, proverò.
E l’Apollonia tanto fece che dai ricci delle castagne cavò la meraviglia delle marmellate.
Un’altra volta quella donnina di Arcumeggia non trovò nemmeno i ricci delle castagne, perché le foglie secche, cadendo, li avevano ricoperti; perciò arrivò con un grembiule pieno di ortiche.
– Apollonia, me la fate la marmellata?
– Con le ortiche?
– Non ho trovato altro…
– Pazienza, si vedrà.
E l’Apollonia prese le ortiche, le inzuccherò, le fece bollire come sapeva lei e ne ottenne una marmellata da leccarsi le dita.
Perché l’Apollonia, quella donnina, aveva le mani d’oro e d’argento, e avrebbe fatto la marmellata anche con i sassi.
Una volta passò di lí l’imperatore e volle provare anche lui la marmellata dell’Apollonia, e lei gliene dette un piattino, ma l’imperatore dopo la prima cucchiaiata si disgustò, perché c’era caduta dentro una mosca.
– Mi fa schifo, – disse l’imperatore.
– Se non era buona, la mosca non ci cascava, – disse l’Apollonia.
Ma ormai l’imperatore si era arrabbiato e ordinò ai suoi soldati di tagliare le mani all’Apollonia.
Allora la gente si ribellò e mandò a dire all’imperatore che se lui faceva tagliare le mani all’Apollonia loro gli avrebbero tagliato la corona con tutta la testa, perché teste per fare l’imperatore se ne trovano a tutte le cantonate, ma mani d’oro come quelle dell’Apollonia sono ben piú preziose e rare.
E l’imperatore dovette far fagotto.
(da “Favole al telefono” di Gianni Rodari)
Il re Mida
Ascolta la favola
Il re Mida era un grande spendaccione, tutte le sere dava feste e balli, fin che si trovò senza un centesimo.
Andò dal mago Apollo, gli raccontò i suoi guai e Apollo gli fece questo incantesimo:
-Tutto quello che le tue mani toccano deve diventare oro.
Il re Mida fece un salto per la contentezza e tornò di corsa alla sua automobile, ma non fece in tempo a toccare la maniglia della portiera che subito la macchina diventò tutta d’oro: ruote d’oro, vetri d’oro, motore d’oro.
Era diventata d’oro anche la benzina, così la macchina non camminava più e bisognò far venire un carro coi buoi per trasportarla.
Appena a casa il re Mida andava in giro per le stanze a toccare più cose che poteva, tavoli, armadi, sedie, e tutto diventava d’oro.
A un certo punto ebbe sete, si fece portare un bicchiere d’acqua, ma il bicchiere diventò d’oro, l’acqua pure, e se volle bere dovette lasciarsi imboccare dal suo servo col cucchiaio.
Venne l’ora di andare a tavola.
Toccava la forchetta e diventava d’oro e tutti gli invitati battevano le mani e dicevano:
– Maestà, toccatemi i bottoni della giacca, toccatemi questo ombrello.
Il re Mida li faceva contenti, ma quando prese il pane per mangiare anche quello diventò d’oro e se volle cavarsi l’appetito dovette farsi imboccare dalla regina.
Gli invitati si nascondevano sotto il tavolo a ridere e il re Mida si arrabbiò, ne acchiappò uno e gli fece diventare d’oro il naso, così non poteva più soffiarselo.
Venne l’ora di andare a dormire, ma il re Mida, senza volerlo, toccò il cuscino, toccò le lenzuola e il materasso, diventarono d’oro massiccio ed erano troppo duri per dormirci.
Gli toccò di passare la notte seduto su una poltrona, con le braccia alzate per non toccare niente, e la mattina dopo era stanco morto.
Corse subito dal mago Apollo per farsi disfare l’incantesimo, e Apollo lo accontentò.
– Va bene, – gli disse, – ma sta’ bene attento, perché per far passare l’incantesimo ci vogliono sette ore e sette minuti giusti, e in questo tempo tutto quello che toccherai diventerà cacca di mucca.
Il re Mida se ne andò tutto consolato, e stava bene attento all’orologio, per non toccare niente prima che fossero passati sette ore e sette minuti.
Purtroppo il suo orologio correva un po’ più del necessario, e andava avanti un minuto ogni ora.
Quando ebbe contato sette ore e sette minuti il re Mida aprì la macchina e ci montò, e subito si trovò seduto in mezzo a un gran mucchio di cacca di mucca, perché mancavano ancora sette minuti alla fine dell’incantesimo.
(da “Favole al telefono” di Gianni Rodari)
Il filobus numero 75
Ascolta la favola
Una mattina il filobus numero 75, in partenza da Monteverde Vecchio per Piazza Fiume, invece di scendere verso Trastevere, prese per il Gianicolo, svoltò giù per l’Aurelia Antica e dopo pochi minuti correva tra i prati fuori Roma come una lepre in vacanza.
I viaggiatori, a quell’ora, erano quasi tutti impiegati e leggevano il giornale, anche quelli che non lo avevano comperato, perché lo leggevano sulla spalla del vicino. Un signore, nel voltar pagina, alzò gli occhi un momento, guardò fuori e si mise a gridare:
“Fattorino, che succede? Tradimento, tradimento!”
Anche gli altri viaggiatori alzarono gli occhi dal giornale, e le proteste diventarono un coro tempestoso:
“Ma di qui si va a Civitavecchia!”
“Che fa il conducente?”
“E’ impazzito, legatelo!”
“Che razza di servizio!”
“Sono le nove meno dieci e alle nove in punto debbo essere in Tribunale, – gridò un avvocato, – se perdo il processo faccio causa all’azienda.”
Il fattorino e il conducente tentavano di respingere l’assalto, dichiarando che non ne sapevano nulla, che il filobus non ubbidiva più ai comandi e faceva di testa sua. Difatti in quel momento il filobus uscì addirittura di strada e andò a fermarsi sulle soglie di un boschetto fresco e profumato.
“Uh, i ciclamini” – esclamò una signora, tutta giuliva.
“E’ proprio il momento di pensare ai ciclamini” – ribatté l’avvocato.
“Non importa, – dichiarò la signora, – arriverò tardi al ministero, avrò una lavata di capo, ma tanto è lo stesso e giacché ci sono mi voglio levare la voglia dei ciclamini. Saranno dieci anni che non ne colgo.”
Scese dal filobus, respirando a bocca spalancata l’aria di quello strano mattino e si mise a fare un mazzetto di ciclamini.
Visto che il filobus non voleva saperne di ripartire, uno dopo l’altro i viaggiatori scesero a sgranchirsi le gambe o a fumare una sigaretta e intanto il loro malumore scompariva come la nebbia al sole. Uno coglieva una margherita e se la infilava all’occhiello, l’altro scopriva una fragola acerba e gridava:
“L’ho trovata io. Ora ci metto il mio biglietto, e quando è matura la vengo a cogliere, e guai se non la trovo.”
Difatti levò dal portafogli un biglietto da visita, lo infilò in uno stecchino e piantò lo stecchino accanto alla fragola. Sul biglietto c’era scritto: – Dottor Giulio Bollati.
Due impiegati del ministero dell’Istruzione appallottolarono i loro giornali e cominciarono una partita di calcio. E ogni volta che davano un calcio alla palla gridavano: “Al diavolo!”
Insomma, non parevano più gli stessi impiegati che un momento prima volevano linciare i tranvieri. Questi, poi, si erano divisi una pagnottella col ripieno di frittata e facevano un picnic sull’erba.
“Attenzione!” – gridò ad un tratto l’avvocato.
Il filobus, con uno scossone, stava ripartendo tutto solo, al piccolo trotto. Fecero appena in tempo a saltar su e l’ultima fu la signora dei ciclamini che protestava:
– Eh, ma allora non vale. Avevo appena cominciato a divertirmi.
“Che ora abbiamo fatto?” – domandò qualcuno.
“Uh, chissà che tardi.”
E tutti si guardarono il polso. Sorpresa: gli orologi segnavano ancora le nove meno dieci. Si vede che per tutto il tempo della piccola scampagnata le lancette non avevano camminato. Era stato tempo regalato, un piccolo extra, come quando si compra una scatola di sapone in polvere e dentro c’è un giocattolo.
“Ma non può essere!” – si meravigliava la signora dei ciclamini, mentre il filobus rientrava nel suo percorso e si gettava giù per via Dandolo.
Si meravigliavano tutti. E sì che avevano il giornale sotto gli occhi, e in cima al giornale la data era scritta ben chiara: 21 marzo.
Il primo giorno di primavera tutto è possibile.
(da “Favole al telefono” di Gianni Rodari)
La caramella istruttiva
Ascolta la favola
Sul pianete Bih non ci sono libri. La scienza si vende e si consuma in bottiglie.
La storia è un liquido rosso che sembra granatina, la geografia un liquido verde menta, la grammatica incolore e ha il sapore dell’acqua minerale. Non ci sono scuole, si studia a casa. Ogni mattina i bambini, secondo l’età, debbono mandar giù un bicchiere di storia, qualche cucchiaiata di aritmetica e così via.
Ci crederete? Fanno i capricci lo stesso.
– Su, da bravo, – dice la mamma, – non sai quanto è buona la zoologia. È dolce, dolcissima.
Domandalo alla Carolina – (che è il robot elettronico di servizio).
La Carolina, generosamente, si offre di assaggiare per prima il contenuto della bottiglia. Se ne versa un dito nel bicchiere, lo beve, fa schioccare la lingua: – Uh, se è buona – esclama, e subito comincia a recitare la zoologia: – “La mucca è un quadrupede ruminante, si nutre di erba e ci dà il latte con la cioccolata.”
– Hai visto? – domanda la mamma trionfante.
Lo scolaretto nicchia. Sospetta ancora che non si tratti di zoologia, ma di olio di fegato di merluzzo.
Poi si rassegna, chiude gli occhi e trangugia la sua lezione tutta in una volta. Applausi.
Ci sono, si capisce, anche scolaretti diligenti e studiosi: anzi golosi. Si alzano di notte a rubare la storia-granatina, e leccano fin l’ultima goccia dal bicchiere. Diventano sapientissimi.
Per i bambini dell’asilo ci sono delle caramelle istruttive: hanno il gusto di fragola, dell’ananas, del ratafià, e contengono alcune facili poesie, i nomi dei giorni della settimana, la numerazione fino a dieci.
Un mio amico cosmonauta mi ha portato per ricordo una di quelle caramelle. L’ho data al mio bambino, ed esso ha cominciato subito a recitare una buffa filastrocca nella lingua del pianeta Bih, che diceva pressapoco:
“anta anta pero pero
penta pinta pim però“,
e io non ci ho capito niente.
(da “Favole al telefono” di Gianni Rodari)
Il palazzo di gelato
Ascolta la favola
Una volta, a Bologna, fecero un palazzo di gelato proprio sulla Piazza Maggiore, e i bambini venivano di lontano a dargli una leccatina.
Il tetto era di panna montanta, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli di frutta candita. Tutto il resto era di gelato: le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato.
Un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e gli leccò le zampe una per una, fin che il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti, e i piatti erano di gelato al cioccolato, il più buono.
Una guardia del Comune, a un certo punto, si accorse che una finestra si scioglieva. I vetri erano di gelato alla fragola, e si squagliavano in rivoletti rosa.
“Presto”, gridò la guardia, “più presto ancora!”
E giù tutti a leccare più presto, per non lasciar andare perduta una sola goccia di quel capolavoro.
“Una poltrona!” implorava una vecchiettina, che non riusciva a farsi largo tra la folla, “una poltrona per una povera vecchia. Chi me la porta? Coi braccioli, se è possibile”.
Un generoso pompiere corse a prenderle una poltrona di gelato alla crema e pistacchio, e la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai braccioli.
Fu un gran giorno, quello, e per ordine dei dottori nessuno ebbe il mal di pancia.
Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori sospirano: “Eh già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di Bologna”.
(da “Favole al telefono” di Gianni Rodari)
La guerra delle campane
Ascolta la favola
C’era una volta una guerra, una grande e terribile guerra, che faceva morire molti soldati da una parte e dall’altra. Noi stavamo di qua e i nostri nemici stavano di là, e ci sparavano addosso giorno e notte, ma la guerra era tanto lunga che a un certo punto ci venne a mancare il bronzo per i cannoni, non avevamo più ferro per le baionette, eccetera.
Il nostro comandante, lo Stragenerale Bombone Sparone Pestafracassone, ordinò di tirar giù tutte le campane dai campanili e di fonderle tutte insieme per fabbricare un grossissimo cannone: uno solo, ma grosso abbastanza da vincere tutta la guerra con un sol colpo.
A sollevare quel cannone ci vollero centomila grù; per trasportarlo al fronte ci vollero novantasette treni. Lo Stragenerale si fregava le mani per la contentezza e diceva: “Quando il mio cannone sparerà i nemici scapperanno fin sulla luna”.
Ecco il gran momento. Il cannonissimo era puntato sui nemici. Noi ci eravamo riempiti le orecchie di ovatta, perché il frastuono poteva romperci i timpani e la tromba di Eustachio.
Lo Stragenerale Bombone Sparone Pestafracassone ordinò: “Fuoco!”
Un artigliere premette un pulsante. E d’improvviso, da un capo all’altro del fronte, si udì un gigantesco scampanio: Din! Don! Dan!
Noi ci levammo l’ovatta dalle orecchie per sentir meglio.
“Din! Don! Dan!, tuonava il cannonissimo. E centomila echi ripetevano per monti e per valli:
“Din! Don! Dan!
“Fuoco!” gridò lo Stragenerale per la seconda volta: “Fuoco, perbacco!”
L’artigliere premette nuovamente il pulsante e di nuovo un festoso concerto di campane si diffuse di trincea in tricea. Pareva che suonassero insieme tutte le campane della nostro patria. Lo Stragenerale si strappava i capelli per la rabbia e continuò a strapparseli fin che gliene rimase uno solo.
Poi ci fu un momento di silenzio. Ed ecco che dall’altra parte del fronte, come per un segnale, rispose un allegro, assordante: Din! Don! Dan!
Perché dovete sapere che anche il comandate dei nemici, il Mortesciallo Von Bombonen Sparonen Pestrafrakasson, aveva avuto l’idea di fabbricare un connonissimo con le campane del suo paese!
Din! Dan! Tuonava adesso il nostro cannone.
Don! Rispondeva quello dei nemici. E i soldati dei due eserciti balzavano dalle trincee, si correvano incontro, ballavano e gridavano: “Le campane, le campane! E’ festa! È scoppiata la pace!”.
Lo Stragenerale e il Mortesciallo salirono sulle loro automobili e corsero lontano, e consumarono tutta la benzina, ma il suono delle campane li inseguiva ancora.
(da “Favole al telefono” di Gianni Rodari)
Il topo che mangiava i gatti
Ascolta la favola
Un vecchio topo di biblioteca andò a trovare i suoi cugini, che abitavano in solaio e conoscevano poco il mondo.
– Voi conoscete poco il mondo, – egli diceva ai suoi timidi parenti, – e probabilmente non sapete nemmeno leggere.
– Eh, tu la sai lunga, – sospiravano quelli.
– Per esempio, avete mai mangiato un gatto?
– Eh, tu la sai lunga.
Ma da noi sono i gatti che mangiano i topi.
– Perché siete ignoranti.
Io ne ho mangiato più d’uno e vi assicuro che non hanno detto neanche: Ahi!
– E di che sapevano?
– Di carta e d’inchiostro, a mio parere.
Ma questo è niente.
Avete mai mangiato un cane?
– Per carità.
– Io ne ho mangiato uno proprio ieri.
Un cane lupo.
Aveva certe zanne…
Bene, si è lasciato mangiare quieto quieto e non ha detto neanche: Ahi!
– E di che sapeva?
– Di carta, di carta.
E un rinoceronte l’avete mai mangiato?
– Eh, tu la sai lunga.
Ma noi un rinoceronte non l’abbiamo visto mai.
Somiglia al parmigiano o al gorgonzola?
– Somiglia a un rinoceronte, naturalmente.
E avete mai mangiato un elefante, un frate, una principessa, un albero di Natale?
In quel momento il gatto, che era stato ad ascoltare dietro un baule, balzò fuori con un miagolio minaccioso.
Era un gatto vero, di carne e d’ossa, con baffi e artigli.
I topolini volarono a rintanarsi, tranne il topo di biblioteca, che per la sorpresa era rimasto immobile sulle sue zampe come un monumentino.
Il gatto lo agguantò e cominciò a giocare con lui.
– Tu saresti il topo che mangia i gatti?
– Io, Eccellenza…
Lei deve comprendere…
Stando sempre in libreria…
– Capisco, capisco.
Li mangi in figura, stampati nei libri.
– Qualche volta, ma solo per ragioni di studio.
– Certo.
Anch’io apprezzo la letteratura.
Ma non ti pare che avresti dovuto studiare un pochino anche dal vero?
Avresti imparato che non tutti i gatti sono fatti di carta, e non tutti i rinoceronti si lasciano rosicchiare dai topi.
Per fortuna del povero prigioniero il gatto ebbe un attimo di distrazione, perché aveva visto passare un ragno sul pavimento.
Il topo di biblioteca, con due salti, tornò tra i suoi libri, e il gatto dovette accontentarsi di mangiare il ragno.
La famosa pioggia di Piombino
Ascolta la favola
Una volta a Piombino piovvero confetti. Venivano giù grossi come chicchi di grandine, ma erano di tutti i colori: verdi, rosa, viola, blu.
Un bambino si mise in bocca un chicco verde, tanto per provare, e trovò che sapeva di menta. Un altro assaggiò un chicco rosa e sapeva di fragola.
“Sono confetti! Sono confetti!”.
E via tutti per le strade a riempirsene le tasche.
Ma non facevano in tempo a raccoglierli, perché venivano giù fitti fitti.
La pioggia durò poco ma lasciò le strade coperte da un tappeto di confetti profumati che scricchiolavano sotto i piedi.
Gli scolari, tornando da scuola, ne trovarono ancora da riempirsi le cartelle.
Le vecchiette ne avevano messi insieme dei bei fagottelli coi loro fazzoletti da testa.
Fu una grande giornata.
Anche adesso molta gente aspetta che dal cielo piovano confetti, ma quella nuvola non è passata più né da Piombino né da Torino, e forse non passerà mai nemmeno da Cremona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Phone photo created by drobotdean – www.freepik.com

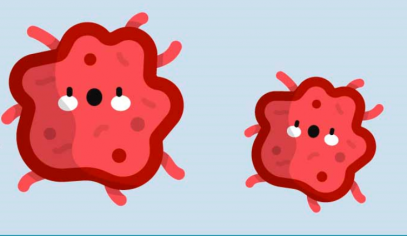











Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via