
La valutazione in itinere si adatta a quella finale: cosa ci rivelano le scelte valutative sulla qualità della scuola

Cosa ci dicono le particolari scelte valutative operate da un gruppo di docenti sulla qualità della scuola in cui lavorano? Nel corso degli ultimi decenni abbiamo appreso molte cose rispetto all’efficacia e all’inefficacia delle diverse scelte valutative. In particolare, numerose ricerche empiriche hanno studiato l’associazione tra alcune scelte comunicative della valutazione svolta nel corso della didattica e la qualità degli apprendimenti e della dimensione emotivo-motivazionale. Le indagini hanno ampiamente mostrato che la scelta di impiegare i voti nel corso della didattica (numerici o non numerici: non v’è alcuna differenza tra un 8 e un buono) non è associata né al miglioramento degli apprendimenti né allo sviluppo di emozioni positive e di un’adeguata motivazione verso lo studio. In poche parole, nelle classi in cui la valutazione è incentrata sui voti si tende ad apprendere meno, si sta peggio e si sviluppa un crescente astio nei confronti della scuola e, più in generale, dello studio. Ovviamente ci sono eccezioni, però di solito a limitare i danni in simili contesti è la popolazione studentesca che sin dall’inizio ha una buona dotazione di partenza. In sintesi, la scelta di impiegare i voti in itinere è profondamente selettiva e riproduttiva: trasforma il privilegio di alcuni individui in merito e lo svantaggio di altri in colpa. Tuttavia, almeno per la legge, nella valutazione in itinere non è obbligatorio né uno né un “congruo numero di voti”.
Fortunatamente, esistono scuole e docenti che non incentrano sui voti la valutazione in itinere ma – in coerenza sia con la normativa sia con le ricerche scientifiche in ambito pedagogico e didattico – ricorrono a feedback analitici, ovvero a riscontri descrittivi. Le indagini condotte sul campo mostrano chiaramente che i feedback analitici sono associati ad apprendimenti migliori, allo sviluppo di emozioni positive e di una forte motivazione verso lo studio. Questi riscontri descrittivi, veri e propri indicatori di un insegnamento di qualità, mostrano alcune caratteristiche fondamentali: non comunicano voti ma informazioni sul lavoro svolto (punti di forza, criticità) e sui processi che lo hanno accompagnato; forniscono concrete indicazioni di miglioramento delle specifiche attività e usano l’errore come risorsa e non come penalizzazione. È inoltre stato riscontrato come una rigorosa autovalutazione consenta di impiegare i criteri valutativi come elementi di regolazione delle attività, un processo che rende molto più significativo l’apprendimento. Se le scelte sulla valutazione in itinere ci dicono molto sulla qualità di una scuola è perché esse sono lo specchio di un certo modo di concepire l’insegnamento. Il ricorso al feedback descrittivo e non al voto è associato a una didattica che coinvolge attivamente chi apprende. Prendiamo la didattica dell’errore.
Questa scelta didattica, estremamente efficace, viene compromessa dalla tendenza a basare la valutazione in itinere sui voti. Infatti, assegnare un voto a una prova porta insegnanti e studenti a concepire ogni errore come fattore di penalizzazione. L’errore serve a scalare qualche punto da un massimo teorico da assegnare a un lavoro “perfetto”. In tal modo l’errore viene per lo più percepito come elemento di frustrazione o umiliazione e non come occasione di insegnamento e apprendimento. Sappiamo bene che il voto colloca inevitabilmente un individuo in una certa posizione nella graduatoria di classe e, in genere, il perdere posizioni (o il non guadagnarne) viene associato a un fallimento.
Non è un caso che, generalmente, la scelta di abbinare in itinere un voto a un riscontro descrittivo sia piuttosto inefficace, dato che la presenza del voto tende a inibire un ragionamento costruttivo sugli errori. Fatte queste premesse, è lecito chiedersi quali conseguenze avrà sull’insegnamento e sull’apprendimento il cambiamento nella valutazione periodica e finale della scuola primaria. Come noto, l’OM 3/2025 ha reintrodotto nelle schede di fine quadrimestre (valutazione periodica) e di fine anno (valutazione finale) i voti non numerici più tradizionali (giudizi sintetici da non sufficiente a ottimo per ogni disciplina) rispetto a quelli previsti all’A.S. 2020/21 (livelli da in via di prima acquisizione ad avanzato per ogni obiettivo). La valutazione sulla scheda e quella in itinere hanno funzioni differenti alle quali corrispondono – o dovrebbero corrispondere – differenti scelte comunicative.
Questo è solo un estratto dell’articolo presente all’interno del numero 651 di Tuttoscuola.
Per leggere l’articolo sfoglia la rivista cliccando qui.
Non sei ancora abbonato? Clicca qui e scopri come abbonarti (a partire da 2,50 euro al mese)
Chi è l’autore
Cristiano Corsini
Docente ordinario dell’Università di Roma Tre. La sua attività di ricerca è finalizzata all’analisi dei paradigmi, degli approcci e delle scelte metodologiche che caratterizzano le prassi valutative di scuole, università, docenti e istituti preposti alla valutazione educativa (Invalsi, Anvur, Oecd, Iea). Le aree d’indagine sono quattro. La prima è relativa all’impiego, da parte di scuole, università e docenti, di strumenti e approcci valutativi finalizzati all’autovalutazione e alla valutazione, con particolare riguardo all’utilizzo della valutazione formativa come strategia didattica e di sviluppo di contesti complessi. La seconda è legata all’analisi dei sistemi di accountability educativa, all’impiego di modelli del valore valore aggiunto e di altri indicatori di efficacia a livello scolastico e universitario. La terza indaga il ruolo degli stereotipi, con particolare riferimento a quelli di genere, nei processi valutativi. La quarta, infine, è relativa allo sviluppo della ricerca-formazione come elemento di sintesi tra didattica e indagine scientifica.
Di più all’interno dell’ultimo numero di Tuttoscuola
Nel numero di aprile un focus dedicato alle nuove Indicazioni Nazionali e un approfondimento sull’Istruzione Tecnica Superiore. La Scuola che Sogniamo di questo numero è curata da Fondazione Carolina che punta i fari sul bullismo e sul cyberbullismo. Nel Cantiere della Didattica, Cristiano Corsini scrive di scelte valutative e qualità delle scuole, Gregorio Iannaccone della valutazione dei dirigenti e Roberto Franchini del curricolo intelligente. Franco Lorenzoni ci parla invece di scrittura creativa e lettura collettiva. Presenti come sempre approfondimenti dedicati a DS, DSGA e genitori. Da non perdere!
© RIPRODUZIONE RISERVATA


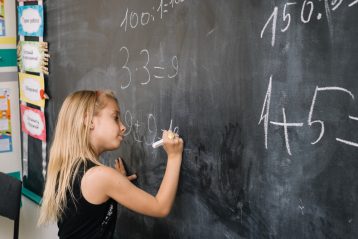





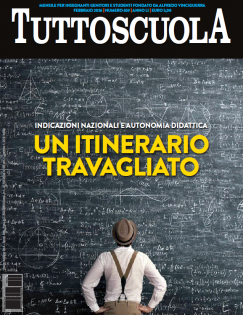




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via