
Fubini: “Perché in Italia resti quello che nasci”
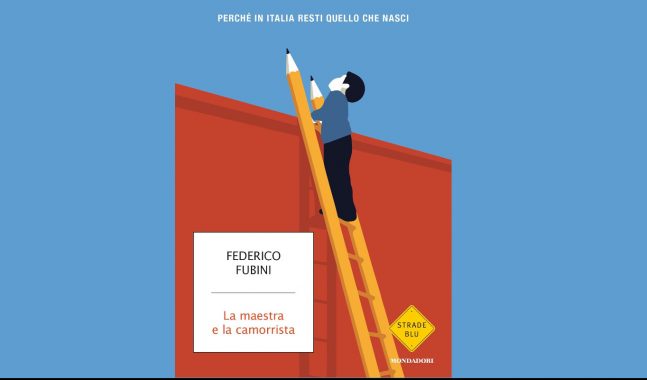
Il sottotitolo dell’ultimo libro di Federico Fubini, inviato ed editorialista economico del Corriere della Sera (di cui è anche vicedirettore ‘ad personam’), spiega in sintesi qual è il filo conduttore del volume, intitolato La Maestra e la camorrista (Mondadori, 2018), un’opera che affronta il tema dell’immobilità sociale plurisecolare del nostro Paese non con il linguaggio asettico del saggista economico ma con quello caldo e a tratti appassionato del narratore.
L’esordio del libro è fulminante: Fubini incontra a Firenze il marchese Piero Antinori, che risiede a Palazzo Antinori, in Piazza Antinori, ed è l’ultimo discendente di una famiglia di vinattieri già nota nel 1300, e che ha svolto questa attività con successo nei secoli successivi, da una generazione all’altra, fino ad oggi.
L’idea di incontrare Piero Antinori è stata suggerita al fiorentino Fubini da uno studio di due ricercatori della Banca d’Italia che, confrontando la Firenze attuale con quella quattrocentesca dei Medici, hanno scoperto che le famiglie più ricche e quelle più povere sono rimaste le stesse di sei secoli e venti generazioni fa.
Fubini ha voluto riscontrare questa tesi con un singolare approccio, a metà strada tra il giornalismo d’inchiesta e la metodologia della pedagogia sperimentale, che lo ha portato a sottoporre una serie di test a giovani studenti appartenenti a due classi sociali agli antipodi: gli allievi di un prestigioso liceo classico milanese e di un collegio universitario esclusivo del Nord da una parte, e quelli di un istituto professionale di Mondragone (Caserta) e di un quartiere di Napoli dominato dalla camorra dall’altra.
Si può combattere l’immobilità sociale?
I test somministrati hanno interrogato i giovani su temi come la fiducia in se stessi, nella propria intelligenza, nel proprio futuro e nel prossimo, con l’obiettivo di verificare se e quanto questi fattori impediscano ai più svantaggiati di cambiare la propria condizione d’origine.
Ne è risultato che a quell’età i giochi sono già fatti, anzi che lo erano già da assai prima, dalla scuola elementare se non dell’infanzia, dai primissimi anni di età. Sulla base di altri test e verifiche l’autore deduce che “Già a cinque anni l’attitudine a fidarsi, investire, interagire nel proprio interesse, era molto diversa in base al luogo di nascita”. Così i giovani discendenti da famiglie che in passato hanno avuto successo economico sono ancora al vertice, mentre quelli appartenenti alle classi popolari di un tempo sono sempre fermi ai gradini più bassi, è la constatazione finale di Fubini.
Il libro è ricco di episodi e personaggi che lo rendono vivace ed emotivamente coinvolgente, come la maestra che era diventata amica di una camorrista, poi uccisa, che la aveva però aiutata a tenere regolarmente in classe i bambini del quartiere (uno dei più poveri di Napoli, e quello anagraficamente più giovane, denominato con un nome di fantasia), oppure il violinista di origine colombiana (nato a Medellin, capitale del narcotraffico) William Chiquito, giunto in Italia grazie a una borsa di studio del pittore Fernando Botero e oggi apprezzato componente dell’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, coinvolto da Fubini in uno straordinario incontro con i ragazzi di un Istituto tecnico di Mondragone volto a dimostrare che il destino e la fortuna individuali non sono inevitabilmente legati alla classe sociale di appartenenza.
Occorre cominciare dai bambini di 0-5 anni
Messaggi di speranza, che però si scontrano con la dura realtà di un Paese afflitto da una immobilità sociale antica, le cui radici affondano anche nella diversa educazione ricevuta dai bambini fin dai primi anni di vita, quelli in cui si formano le strutture cognitive e caratteriali fondamentali, che influiscono poi sui diversi destini. Per questo, sostiene Fubini nel capitolo conclusivo del volume, chiaramente rivolto ai decisori politici, se è indispensabile investire in istruzione per ragioni di carattere generale, di tipo macroeconomico e sociale, lo è ancora di più, per un Paese come l’Italia, puntare prioritariamente sugli interventi educativi in favore dei bambini di 0-5 anni delle aree svantaggiate.
A sostegno della proposta l’autore cita un lavoro dell’economista e sociologo americano James Heckman (Give Kids a Fair Chance, MIT Presse, 2013) che ha stimato in oltre sette dollari per dollaro investito il rendimento di un programma di educazione prescolare realizzato negli Stati Uniti, in North Carolina, in favore di alcuni neonati di quartieri particolarmente difficili, seguiti poi per 35 anni con uno studio longitudinale. Un investimento di questo tipo sarebbe particolarmente raccomandabile in un Paese ad elevata immobilità sociale come l’Italia. Forse non avrebbe lo stesso elevato rendimento stimato da Heckman, ma “sarebbe comunque più del valore di un titolo di Stato italiano negli anni d’oro”, conclude Fubini.














Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via