
Danilo Dolci, 100 anni dalla nascita. Novara: ‘In lui la politica è educazione e l’educazione è politica. Il suo metodo esempio di educazione liberante’
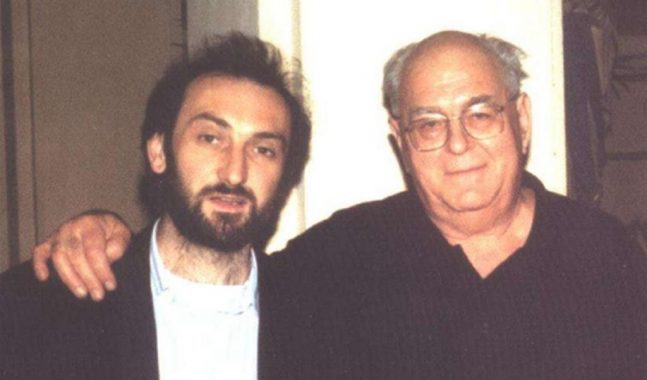
Non impartiva lezioni ma dava esempi. E scioperava alla rovescia. A 100 anni dalla nascita di Danilo Dolci, una delle più significative personalità in campo di nonviolenza ed esperienza maieutica, parliamo di lui e del suo messaggio insieme a Daniele Novara, pedagogista, autore, counselor, formatore e direttore di CPP.
A 100 anni dalla nascita di Danilo Dolci, qual è l’attualità del suo messaggio?
“Per comprenderne l’attualità, occorre entrare nel cuore della sua esperienza e della sua ricerca: la maieutica, una parola greca che sta per «ostetricia», ovvero l’arte di far nascere. La maieutica per lui è liberare le risorse personali, sociali, di gruppo, di comunità; uscire dall’autoreferenza e muoversi assieme per svilupparsi e sviluppare. Si tratta di un progetto molto ambizioso che unisce economia, cultura, società, politica e educazione. Un sogno che ancora oggi tiene vive tante aspirazioni.
Danilo si è sempre posto il problema di come rendere le persone protagoniste dei loro destini, al di là di ogni oppressione e di ogni falsità. Una ricchezza che non possiamo permetterci di disperdere in nessun modo: il suo metodo di lavoro è un esempio praticabile di educazione liberante.
In Danilo Dolci la politica è educazione e l’educazione è politica, in quanto i presupposti della democrazia sono culturali e non solo istituzionali. La democrazia per Danilo Dolci si forma innanzitutto nella testa delle persone. Lui stesso definisce i processi di cambiamento sociale che propone nella Sicilia degli anni ’50 e ’60 di “crescita collettiva”, di crescita di un popolo, non possono essere imposti dall’alto. Vi è in lui una costante tensione a generare quelle condizioni sociali e politiche che permettono ai singoli individui di maturare una consapevolezza del proprio valore, del proprio potere, il bisogno di farsi sentire, di valorizzare la propria esistenza”.
Don Milani, Danilo Dolci, Bruno Ciari… Negli ultimi anni abbiamo celebrato la nascita di tre grandi pedagogisti. C’è un filo rosso che attraversa il pensiero e l’azione di questi grandi maestri?
“Tutto il settore educativo vive oggi una condizione di grande sofferenza, non di semplice difficoltà. Bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e operatori educativi si trovano in una situazione di forte marginalità, se non di discriminazione. Manca un immaginario comune e collettivo che consideri le nuove generazioni una risorsa e che quindi guidi la mano delle Istituzioni e della politica perché anche gli investimenti economici vadano in quella direzione con parchi gioco, centri ludici, asili nido, formazione degli insegnanti, presenza pedagogica nelle scuole, incentivi pedagogici ai genitori.
C’è da avere nostalgia di figure come Danilo Dolci, Bruno Ciari, Gianni Rodari, Mario Lodi, Alberto Manzi e don Milani il cui ricordo dovrebbe creare suggestioni per cui l’impegno educativo corrisponde a un vero e proprio impegno nel cambiamento della società. Questa consapevolezza oggi non c’è e si ritiene il mondo dei bambini, dei ragazzi e dell’educazione un mondo secondario, marginale.
Con Danilo Dolci e il nostro Centro abbiamo dimostrato che sviluppare un’educazione maieutica corrisponde a formare generazioni di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di gestire le sfide del futuro, salvare il Pianeta, vivere una cittadinanza che sappia fare dell’accoglienza un suo momento privilegiato, cercare l’alternativa a un’economia di esclusivo sfruttamento della natura e degli individui.
“‘Ognuno cresce solo se sognato’ recita un verso di una delle più famose poesie di Danilo Dolci, il lascito di questa grande figura che ci guida nella nostra azione e nella nostra speranza”.
Danilo Dolci in vita era stato soprannominato il Gandhi italiano, cosa ne pensa?
“Danilo Dolci, nella storia italiana, è una figura centrale legata alla rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale, specialmente dopo il Fascismo. L’Italia, negli anni ‘50, era un Paese che aveva subito una vera e propria violazione della sua storia millenaria, fatta di cultura, di arte e di un’economia vitale. Lui diviene il testimone di un’Italia diversa, migliore, che ha combattuto e combatte la corruzione, che valorizza le risorse degli individui, che fa parlare le persone e che crea connessioni. Tutte parole chiave del suo lavoro sociale e educativo.
Decide di consacrarsi alla causa laica dei più poveri, trascurati e abbandonati nella Sicilia occidentale, in quegli anni uno dei luoghi di maggior povertà e sottosviluppo di tutta Europa. Forte dell’esperienza con don Zeno Saltini a Nomadelfia e di un carisma assolutamente unico e indiscutibile, introduce in Italia la nonviolenza di Gandhi. Nel ’52, per protestare contro la morte di fame di una bambina nei bassi palermitani, attua la prima esperienza di digiuno gandhiano in Italia.
Sua l’idea, qualche anno dopo, dello sciopero alla rovescia, quando porta un gruppo di contadini siciliani a zappare un pezzo di terra per chiedere di poter lavorare sostenendo che era dovere dello Stato, nel rispetto dell’articolo 4 della Costituzione, dare a tutti questa possibilità.
Danilo si rende conto che deve intervenire sul sistema mafioso che opprime la Sicilia e per primo denuncia i livelli politici della mafia, raccogliendo testimonianze molto precise. Come Gandhi in India, Dolci viene osteggiato in tutti i modi, al punto da spingerlo a ritirarsi dalla scena pubblica per dedicarsi esclusivamente all’educazione con la creazione del Centro Educativo di Mirto, presso Partinico”.
Secondo lei perché la figura di Danilo Dolci è ancora confinata in un ambito di nicchia, rispetto ai grandi e più famosi pedagogisti italiani?
“Danilo Dolci non è un teorico della pedagogia o dell’educazione. È un educatore che intreccia costantemente, come tutti i grandi educatori da Pestalozzi in poi, l’azione e la riflessione. Ogni sua riflessione è assolutamente contingente a un’azione, non può esistere a prescindere da un intervento diretto, da un tentativo di innestare nella realtà dei motivi di cambiamento e di trasformazione. Da questo punto di vista, non esiste un nucleo epistemologico puro sotto il profilo pedagogico nell’esperienza di Danilo Dolci, un’esperienza com’è noto molto eclettica.
Danilo nasce prima di tutto come poeta, materiali che terrà in stand by per diversi anni per dedicarsi alacremente all’intervento sociale. Ma Danilo Dolci è anche un educatore: lo stesso impegno sociale lo porta sul versante dell’educazione in senso stretto.
Nasce come poeta, opera come animatore sociale, e muore come educatore. Però queste tre componenti sono passaggi unitari della sua vita, non c’è tra loro una sostanziale distinzione.
Se c’è una metafora che può caratterizzare l’esperienza pedagogica di Danilo Dolci è senz’altro la metafora della domanda. Possiamo definirlo come l’educatore della domanda, ossia l’educatore che innesta tutta la sua azione formativa sul chiedere, sull’esplorare, sul creare, sull’interrogazione, ovviamente non in senso scolastico, ma nel senso dello scavo, dell’andare oltre l’apparente, cercando di scoprire il “non-noto”, ciò che è velato dalle tradizioni, dalla consuetudine, dagli stereotipi”.
In Europa e nel mondo sembra non esserci più spazio per un pensiero di pace. Perché, secondo lei, è invece ancora più importante far conoscere il pensiero di Danilo Dolci?
“Non sarei così catastrofistico. Nel complesso, l’opinione pubblica, sia italiana che europea, è orientata al valore della pace. Abbiamo in Italia una Costituzione fortemente pacifista. L’Articolo 11 dichiara senza mezzi termini: l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Senz’altro, dall’invasione della Russia in Ucraina e l’inizio di questa tragicissima guerra che ha già lasciato centinaia di migliaia di morti sul terreno, il linguaggio militare è tornato a farla da padrone come se si fosse compiuto un viaggio nel tempo che ci ha riportati alla Seconda guerra mondiale. L’idea del nemico, l’appello alla vittoria, all’eroismo… Concetti semplicemente agghiaccianti e che lasciano senza fiato, tenendo conto che, alla fine degli anni Quaranta, prima di Danilo Dolci, Gandhi riuscì a liberare l’India senza violenza. Abbiamo avuto Nelson Mandela e Martin Luther King. Come ha detto il Papa, gli interessi economici sono enormi: se le armi non si usano, non si possono produrre. Siamo ancora fermi al gioco della domanda e dell’offerta. Le Borse segnalano che le azioni delle aziende produttrici di armi sono schizzate alle stelle.
A tutto questo l’opinione pubblica deve opporsi concretamente con marce, manifestazioni, iniziative. È uno dei grandi lasciti di Danilo Dolci che, all’epoca della guerra in Vietnam, organizzò una marcia della pace che attraversò tutta l’Italia, seguita da un’altra in Sicilia dopo il terremoto del Belice quando lo Stato non interveniva a favore della ricostruzione. Dobbiamo fare uno sforzo per consegnare alle nuove generazioni queste grandi figure perché la pace è un valore, ancora prima dell’ambiente. Non ci sarà nessun miglioramento nei cambiamenti climatici se la guerra dovesse diventare endemica. Bisogna spingere i politici italiani a ricordare Danilo Dolci, Aldo Capitini, don Lorenzo Milani con il suo ‘L’obbedienza non è più una virtù’.[1] La nonviolenza, come ci hanno insegnato, è il metodo più efficace anche nella gestione di un eventuale invasione nemica perché crea le condizioni affinché un eventuale invasore si trovi senza terreno sotto i piedi. Viceversa, andare allo scontro armato non fa che alimentare proprio la sua stessa cultura. L’errore che ha fatto l’Ucraina è lo stesso che ha fatto Israele reagendo così drammaticamente dopo l’uccisione di millequattrocento persone il 7 ottobre. Lo stesso che fecero gli Stati Uniti con l’invasione dell’Afghanistan dopo le Torri Gemelle. Iniziative che non sortiscono alcun effetto se non lasciare una scia di morti e arricchire i venditori di armi”.
Se l’occhio non si esercita, non vede,
pelle che non tocca, non sa,
se il sangue non immagina, si spegne.[2]
Mercoledì 26 giugno, dalle 21, ci darà un evento online dedicato ai 100 anni dalla nascita di Danilo Dolci dal titolo “Danilo Dolci. Cent’anni del Gandhi italiano”.
Nel corso della diretta Daniele Novara ripercorre l’incontro e le esperienze con Danilo Dolci, il gandhiano che ha denunciato e combattuto la mafia in Sicilia dalla fine degli anni ’50. Il testimone di uno spirito internazionalista, capace di mettere insieme le migliori risorse intellettuali per comprendere la realtà e iniziare a cambiarla.
La diretta online di mercoledì 26 giugno alle 21.00 sarà trasmessa sul canale Youtube e Facebook del CPP.
Insieme a Daniele Novara interverranno Reginaldo Palermo, vicedirettore di Tecnica della Scuola, Alex Corlazzoli, maestro di scuola primaria e giornalista. Modera Matteo Bernardelli, staff CPP.
[1] L. Milani, L’obbedienza non è più una virtù, Libreria editrice fiorentina, Firenze, 1965
[2] D. Dolci, Il limone lunare, in Creatura di creature, Corbo e Fiori Editori, Venezia 1983.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

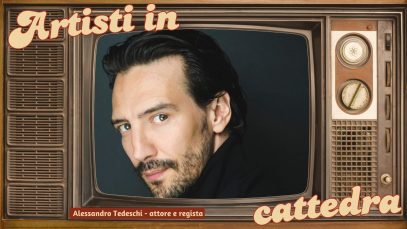
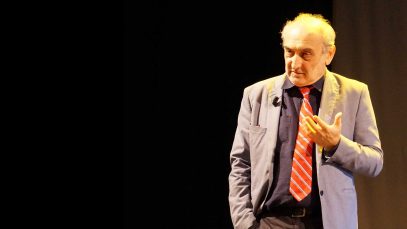
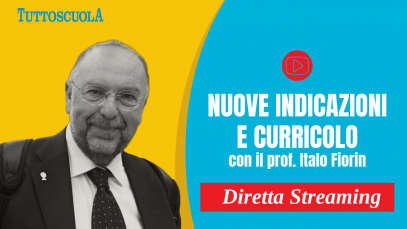




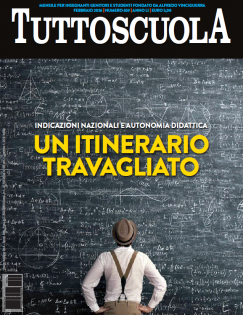




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via