
I cento linguaggi dei bambini: come l’educazione attiva trasforma il curricolo in un percorso di vita

Bambini che crescono e apprendono fin dalla nascita, all’interno di un sistema integrato 0–6 che, nonostante i divari territoriali, rappresenta un modello educativo riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Bambini felici, protagonisti di una scuola dell’infanzia e primaria che eccellono nelle rilevazioni internazionali, e tuttavia immersi in una criticità di sistema che interrompe il ciclo della primaria per introdurre una secondaria di primo e secondo grado che fatica a funzionare.
Perché? I professori, rispetto ai maestri, non cambiano soltanto nome ma anche modo di lavorare: prevalgono ancora metodologie didattiche trasmissive ormai superate, che continuiamo a mantenere a discapito di quelle attive. Certo, le Indicazioni Nazionali si rinnovano, ma si attendono riforme di ben più ampia portata che mettano i maestri al centro, a partire da una reale valorizzazione contrattuale del loro lavoro.
Serve un’inversione di modello, perché oggi tutto è cambiato: un tempo i professori si distinguevano dai maestri per la loro più estesa formazione universitaria, oggi comune a entrambe le figure. La scuola primaria italiana, soprattutto se osservata attraverso la lente dell’approccio dei cento linguaggi di Reggio Emilia, rappresenta un modello di eccellenza che ha saputo affermarsi nel panorama internazionale.
In questa visione il bambino è protagonista attivo della propria crescita, capace di esprimere pensieri e idee attraverso molteplici linguaggi: il corpo, la parola, il disegno, la musica, la narrazione, la tecnologia. Tale filosofia si lega, oggi, alla prospettiva del curricolo verticale previsto dalle Nuove Indicazioni Nazionali, che intende garantire continuità ed equilibrio tra i diversi ordini di scuola, dal nido alla primaria. La sfida educativa è quella di trasformare il percorso scolastico in un cammino coerente e fluido, capace di valorizzare la curiosità e la creatività del bambino senza spezzarne l’evoluzione.
I cento linguaggi come fondamento educativo
L’idea malaguzziana dei cento linguaggi restituisce dignità a tutte le forme espressive del bambino, riconoscendo che ogni linguaggio è una via di accesso privilegiata alla realtà e alla conoscenza. La parola non è più l’unico strumento, poiché al suo fianco si collocano l’esperienza corporea, la manipolazione dei materiali, la sperimentazione scientifica, la creazione artistica, la narrazione e la dimensione digitale.
Reggio Emilia Approach si configura, oggi, come una vera e propria grammatica pedagogica che intreccia linguaggi diversi per costruire pensieri, emozioni e significati, e che trova nell’ambiente il terzo insegnante, capace di suggerire, evocare, stimolare e documentare i processi attraverso tracce visive, fotografie, racconti e portfolio condivisi.
In questa prospettiva ogni bambino non è un recettore passivo di contenuti, ma un costruttore attivo della propria identità, delle proprie conoscenze, della propria immaginazione creativa e della propria capacità di relazione con gli altri, maturando competenze che vanno oltre l’ambito scolastico per radicarsi nella vita sociale e culturale.
Il curricolo verticale come continuità di esperienze
Le Nuove Indicazioni Nazionali del 2025 ribadiscono con forza l’importanza di un curricolo verticale, capace di garantire coerenza nella crescita degli alunni, dal nido fino alla scuola secondaria di primo grado. L’approccio dei cento linguaggi diventa in questa prospettiva una risorsa preziosa, perché assicura che l’apprendimento sia costruito come un continuum, e non come una serie di passaggi disgiunti.
Il bambino che ha sperimentato materiali, narrazioni e linguaggi all’infanzia ritrova in primaria la possibilità di rielaborarli, trasformandoli in competenze disciplinari più articolate e radicate. La verticalità del curricolo si traduce così in una continuità affettiva, cognitiva e metodologica che evita fratture e promuove un senso di appartenenza alla scuola come ambiente di crescita.
Tale prospettiva non riguarda soltanto la progressione delle conoscenze, ma investe anche la dimensione emotiva e sociale, poiché accompagnare il bambino in un percorso senza cesure significa dargli sicurezza, riconoscere la sua storia educativa e costruire un filo rosso tra i diversi ordini di scuola. In questo modo la scuola diventa una comunità di pratiche e significati che sostiene il percorso di vita e di apprendimento di ciascun alunno.
L’insegnante come regista dell’apprendimento
Nella prospettiva delle Indicazioni l’insegnante non è più solo un trasmettitore di saperi, ma un regista che organizza esperienze, tempi e ambienti per favorire il dialogo tra linguaggi e discipline. Il docente stimola la ricerca e l’autonomia, accompagna le scoperte, documenta i processi, valorizza la cooperazione tra pari e costruisce un clima di fiducia in cui l’errore diventa occasione di crescita e riflessione.
Questo ruolo implica una competenza pedagogica raffinata e una sensibilità culturale che permettono di integrare arte, scienza, tecnologia e linguaggi espressivi in un progetto unitario. L’insegnante diventa garante della continuità educativa, non solo offrendo strumenti per affrontare la complessità del presente e preparare i bambini al futuro, ma anche incoraggiando la riflessione metacognitiva, la capacità di porsi domande, la ricerca condivisa e lo sviluppo di un pensiero critico e creativo capace di orientarsi in una società in continua trasformazione e di contribuire in modo responsabile al bene comune.
L’apertura della scuola al territorio
Il modello Reggio valorizza la comunità come parte integrante dell’educazione. La scuola non è un luogo chiuso ma un laboratorio condiviso in cui bambini, famiglie e territorio dialogano, intrecciando esperienze e saperi in un tessuto comune e riconoscendo la pluralità dei contributi.
Anche le Nuove Indicazioni sottolineano l’importanza di una scuola che non isoli, ma che apra le porte al contesto circostante, diventando uno spazio vivo di relazioni, partecipazione e significati. Laboratori, atelier, progetti con associazioni culturali, enti locali e realtà produttive rafforzano la dimensione esperienziale dell’apprendimento e contribuiscono a creare una cultura educativa collettiva.
In questo modo la scuola diventa cuore pulsante della comunità, generando processi di cittadinanza attiva, di corresponsabilità educativa e di sviluppo sostenibile, con un impatto che travalica i confini scolastici per incidere nella vita sociale, culturale ed economica del territorio.
L’integrazione dei linguaggi digitali
La cultura digitale si colloca come ulteriore linguaggio che arricchisce l’esperienza dei bambini. Non si tratta di sostituire la manualità con la tecnologia, ma di integrare strumenti e contesti, offrendo nuove possibilità di espressione e ricerca che spaziano dalla produzione di immagini e video, alla programmazione, al lavoro collaborativo online e alla realtà aumentata o virtuale.
L’uso consapevole di schermi, dispositivi e ambienti digitali si innesta nel curricolo verticale come ulteriore ponte tra linguaggi, rendendo l’apprendimento più vicino alla realtà quotidiana dei bambini e sviluppando al contempo capacità critiche di selezione, interpretazione e rielaborazione delle informazioni.
In questo senso il digitale non è un semplice strumento, ma un ambiente cognitivo e culturale che amplia le capacità creative e relazionali, stimolando competenze trasversali essenziali per il futuro come la collaborazione a distanza, il pensiero computazionale, la creatività multimodale, la cittadinanza digitale e la capacità di partecipare attivamente a una società sempre più interconnessa e complessa.
L’Italia e i risultati internazionali IEA
L’influenza di Reggio Children nel mondo dimostra che l’Italia è capace di fare scuola ben oltre i propri confini, con oltre 130 paesi che hanno adottato programmi ispirati all’approccio reggiano. I dati IEA confermano la solidità della scuola primaria italiana.
Nelle rilevazioni PIRLS 2021 l’Italia ha raggiunto 537 punti in lettura alla quarta primaria, superando la media internazionale e posizionandosi ai vertici in Europa e nel mondo. Nei risultati TIMSS 2023, sempre per la quarta primaria, l’Italia ha ottenuto 513 punti in matematica e 511 in scienze, collocandosi stabilmente sopra la media internazionale.
Questi dati riflettono la qualità di una didattica attiva e laboratoriale, che coinvolge i bambini attraverso esperienze concrete, materiali e linguaggi molteplici. Se si osservano invece i dati OCSE PISA 2022, riferiti ai quindicenni, emergono criticità. L’Italia registra 471 punti in matematica, in linea con la media OCSE, 482 in lettura leggermente sopra la media, e 477 in scienze al di sotto del benchmark.
In particolare, la percentuale di studenti eccellenti ai livelli 5 e 6 è inferiore rispetto alla media internazionale. Ciò indica che le solide basi della primaria e dell’infanzia non trovano continuità nella scuola secondaria, dove prevale un modello trasmissivo che frena le potenzialità.
Una discontinuità che chiede riforme
La distanza tra i buoni risultati della primaria e le difficoltà emerse nella secondaria evidenzia la fragilità del sistema e una discontinuità che rischia di vanificare quanto costruito nei primi anni di vita scolastica. Nella fascia 0–6 e nella primaria la didattica è per necessità attiva e laboratoriale, poiché l’apprendimento nasce dall’esperienza, dall’esplorazione e dalla cooperazione tra pari.
Ma dalla scuola media (cosi come si chiamava ed è rimasta nonostante le buone intenzioni delle Indicazioni Nazionali da Cultura, Scuola, Persona, in avanti) in poi il modello cambia, tornando a privilegiare lezioni frontali, programmi rigidi e una scarsa valorizzazione dei linguaggi espressivi, artistici e digitali. Questo passaggio spezza la continuità del curricolo e rende meno efficace l’apprendimento, alimentando fenomeni di disaffezione scolastica e dispersione.
È qui che si rivela la necessità di riforme strutturali, capaci di ridisegnare il percorso scolastico estendendo il ciclo primario fino alla conclusione della scuola dell’obbligo, con un impianto unitario e continuo, sul modello dei sistemi nordici come quello finlandese e svedese, dove l’istruzione di base dura nove anni senza cesure tra primaria e secondaria inferiore.
Mantenere la figura dei maestri di riferimento dal primo anno della scuola primaria, fino alla fine del ciclo per tutta la scuola dell’obbligo, garantirebbe stabilità relazionale e pedagogica, mentre l’introduzione progressiva, attraverso moduli mirati, degli approfondimenti disciplinari consentirebbe di sviluppare competenze più specifiche senza sacrificare l’approccio laboratoriale.
Una simile scelta permetterebbe di consolidare il paradigma attivo anche oltre i primi anni, trasformando gli ambienti di apprendimento in luoghi vitali di ricerca, sperimentazione, partecipazione attiva e cittadinanza consapevole, e riducendo al contempo le disuguaglianze che spesso emergono nella fase di transizione scolastica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


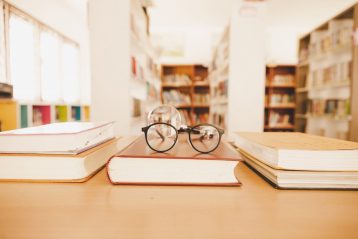











Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via