
Valutazione scolastica, una nuova visione educativa

L’anno scolastico si avvicina alla sua conclusione, e come ogni ciclo che si chiude, è tempo di tirare le somme. Le ultime verifiche prendono forma, i registri si riempiono delle ultime righe, e intanto nei corridoi e nelle aule si insinua silenziosa una riflessione: cosa abbiamo costruito insieme? Cosa resta, al di là dei voti?
La scuola ha i suoi tempi, lenti e regolari, come il ritmo del mare o il mutare delle stagioni. Ogni anno ripete le sue routine, i suoi suoni familiari, le sue piccole liturgie quotidiane. Ma sotto questa superficie regolare batte un cuore profondo, fatto di emozioni trattenute, pensieri non detti, legami che crescono e si trasformano tra le pieghe del tempo scolastico. In quel battito silenzioso vive la parte più vera dell’esperienza educativa, quella che non compare nei documenti, ma abita lo sguardo di un alunno, la voce di un’insegnante, il coraggio di un cambiamento.
In questo scenario così umano e fragile, la valutazione scolastica si presenta come uno dei momenti più delicati. Non è solo uno strumento tecnico: è una narrazione del percorso compiuto, una lente che può illuminare o oscurare. Con l’introduzione della Legge 150 del 2024, il nostro sistema si orienta verso una visione più formativa e relazionale della valutazione, più attenta ai bisogni e alle potenzialità di ciascuno. Ma ogni transizione richiede tempo, cura e consapevolezza.
Tra le novità più significative spicca la richiesta di saper costruire rubriche valutative. Non semplici griglie, ma vere e proprie architetture pedagogiche, che rendano visibile ciò che spesso è intangibile: il progresso, l’impegno, la trasformazione. Redigerle significa tradurre in parole il percorso di un apprendimento, trasformare in indicatori osservabili il viaggio interiore dello studente. È un esercizio sottile, che richiede equilibrio, competenza, sensibilità. E proprio per questo, è uno dei gesti più autentici e potenti che la scuola possa compiere per essere davvero generativa.
La valutazione nella scuola primaria, un nuovo approccio
La Legge 150/2024 ha cambiato il modo di valutare nella scuola primaria. A partire dall’ultimo scrutinio dell’anno scolastico 2024/25, gli apprendimenti, compresa l’educazione civica, saranno valutati con giudizi brevi e chiari su sei livelli: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente.
Questi giudizi saranno accompagnati da semplici descrizioni, legate al curricolo della scuola, e faranno riferimento a quattro aspetti principali: quanto bene l’alunno conosce l’argomento, come usa il linguaggio, quanto è autonomo e se riesce a rielaborare ciò che ha imparato. In alcuni casi, potranno essere aggiunti anche i traguardi di apprendimento raggiunti.
Ogni scuola dovrà creare griglie di valutazione (rubriche) per ogni disciplina e per ogni classe. Ad esempio, in prima elementare, in italiano, “Buono” può significare che l’alunno capisce semplici testi e scrive frasi corrette. In terza, in matematica, “Discreto” può indicare che conosce i concetti ma ha ancora bisogno di aiuto. In quarta, in scienze, “Ottimo” può voler dire che osserva, capisce e rielabora con sicurezza.
La valutazione serve così ad aiutare a imparare meglio, non solo a dare un voto. Deve guidare l’insegnante a proporre attività più adatte e personalizzate. Il collegio dei docenti ha il compito di deliberare i criteri da seguire e inserirli nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Anche il comportamento sarà valutato in modo sintetico, considerando quanto l’alunno sviluppa le competenze di cittadinanza. Rimangono uguali le modalità di valutazione per religione cattolica, attività alternativa alla stessa e per il giudizio generale.
Per gli alunni con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), la valutazione dovrà tenere conto dei loro obiettivi personalizzati, come indicato nei piani individuali (PEI o PDP). Inoltre, sarà data più importanza alle osservazioni quotidiane e alle prove durante l’anno.
Le nuove modalità entreranno in vigore nell’ultimo periodo del 2024/25. Le scuole dovranno aggiornare i documenti ufficiali, i registri e il PTOF, e spiegare bene alle famiglie come funzionano le nuove regole.
Le novità per la scuola secondaria, tra comportamento e responsabilità
Nella scuola secondaria di primo grado, la Legge 150/2024 ha innovato la valutazione del comportamento reintroducendo il voto espresso in decimi, superando il precedente giudizio sintetico. Questo voto, assegnato al termine di ciascun periodo didattico, assume un ruolo centrale nell’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Il legislatore ha stabilito che un voto inferiore a sei decimi comporta automaticamente la non ammissione, anche qualora tutte le discipline curricolari siano sufficienti. Tale valutazione deve tener conto dell’intero anno scolastico, includendo eventuali episodi sanzionati disciplinarmente e il comportamento quotidiano dell’alunno. Il Consiglio di classe è pertanto chiamato ad assumere una posizione deliberativa collegiale, fondata su elementi documentabili e coerenti con i regolamenti interni.
Nella scuola secondaria di secondo grado, la disciplina resta sostanzialmente invariata, ma con un’importante novità: per gli studenti che ottengono un voto di comportamento pari a sei decimi, è previsto l’obbligo di presentare un elaborato critico su tematiche inerenti alla cittadinanza attiva e solidale. Tale produzione, da valutarsi entro l’anno scolastico, ha valore formativo e rappresenta un’occasione per riflettere sul senso civico e la partecipazione democratica. La mancata consegna dell’elaborato comporta la non ammissione all’anno successivo o all’esame di Stato, ribadendo così la centralità delle competenze trasversali e del comportamento responsabile all’interno del percorso scolastico.
È importante notare che, ai sensi dell’art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dalla legge n. 150/2024, il punteggio più alto all’interno della fascia di attribuzione del credito scolastico, basato sulla media dei voti dello scrutinio finale, può essere assegnato se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi. Questa disposizione si applica anche agli studenti frequentanti il terzultimo e penultimo anno.
Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della propria autonomia e in coerenza con quanto disposto dal DPR 275/1999, deliberano criteri e modalità di valutazione del comportamento. Tali criteri devono ispirarsi allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti interni, favorendo pratiche condivise, coerenti e trasparenti. Si raccomanda, inoltre, di adottare rubriche valutative articolate, che rendano esplicite le aspettative comportamentali e aiutino gli studenti a maturare una consapevolezza progressiva del proprio ruolo all’interno della comunità scolastica.
Valutazione e neuroscienze: comprendere per educare
Le neuroscienze offrono preziose indicazioni per comprendere come la valutazione influenzi i processi di apprendimento. Studi nel campo della neuroeducazione hanno dimostrato che l’attivazione emotiva durante l’apprendimento incide direttamente sulla memoria a lungo termine e sulla plasticità cerebrale. Le emozioni positive, come la gratificazione, la fiducia e la curiosità, promuovono la produzione di dopamina e altri neurotrasmettitori che facilitano l’acquisizione e la ritenzione delle informazioni. Di contro, la paura del giudizio o dell’insuccesso attiva l’amigdala, il centro della risposta allo stress, che può inibire l’accesso alla corteccia prefrontale, responsabile del pensiero logico e della risoluzione dei problemi.
Una valutazione percepita come minacciosa, focalizzata sull’errore e sul confronto competitivo, può generare ansia da prestazione e blocchi cognitivi. Questo effetto è particolarmente evidente nei bambini e nei soggetti con fragilità emotive o insicurezze pregresse, che rischiano di interiorizzare una rappresentazione negativa di sé. Al contrario, un ambiente valutativo positivo e supportivo, centrato sul miglioramento continuo e sul riconoscimento degli sforzi, stimola l’apprendimento significativo e l’autoefficacia.
Un altro aspetto rilevante riguarda il tempo della valutazione: secondo recenti studi, l’immediatezza e la coerenza del feedback favoriscono il consolidamento delle tracce mnestiche e orientano il comportamento futuro. Per questo motivo, la valutazione formativa, distribuita nel tempo e fondata sul dialogo, rappresenta un potente strumento di accompagnamento cognitivo ed emotivo. Essa non solo misura, ma educa il cervello a imparare meglio e con maggiore consapevolezza.
Aspetti psicologici e pedagogici della valutazione
Dal punto di vista psicologico, la valutazione incide profondamente sull’autostima, sull’autoefficacia e sull’immagine di sé degli studenti. Una valutazione equa, motivante e trasparente può rafforzare la fiducia nelle proprie capacità, attivando un circolo virtuoso di apprendimento e crescita personale. Al contrario, una valutazione percepita come punitiva, poco chiara o focalizzata esclusivamente sugli errori, rischia di generare vissuti di inadeguatezza, ansia da prestazione e, nei casi più gravi, disaffezione verso la scuola e demotivazione.
Sul piano pedagogico, la valutazione dovrebbe essere concepita come un momento integrato e continuo del processo di insegnamento-apprendimento. Essa non rappresenta una semplice verifica conclusiva, ma uno strumento dinamico per monitorare i progressi, riflettere sulle strategie adottate, sostenere il recupero e promuovere l’eccellenza. In tal senso, il ruolo del docente si configura sempre più come guida e mediatore del significato, in grado di restituire all’alunno un’immagine positiva e costruttiva del proprio percorso.
Un approccio formativo alla valutazione valorizza il feedback tempestivo e personalizzato, l’autovalutazione e la valutazione tra pari. Tali pratiche non solo favoriscono l’apprendimento attivo e la responsabilizzazione degli studenti, ma li aiutano a sviluppare competenze metacognitive fondamentali, come la consapevolezza dei propri punti di forza e delle aree di miglioramento, la capacità di auto-regolarsi, di porsi obiettivi realistici e di riformulare le proprie strategie di studio. In definitiva, una valutazione pensata in chiave educativa contribuisce allo sviluppo integrale della persona, promuovendo l’empatia, la resilienza e il senso di appartenenza alla comunità scolastica.
Conclusione
La valutazione si conferma un pilastro del processo educativo, influenzando in modo decisivo non solo gli esiti scolastici, ma anche la crescita integrale dello studente. Essa assume un valore formativo autentico quando diventa occasione di consapevolezza, riflessione e orientamento, e non si limita alla funzione certificativa. La Legge 150/2024, insieme alla successiva ordinanza ministeriale n. 3 del 2025, segna una svolta verso una valutazione più umana, coerente con i traguardi di competenza del curricolo nazionale, capace di coniugare rigore e attenzione alla persona.
L’impianto normativo richiama con forza l’importanza di una valutazione chiara, trasparente, calibrata sui reali bisogni formativi, che sappia accogliere la diversità e riconoscere i talenti. Tuttavia, perché questa riforma possa incidere realmente sulle prassi didattiche, è indispensabile che le scuole e i docenti assumano una postura pedagogica rinnovata, fondata su empatia, ascolto, osservazione qualitativa e dialogo. La valutazione deve diventare il tempo della relazione educativa, un’opportunità per accendere la motivazione e promuovere il benessere scolastico.
Solo una valutazione che integra le dimensioni cognitive, affettive e sociali può ambire a sostenere percorsi inclusivi ed equi. A tale fine, l’alleanza tra ricerca neuroscientifica, riflessione pedagogica e autonomia didattica diventa fondamentale per garantire a ogni studente la possibilità di crescere, apprendere e sentirsi valorizzato nella propria unicità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA









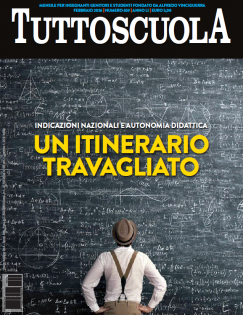




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via