
Raccontare per pensare. L’uso metacognitivo della narrazione orale nei bambini dai 3 ai 5 anni

C’era una volta…
Non è solo l’inizio di una fiaba, ma l’ingresso in un tempo sospeso, in cui tutto può ancora accadere. È la porta socchiusa su un altrove dove il reale e l’immaginario si intrecciano in una danza silenziosa, e dove la logica lascia spazio alla meraviglia. È il tempo dell’infanzia, quello in cui le parole non sono solo suoni, ma magie che danno forma al mondo. E anche se oggi quel tempo sembra lontano, vive ancora in ogni bambino che ascolta, in ogni adulto che ricorda. Perché chi custodisce la scintilla della narrazione conserva anche la possibilità di immaginare, di comprendere, di pensare.
Viviamo immersi in un’epoca che corre, che riassume, che riduce. I messaggi si accorciano, il linguaggio si appiattisce, le emozioni si sintetizzano in emoji. La comunicazione si è fatta immagine, gesto, suono digitale. In questo contesto così rapido e visivo, la narrazione orale sembra appartenere a un passato polveroso, un’attività da bambini, un gioco senza utilità. Ma proprio oggi, nel cuore di questa crisi del linguaggio, raccontare diventa un atto rivoluzionario.
Nei primi anni di vita, tra i tre e i cinque anni, narrare non è solo un modo per intrattenere ma rappresenta un gesto educativo profondo, fondativo. Attraverso la parola narrata, il bambino inizia a mettere ordine nel caos dell’esperienza, a costruire legami tra ciò che accade fuori e ciò che accade dentro. La narrazione è il primo tentativo di dare un senso alla realtà, di cucire insieme emozioni e fatti, di immaginare ciò che non è ancora ma potrebbe essere.
Raccontare è, per il bambino, un atto di pensiero. Un gioco serio. Una forma di conoscenza vissuta. Mentre ascolta o inventa storie, il bambino esercita l’introspezione, si specchia nei personaggi, formula ipotesi, esplora alternative. E lo fa naturalmente, spontaneamente, senza bisogno di istruzioni. La narrazione accende la mente, stimola il linguaggio, struttura la memoria, attiva i primi rudimenti della metacognizione: il pensiero che riflette su se stesso.
Non c’è nulla di ingenuo o di secondario nel raccontare. È un atto pedagogico e cognitivo potentissimo, capace di accompagnare la crescita ma anche di guidarla. Raccontare significa donare senso, creare legami, costruire consapevolezza. Significa immaginare il mondo per poi imparare ad abitarlo. In questo saggio, esploreremo il valore metacognitivo della narrazione orale nella prima infanzia, mostrando come essa non sia solo un ponte verso la comprensione, ma anche una radice profonda dell’identità in formazione. Perché ogni storia raccontata è anche una storia che ci racconta.
Il potere della narrazione nella prima infanzia
Sin dai primi anni, i bambini sono immersi in un mondo di parole. Le storie raccontate dagli adulti, le favole inventate nel gioco simbolico, i racconti autobiografici che emergono nei momenti di condivisione quotidiana rappresentano una palestra fondamentale per lo sviluppo del pensiero. La narrazione non è soltanto un atto linguistico bensì un processo cognitivo che consente al bambino di organizzare mentalmente le esperienze, di trasformarle in eventi significativi, di collocarle in una sequenza temporale coerente. In questo senso, il racconto diventa una forma primitiva di pensiero narrativo, in cui fantasia e realtà si intrecciano per produrre significato. Il bambino, mentre narra, esercita la propria capacità di categorizzare, di selezionare, di interpretare. Le prime forme di logica, la comprensione della consequenzialità e la capacità di anticipare scenari futuri si sviluppano proprio attraverso questa pratica. La narrazione si rivela così non solo un’esperienza emotiva, ma una potente leva di crescita cognitiva.
Raccontare per comprendere il sé
Nel raccontare, il bambino costruisce progressivamente un’immagine di sé che non è fissa o definitiva, ma dinamica e in continuo divenire. Ogni storia narrata diventa una finestra aperta sull’interiorità, uno spazio simbolico dove emozioni, paure, desideri e vissuti trovano rappresentazione e prendono forma. Il racconto consente al bambino di esplorare ciò che prova, senza necessariamente doverlo dichiarare apertamente, permettendogli di parlare di sé attraverso personaggi immaginari, vicende fantastiche, animali parlanti o supereroi. Questo consente di mantenere una distanza di sicurezza affettiva e, al tempo stesso, di accedere a contenuti profondi e autentici.
I personaggi delle storie, così come i conflitti e le soluzioni immaginate, riflettono spesso il mondo interno del bambino. In essi si specchiano bisogni di riconoscimento, paure di separazione, desideri di appartenenza, esperienze non elaborate. Raccontare, dunque, non è un’attività neutra, ma una forma di elaborazione simbolica e narrativa dell’identità. In questa pratica, il bambino apprende a riconoscere e a nominare le proprie emozioni, ad articolare nessi tra eventi, pensieri e stati d’animo, a differenziare le cause dalle conseguenze. Si attiva così una prima forma di consapevolezza affettiva, che costituisce la base per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva.
La narrazione, inoltre, permette di rielaborare esperienze complesse, a volte traumatiche, che non trovano facilmente spazio nella comunicazione diretta. Attraverso il racconto, il bambino può riscrivere simbolicamente ciò che ha vissuto, trasformare la paura in coraggio, il fallimento in apprendimento, il dolore in speranza. Questa possibilità immaginativa nutre anche il senso di autoefficacia, cioè la percezione di poter agire sul mondo e su di sé in modo trasformativo. Raccontare diventa così un esercizio di pensiero prospettico nel quale si impara non solo a comprendere ciò che è accaduto, ma anche a proiettarsi nel futuro, a immaginare possibilità alternative, a prendere decisioni narrative che modellano la propria identità.
Il sé narrante, nei bambini, non si costruisce mai in solitudine. È nella relazione con l’altro, nel contesto di un dialogo fatto di parole, ascolto autentico e riconoscimento empatico, che la voce interiore prende corpo. L’adulto che ascolta senza giudicare, che accoglie senza correggere, diventa specchio e sostegno, favorendo un processo di costruzione identitaria profondo e duraturo. Così, la narrazione orale si configura come uno spazio relazionale privilegiato, in cui il bambino non solo racconta chi è, ma diventa ciò che racconta.
La narrazione come palestra linguistica
Sul piano linguistico, la narrazione orale rappresenta un contesto privilegiato per l’apprendimento e il consolidamento delle competenze comunicative, poiché offre al bambino un ambiente autentico e motivante in cui la lingua viene utilizzata con finalità reali e relazionali. Il bambino che narra è chiamato a esercitare una complessa gamma di abilità, scegliendo con cura le parole, organizzando logicamente il discorso, adattandolo all’interlocutore e sostenendo l’attenzione narrativa nel tempo. In questo processo, il linguaggio non viene semplicemente appreso, ma vissuto come strumento espressivo, cognitivo e sociale.
La struttura della narrazione, con il suo schema canonico di apertura, sviluppo e chiusura, rappresenta una forma archetipica attraverso cui il bambino impara a costruire discorsi coerenti e coesi. L’uso di connettivi logici e temporali, l’impiego corretto dei tempi verbali e la scelta lessicale contestuale diventano competenze linguistiche che si affinano attraverso la pratica e l’ascolto. Inoltre, raccontare stimola la padronanza metalinguistica: il bambino inizia a riflettere sulla lingua che usa, distinguendo tra diversi registri, tra il parlato quotidiano e il linguaggio narrativo, tra la forma e il contenuto.
L’ascolto delle storie raccontate dagli altri, siano esse prodotte da coetanei o adulti, rappresenta un’occasione preziosa per l’arricchimento lessicale, l’acquisizione di nuove strutture sintattiche e la comprensione di punti di vista differenti. Questo esercizio di decentramento cognitivo, che implica la capacità di immedesimarsi in personaggi e situazioni diverse dalle proprie, costituisce una premessa fondamentale per lo sviluppo dell’empatia e del pensiero narrativo.
Infine, la narrazione orale assume anche una funzione sociale imprescindibile poichè attraverso il racconto, il bambino sperimenta la possibilità di comunicare emozioni, condividere esperienze, negoziare significati. Il linguaggio, in questo senso, diventa un ponte tra sé e gli altri, tra l’individuo e la comunità. La narrazione si configura dunque come una pratica linguistica che è, al tempo stesso, personale e collettiva, creativa e regolata, spontanea e culturalmente strutturata.
Il racconto come spazio per pensare
Oltre a favorire la crescita linguistica ed emotiva, la narrazione attiva precoci e significative forme di metacognizione, ossia la capacità del bambino di riflettere sul proprio pensiero, sulle proprie azioni cognitive e sulle strategie che mette in atto per comprendere e raccontare la realtà. Quando il bambino costruisce una storia, non si limita a usare il linguaggio come veicolo passivo di contenuti, ma è chiamato a gestire una complessa attività mentale: deve pianificare la trama, monitorare la coerenza tra gli eventi, decidere come esprimere le emozioni dei personaggi e mantenere una logica interna che renda il racconto comprensibile.
Questo processo implica attenzione sostenuta, autocontrollo esecutivo, e soprattutto consapevolezza dei propri stati mentali e di quelli altrui. In altre parole, la narrazione diventa uno spazio privilegiato in cui il bambino inizia a pensare sul proprio pensiero, sviluppando una forma embrionale di autoregolazione cognitiva. Tale consapevolezza, ancora in fase emergente nella fascia d’età prescolare, si sviluppa gradualmente grazie all’interazione con un adulto significativo: un educatore, un genitore, un insegnante che non si limita ad ascoltare, ma rilancia con domande, valorizza ogni contributo, guida la riflessione.
Un adulto che sa accompagnare la narrazione con uno stile dialogico e non direttivo, aiuta il bambino a esplicitare i propri ragionamenti, a riformularli in maniera più chiara, a mettersi nei panni dell’ascoltatore. Raccontare diventa allora un vero e proprio laboratorio cognitivo, un esercizio concreto di metacognizione, in cui si apprendono strategie di problem solving, si confrontano ipotesi, si costruiscono nessi causali e si sperimentano nuove possibilità di rappresentazione della realtà. La metacognizione, che sarà fondamentale per gli apprendimenti scolastici futuri, trova nella narrazione le sue radici più profonde, nutrite dal piacere ludico del racconto condiviso, dalla relazione affettiva con l’adulto e dalla soddisfazione di dare senso alla propria esperienza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


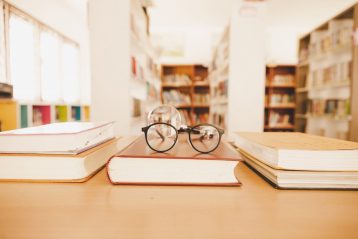











Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via