
Il latino, una necessità culturale, pedagogica ed esistenziale
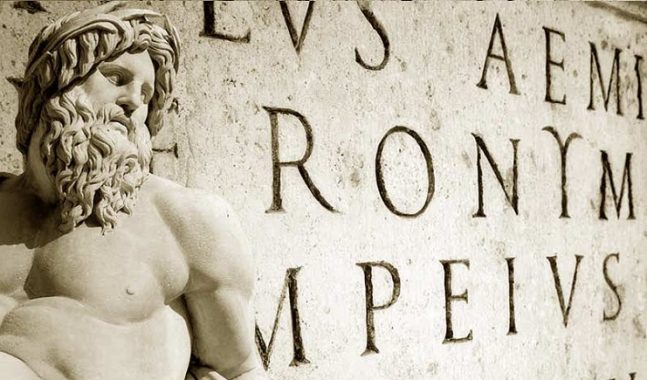
di Anna Paola Tantucci, Presidente E.I.P Italia
——————————————–
Nell’edizione cartacea del numero di settembre 2025 della rivista Tuttoscuola è stato pubblicato un intervento della Prof.ssa Anna Paola Tantucci sul ruolo del latino nel nostro tempo e nella scuola, a commento della pubblicazione delle nuove Indicazioni per il primo ciclo e come contributo alla preparazione per quelle del quinquennio superiore.
Lo riproponiamo qui per l’indubbio interesse per l’ampio pubblico di tuttoscuola.com. Nella rivista cartacea l’intervento è stato suddiviso per ragioni giornalistiche in tre parti, con la firma dell’Autrice alla fine della terza parte. Si tratta di un unico contributo, interamente attribuibile ad Anna Paola Tantucci. Ci scusiamo se l’impaginazione ha reso poco chiara la maternità dell’intervento pubblicato.
——————————
Nell’attuale dibattito educativo, la reintroduzione del Latino nella Scuola secondaria di I grado, emersa nel testo delle Nuove Indicazioni Nazionali, ha riacceso l’urgenza di una profonda riflessione sul ruolo e il valore di questa disciplina nel XXI secolo. Sarebbe riduttivo e capzioso parlare di un mero “ritorno al passato”, e ritengo che occorra dirigere la riflessione verso il riconoscimento del valore intrinseco del Latino come strumento formativo. Questa scelta ministeriale ci chiede di andare oltre i preconcetti e di esplorare come lo studio di una lingua considerata “antica” possa in realtà offrire risposte concrete alle sfide del presente. Come sottolineato dalle stesse Indicazioni, “Ripensare il ruolo del latino nella scuola del XXI secolo è compito necessario e quanto mai attuale, perché incrocia questioni basilari come la conoscenza e la valorizzazione della lingua e della cultura italiana, anche in prospettiva storica, e il rapporto tra la cultura italiana e quelle europee“.
È proprio da questa consapevolezza che intendiamo partire, per dimostrare come il Latino non sia solo una “palestra per la mente”, ma una vera e propria necessità culturale, pedagogica ed esistenziale per la formazione dei cittadini di oggi e di domani.
1. Latino come necessità culturale
La lingua latina discende, in senso genealogico, da una lingua scomparsa, la lingua indoeuropea comune. Affermatasi in un piccolo territorio intorno a Roma, si è sviluppata lungo l’arco dei secoli, prestandosi via via a esprimere ogni attività di pensiero, a significare ogni fatto della vita e a dare forma letteraria a ogni concepimento d’arte. Come ebbe a scrivere il fine latinista Ettore Bignone “La lingua di questo popolo di così umili princìpi, rincantucciato in origine in un angoletto della penisola, quasi soffocata fra l’osco, l’etrusco e l’umbro che è parlato quasi sino alle porte di Roma, diviene la lingua di un grande impero: la lingua che ha la più ricca storia civile e che ha compiuta la più vasta, durevole missione culturale nel corso di millenni“.
Originariamente lingua di oscuri agricoltori e commercianti, il latino, più di ogni altro linguaggio della famiglia indoeuropea da cui deriva, ha tenuto fede alle tradizioni di questo grande popolo, conquistatore spirituale e civilizzatore del mondo. Si è arricchita nei contatti con le popolazioni vicine, non temendo di assumere da Sabini, Etruschi, Galli e, soprattutto, Greci ciò che le era utile, mantenendo però sempre salda la sua unità.
Con l’espandersi dell’Impero, il latino divenne la lingua di tutto l’impero romano: lingua dell’esercito, dell’amministrazione, del diritto, dell’eloquenza forense, della civiltà e della letteratura romana.
Si estese dalla Gallia alla Spagna, sul Danubio, nell’Illiria, nella Dacia e nell’Africa romana.
L’avvento del Cristianesimo ne segnò ulteriormente la dimensione, rendendola la lingua religiosa di tutto il mondo unificato dalla fede cristiana, “cattolico” nel senso proprio della parola.
Al dissolversi dell’Impero romano, la lingua latina sopravvisse, divenendo una vera e propria essenza e potenza spirituale, che andava oltre la dimensione politica e, per secoli, rimase la sola lingua di cultura di tutta l’Europa.
Dopo una vita millenaria e un’agonia durata secoli, dissolvendosi come parlata viva, diede origine alle lingue letterarie europee: italiano, rumeno, francese, spagnolo, portoghese, provenzale.
Le maggiori di queste lingue, conservando la tradizione spirituale di Roma e, in varia misura, il genio civile di Roma, si estesero per il mondo, conquistando nuove regioni e civilizzando nuovi continenti attraverso coloro che le parlavano.
Il “capolavoro di Roma” non fu solo l’aver creato una volta l’unità politica del mondo antico, ma l’aver creato e mantenuto per millenni, e ancora oggi, l’unità spirituale della civiltà europea e in gran parte mondiale. Questo capolavoro si è propagato nello spirito della civiltà romana (sebbene fecondata anche da popoli di altre stirpi che contribuirono in non minor misura alla cultura mondiale), nei modi di sentire e di pensare diffusi dalle letterature che da essa sono sorte o si sono nutrite, nell’uso della sua lingua per secoli nelle scienze e nella più alta cultura, e nella diffusione e unità della religione cattolica.
La lezione più significativa di Roma, quella che l’ha portata da villaggio agreste a diventare “urbs” e poi “orbis” (mondo intero), risiede nella sua concezione di cittadinanza. A differenza dei Greci, infatti, per i quali i cittadini erano solo gli indigeni nati nella propria terra (“indi-genos“), per i Romani si diventava cittadini “per legge”. Questa attitudine a ricevere e assimilare ciò che era straniero – fossero Greci o barbari – ha permesso ai Romani di essere universali e rende Roma il modello culturale originario dell’Occidente e dell’Europa, più che Atene o Gerusalemme.
Il latino è la lingua da cui deriva l’italiano, lingua che ha mantenuto al meglio, tra tutte le lingue romanze, le caratteristiche del latino. Studiare il latino, quindi, permette di comprendere meglio il funzionamento dell’italiano, la sua sintassi e la formazione delle parole.
In un contesto socio-culturale in cui i social media promuovono un consumo rapido e superficiale delle informazioni, il latino insegna la pazienza di riflettere su un testo, richiede di scegliere il vocabolo più pertinente, rende capaci di analizzare un brano per distinguere il vero dal falso, e in sostanza, aiuta ad “andare oltre” la superficie. Ci porta ad essere intelligenti, nel senso etimologico di capaci di “intus legere“, cioè a leggere in profondità.
Come affermava Carlo Levi: “Il futuro ha un cuore antico”.
Il latino non è affatto una lingua morta, ma una palestra ricca di strumenti che guidano gli studenti all’acquisizione di competenze che vanno ben oltre il semplice studio di una lingua antica. Attraverso il latino si rafforzano le capacità linguistiche, si sviluppa il pensiero logico e la capacità di analizzare e risolvere problemi, si potenzia la memoria e la concentrazione, e si diventa più consapevoli della storia e dell’identità culturale. Inoltre, la letteratura latina è alla base della letteratura italiana ed occidentale (comprendendo le due Americhe) e fornisce coordinate culturali fondamentali per capire la storia e il pensiero.
Il confronto con le lingue vive non è appropriato, poiché si tratta di due tipi di competenze diverse: lo studio del latino, una “lingua chiusa” ma non morta, è una “riflessione sulla lingua”, mentre lo studio di una lingua viva parlata mira a “imparare a parlarla”.
La lingua latina, oltre a rivelare i tesori della civiltà da cui deriviamo, è, dal punto di vista didattico, preparatoria dello spirito del giovane studente a tutte le conquiste che farà negli anni nei vari campi del sapere. È fonte di una tradizione culturale e testimonianza dell’uomo che, pensando, si esprime e si rivela a se stesso.
2. Latino come necessità pedagogica
La percezione comune del latino è quella di una materia ostica, un retaggio del passato, qualcosa di “inutile” nel mondo frenetico e iperconnesso in cui viviamo. Tuttavia, il latino è in realtà una palestra mentale incredibilmente efficace, un potente strumento per lo sviluppo critico e per la formazione di cittadini capaci di affrontare le complessità del mondo.
A differenza dell’italiano, che ha un ordine di parole relativamente fisso, il latino gioca con la flessibilità della sintassi, e questa non è un difetto, ma una virtù. Per tradurre una frase, lo studente non può limitarsi a un’associazione meccanica, ma deve analizzare la funzione grammaticale di ogni singola parola, decodificare le desinenze e comprendere le relazioni logiche. Ogni singola frase latina diventa un piccolo problema logico da risolvere, un esercizio costante di “problem solving” che affina la capacità di ragionamento e il pensiero critico.
Il latino è anche un ponte che collega i nostri studenti a un mondo di lingue e culture. È la base solida per l’apprendimento di tutte le lingue romanze – spagnolo, francese, portoghese, rumeno – che condividono la stessa radice.
Ma non solo: anche l’inglese, pur essendo una lingua germanica, possiede un’enorme quantità di lessico di derivazione latina, specialmente nei termini più formali e accademici. E, al di là del lessico, il latino insegna un metodo di analisi linguistica che è trasferibile e prezioso per l’apprendimento di qualsiasi lingua futura.
Il latino non è una materia che permette superficialità. Richiede disciplina, impegno costante e un’attenzione quasi maniacale ai dettagli. Questo rigore non è una punizione, ma una virtù pedagogica: educa lo studente alla perseveranza di fronte alle difficoltà, alla precisione nell’analisi e alla resilienza nel superare gli ostacoli. Tutte queste abilità si traducono in un miglioramento generale del metodo di studio, fondamentali per il successo in qualsiasi ambito accademico e professionale.
Potrebbe sembrare un paradosso, ma il latino è incredibilmente pertinente nell’era digitale. In un mondo sommerso da informazioni, la capacità di filtrare e analizzare criticamente testi complessi, affinata con il latino, è più che mai preziosa. Inoltre, moltissimi linguaggi specialistici – dalla medicina al diritto, dalla scienza alla tecnologia – sono intrisi di terminologia di origine latina. Persino nel campo dell’intelligenza artificiale, la comprensione di strutture logiche e grammaticali chiare può essere un vantaggio sorprendente. Il latino ci insegna a pensare in modo strutturato, un’abilità cruciale per i “nativi digitali”.
3. Latino come necessità esistenziale
La scuola è il luogo d’elezione per scoprire se stessi e il mondo. Montaigne, nel XVI secolo, si pose una domanda molto attuale: “Come possiamo tutelarci dal diventare un giorno scienziati senza conoscenza, magistrati senza giurisdizione e comici senza commedia?“.
Oggi, nell’era del “monoteismo tecnologico”, la sfida è formare persone intelligenti e libere, non gregarie, capaci di gestire o ribellarsi a macchine più o meno intelligenti.
Per questo, si può immaginare una scuola che recuperi i “perché”, che insegni a cogliere la profondità e la relazione tra le cose, che scopra il valore del passato e della memoria e insieme si impegni a inventare il futuro.
Possiamo fare nostra la proposta di Ivano Dionigi nel recente volume dedicato alla figura del “Magister”. Egli, in alternativa ad uno slogan degli anni ‘90 dedicato al futuro della scuola (Inglese, Internet, Impresa) propone “tre I” come fondamenti su cui costruire “teste ben fatte”, come auspicato da Montaigne prima di Morin: Interrogare, Intelligere, Invenire.
Lo studio del Latino non è solo assimilazione passiva di nozioni, ma un invito costante a interrogare il testo, la storia, e di conseguenza, noi stessi. È un esercizio di pensiero critico che spinge a non accontentarsi di risposte superficiali, ma a scavare più a fondo. Interrogare la lingua latina significa anche interrogare le radici del nostro pensiero e della nostra cultura. Come ci ricorda Seneca: “Quid est ergo bonum? Rerum scientia. Quid malum? Rerum ignorantia. Quid est virtus? Rerum scientia. Quid est vitium? Rerum ignorantia“. La “scientia” è il bene e l'”ignorantia” è il male. Per acquisire conoscenza, dobbiamo porci domande, e il latino ci costringe a farlo, richiedendo indagine e “messa in discussione” delle parole, della sintassi e del contesto storico.
4. Conclusioni: un investimento per il futuro
In definitiva, il latino non è un peso del passato, ma un investimento prezioso nel futuro dei nostri studenti. Sviluppa competenze chiave come la logica, la precisione, una profonda comprensione linguistica e un raffinato pensiero critico. Offre un arricchimento culturale inestimabile, collegandoci direttamente alle radici della nostra civiltà. È una preparazione fondamentale per affrontare la complessità del mondo moderno. Il latino è un tesoro culturale, pedagogico e umanistico che merita di essere quotidianamente scoperto e valorizzato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA








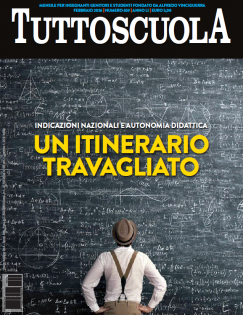




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via