
La collegialità tradita. Quando la collaborazione si ferma alla carta
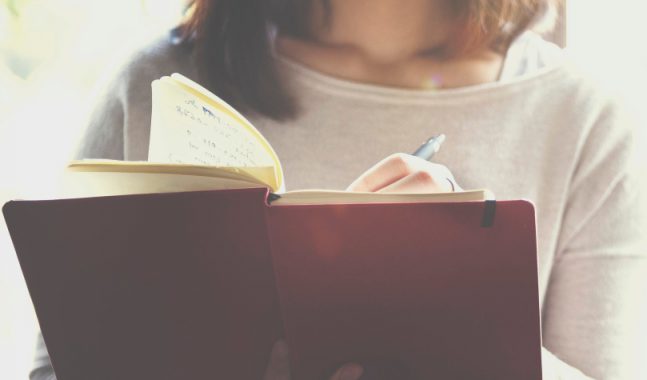
La collegialità è stata a lungo considerata uno dei pilastri delle istituzioni democratiche e partecipative, poiché rappresenta l’antidoto naturale al rischio di autoreferenzialità e di concentrazione del potere nelle mani di pochi. Essa concretizza un principio di uguaglianza sostanziale, dove ogni voce, indipendentemente dal ruolo, dal grado di esperienza o dall’anzianità, ha il diritto e il dovere di essere ascoltata. Ogni decisione prende così forma dall’incontro e dal confronto tra prospettive differenti, generando non solo un risultato più equo ma anche più ricco.
Nel contesto educativo questo ideale assume una valenza decisiva, perché la scuola non è soltanto luogo di trasmissione del sapere, bensì spazio di crescita democratica, di educazione alla cittadinanza e di apprendimento della convivenza civile. Eppure, ciò che accade nella pratica spesso disattende queste premesse: la collegialità rimane confinata nei documenti ufficiali, proclamata nelle norme e nei regolamenti, ma raramente diventa esperienza viva e concreta. Questo scarto tra l’ideale e la realtà produce un tradimento silenzioso, che mina la credibilità delle istituzioni, disorienta chi le vive dall’interno e finisce per impoverire il tessuto comunitario.
Il significato autentico della collegialità
Per comprendere davvero cosa significhi collegialità occorre liberarla da interpretazioni riduttive che la assimilano alla semplice presenza a una riunione o al gesto formale della firma di un verbale. La collegialità autentica è innanzitutto un atteggiamento culturale, una disposizione interiore a considerare il bene comune come superiore agli interessi individuali.
Essa nasce dalla consapevolezza che nessuno possiede da solo la verità o la soluzione ai problemi, ma che ogni percorso decisionale necessita di essere arricchito da molteplici voci. Nel mondo scolastico questo principio è particolarmente evidente, poichè la crescita di uno studente non può dipendere da una sola prospettiva, ma necessita di un intreccio di competenze, sensibilità e metodologie differenti.
Un docente di matematica, un docente di lettere e un docente di scienze, sebbene muovano da saperi specifici, concorrono insieme a definire un progetto unitario, capace di guardare allo sviluppo integrale della persona. La collegialità autentica, dunque, non coincide con l’unanimità, spesso frutto di conformismo, ma con il coraggio di mettere in dialogo posizioni diverse, talvolta opposte, per giungere a una sintesi più ricca, più solida e più feconda.
L’illusione delle procedure
Il tradimento della collegialità si manifesta in tutta la sua evidenza quando essa viene ridotta a una sequenza di procedure burocratiche che certificano la forma, ma tradiscono la sostanza. Le riunioni, nate per essere luoghi di dialogo e di elaborazione condivisa, si trasformano in momenti di ratifica di decisioni già prese altrove. In molti casi a determinare la linea non è l’intera comunità, ma una ristretta cerchia di persone o, più semplicemente, un singolo, che per ruolo o consuetudine assume su di sé il potere di stabilire le scelte.
I verbali, in questi contesti, diventano atti notarili che sanciscono un accordo mai realmente discusso, producendo una parvenza di partecipazione che nasconde, invece, l’assenza di un confronto reale. Tutto appare regolare dal punto di vista normativo, ma nulla rispecchia la sostanza viva di un processo collegiale. A questo si somma la ritualità sterile delle convocazioni obbligatorie, che trasformano l’appuntamento in un dovere da assolvere senza convinzione, spesso vissuto con fastidio e rassegnazione. Il risultato è un clima di apatia e di estraneità in cui si partecipa senza partecipare, con la certezza che nulla di quanto si dirà potrà davvero influenzare l’esito finale. La collegialità, privata della sua anima dialogica, si riduce così a un guscio formale, svuotato di senso.
Le conseguenze del tradimento
Il tradimento della collegialità non è mai neutro, perché lascia cicatrici profonde sulla qualità delle relazioni e sul senso di appartenenza. Quando i membri di una comunità percepiscono che le loro opinioni non hanno alcun peso e che la partecipazione è solo facciata, smettono di credere nella possibilità di incidere e si rifugiano in atteggiamenti di indifferenza o di resistenza passiva. Il patto fiduciario, che dovrebbe essere alla base di ogni istituzione, si incrina, lasciando spazio al sospetto, alla delusione e, talvolta, al conflitto aperto.
Sul piano professionale, questo impoverisce la comunità, che perde l’occasione di nutrirsi della varietà di esperienze presenti al suo interno e di crescere grazie allo scambio. La scuola, in particolare, rischia di diventare una somma di individualità isolate, in cui ciascuno si limita a portare avanti il proprio lavoro senza avvertire il senso di un progetto comune.
Sul piano culturale si genera stagnazione, poichè le innovazioni rimangono iniziative sporadiche, legate al singolo, e non diventano mai patrimonio condiviso. Con il tempo, tutto questo produce una comunità fragile, incapace di rinnovarsi e di affrontare le sfide con lucidità, esponendola al rischio di trasformarsi in una struttura inerte, più preoccupata di conservare equilibri formali che di costruire futuro.
La possibilità di un riscatto
Nonostante i tradimenti e le distorsioni, la collegialità può essere recuperata se la si ripensa come un bene prezioso da custodire e rigenerare. Per riuscirci non basta moltiplicare le riunioni o caricare gli organi collegiali di nuovi compiti burocratici: occorre restituire loro senso e vitalità.
Bisogna creare contesti in cui la parola di ciascuno sia realmente ascoltata e non semplicemente registrata, in cui il dissenso non venga percepito come un ostacolo da eliminare ma come una risorsa da valorizzare. Serve una cultura diversa, capace di far percepire la collegialità non come un dovere imposto dall’alto, ma come un’opportunità per sentirsi parte di un progetto comune.
È fondamentale che ogni componente sappia che il proprio contributo non è irrilevante, ma indispensabile alla costruzione di una visione collettiva. Solo così la collegialità può tornare a essere ciò che dovrebbe essere: non un orpello formale, ma il motore pulsante di una comunità viva, in grado di rigenerarsi, di innovare e di crescere nella fiducia reciproca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA














Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via