
In ricordo di Paola Serafin

Tuttoscuola vuole ricordare Paola Serafin, la dirigente sindacale della Cisl-scuola e componente del CSPI, non solo esprimendo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla segreteria nazionale della CISL-scuola, ma riportando integralmente il suo intervento “Una dirigenza che dà forma al futuro”, con cui si apriva il numero di giugno 2025 di Dirigenti News.
Sapeva di avere poco tempo ancora per vivere, ma nella parte finale di questo suo intervento emerge, comunque, lucidamente e con ottimismo la fiducia e l’incoraggiamento per contribuire alla costruzione di un mondo nuovo.
Questo è il corsivo (non firmato, ma come sempre li scriveva Paola Serafin) che apre il numero 22 del 5 giugno 2025 di Dirigenti News, la newsletter della CISL Scuola dedicata in modo specifico alle problematiche della dirigenza.
Una dirigenza che dà forma al futuro
Alcuni eventi culturali, apparentemente molto lontani tra loro, hanno fornito in queste ultime settimane interessanti spunti per rileggere la nostra professione e offrire una chiave interpretativa nuova, per un momento lontana dalle visioni quotidiane e a corto raggio alle quali siamo spesso costretti dalla contingenza. Sappiamo bene che l’elemento davvero generativo della nostra professione di dirigenti scolastici dovrebbe essere la possibilità di contribuire a costruire uno sguardo per il futuro con la nostra comunità scolastica, o – come recita il motto del prossimo imminente congresso della Cisl Scuola – dare una forma al futuro. Perché nessuno più delle scuole è al centro di processi che danno forma al futuro.
I tre eventi ai quali facciamo riferimento, e che vogliamo accostare in modo forse un po’ temerario, sono il Festival dell’economia di Trento, dal significativo titolo Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio, la prima Climate Week in corso a Venezia e la restituzione dei risultati della ricerca condotta dalla Fondazione Agnelli e dalla Fondazione Rocca sui divari territoriali di apprendimento, presentata recentemente alla Camera dei deputati.
Del primo, tra i tanti, vogliamo ricordare l’intervento di Stefano Mancuso, uno dei massimi esperti di neurobiologia vegetale, un campo quindi molto lontano dalla pedagogia. Al centro della sua relazione la differenza tra organizzazione del mondo animale e vegetale.
L’organizzazione del mondo animale, e inevitabilmente anche nostra, è prevalentemente ispirata alla verticalizzazione del potere di controllo, piramidale e con flussi top down, e nello stesso tempo da un’alta specializzazione degli organismi intermedi, che consentono di esercitare una migliore supervisione dei processi ma che si scontrano con una minore flessibilità nella risposta all’imprevisto, perché il luogo della decisione è lontano dal luogo ove si affacciano i problemi, perché la comunicazione dei dati dalla periferia al centro può essere incompleta o falsata o comunque ritardata e perché l’alta specializzazione può divenire un elemento di debolezza. Questa organizzazione ha fondamenti biologici: il nostro corpo prevede un solo cervello, con la duplicazione di altri organi specializzati controllati a livello centrale, la cui morte è in grado, comunque, di generare la morte dell’intero organismo, proprio per l’alta specializzazione posseduta. Questo tipo di organizzazione riguarda lo 0,3 per cento della vita sulla terra.
L’organizzazione del mondo vegetale è, all’opposto, del tutto decentralizzata e distribuita, consente una migliore risposta al mutare delle condizioni, consente la sopravvivenza della parte anche quando l’organismo sembra danneggiato, è regolata in reti. Ad esempio, osserva Mancuso, le piante respirano, bevono, sentono, ragionano con tutto il corpo.
Due visioni opposte che, però, se trasportate in tema di leadership e organizzazione, ci dovrebbero far riflettere. D’altra parte, nel medesimo Festival anche Angelo Paletta ha sottolineato come il mondo aziendale si stia ormai da molto tempo spostando verso modelli di leadership distribuita, ma questa naturalmente va progressivamente costruita, non è un valore in sé. Dunque, se vogliamo pensare il futuro della nostra scuola dobbiamo analizzare la rilevanza del fattore organizzativo, a cui anche il nuovo CCNL di comparto dovrà offrire una prospettiva.
Questa attenzione al rapporto centralizzazione/distribuzione dell’organizzazione sociale è stata curiosamente al centro anche dell’intervento di Jeremy Rifkin nel Climate week a Venezia, secondo una prospettiva del tutto diversa ma singolarmente assonante. L’economista statunitense ha illustrato alcuni tratti della nuova rivoluzione industriale in corso, dopo i grandi mutamenti dell’800 e del ‘900. Anche in questo caso l’elemento comune del cambiamento di paradigma che stiamo vivendo è il passaggio da sistemi centralizzati a sistemi distribuiti. Questo avviene nella produzione e distribuzione dell’energia, nella comunicazione, nella mobilità, nella gestione delle risorse idriche. Questo tipo di mutamento influenza profondamente l’organizzazione economica e sociale, innescando esempi di produzione additiva piuttosto che sottrattiva. Secondo uno studio della IEG bank Europe, entro il 2040 il 40 per cento di tutti i prodotti sarà realizzato con stampa 3d e il software potrà essere utilizzato anche da piccole e medie imprese ad alto sviluppo tecnologico che porteranno una ridefinizione dei modelli economici come li conosciamo oggi e che attualmente, invece, concentrano in 500 aziende globali un terzo del pil mondiale. Queste aziende impiegano tuttavia solo 65 milioni di persone su oltre 3 miliardi e mezzo di lavoratori e al loro vertice ci sono solo 8 persone la cui ricchezza combinata è pari a quella di metà dell’umanità.
In questi processi in corso, in questa dialettica tra accentramento e distribuzione, viene spontaneo pensare all’autonomia scolastica e sorprenderci di quanto fosse per l’epoca una intuizione innovativa. Già da tempo costituisce una forma organizzativa orientata a soluzioni distributive piuttosto che centralistiche, antesignana straordinaria nella sua precocità storica, unica forma di organizzazione in Italia a così alto tasso partecipativo e distribuito nelle decisioni.
La ricerca delle Fondazioni Agnelli e Rocca sottolinea che le scuole proprio per questo contano, possono fare la differenza in termini di riduzione dei divari territoriali e per preparare gli allievi a dare forma al futuro.
Che le scuole contassero davvero lo avevamo visto già con il Covid, con il crollo dei risultati di apprendimento soprattutto tra le fasce più deboli. Ma la ricerca delle Fondazioni Agnelli e Rocca si concentra su ciò che le scuole possono fare per ridurre la varianza dei risultati tra gli istituti scolastici di uno stesso territorio e anche nella stessa scuola. Perché le istituzioni scolastiche sono vicine al luogo ove si verificano i problemi e, come nei sistemi distribuiti, possono reagire rapidamente e costruire soluzioni senza perdere la dimensione di rete e le connessioni con l’intero sistema. Ma devono farlo tenendo presenti gli scenari globali, il passaggio in atto dal concetto di progresso a quello di equilibrio entro i sistemi in cui viviamo, di sostenibilità per un futuro che non sia devastante. Devono saper guardare al futuro, programmare a medio e lungo tempo, provare a dare forma al futuro.
Secondo i risultati della ricerca, infatti, le scuole che ottengono migliori risultati in termini di riduzione dei divari di apprendimento sono quelle che agiscono con più convinzione e competenza l’autonomia scolastica, esempio fondamentale di distribuzione nel territorio di possibilità di gestione e scelta. Ancora una volta risultano essere fattori centrali la leadership distribuita, la capacità di operare sul curricolo adattandolo alle diverse situazioni, l’introduzione di innovazione didattica e l’utilizzo di prove standardizzate, anche passando per processi organizzativi apparentemente limitati come la formazione delle classi. La presenza di progetti extracurricolari inoltre sembra influenzare i risultati, esprime vitalità della scuola e connessione con il territorio. Insomma, è rilevante la presenza di scelte e soluzioni definite proprio là ove i problemi si presentano, nel territorio, nella comunità, in una dimensione di rete.
Dobbiamo dunque riappropriarci dell’orgoglio di ciò che siamo, della forte anticipazione attraverso l’autonomia scolastica di forme organizzative della società che emergono prepotentemente ora in ogni campo e dobbiamo sfruttare ogni spazio in termini di formazione e gestione per attivarla in tutte le sue potenzialità, per rendere alle nostre scuole spirito di intraprendenza e innovatività.
Il ruolo dei dirigenti scolastici è fondamentale, ma occorre essere consapevoli che oggi hanno bisogno di nuovi modelli di leadership distribuita che consolidino entro un progetto comune tutte le energie. Scelte residuali e difensive, verticiste e di accentramento, che guardano a modelli organizzativi tipici delle precedenti rivoluzioni industriali, non possono che essere devastanti, sia per i risultati della scuola, sia per il benessere lavorativo del dirigente scolastico che da solo non potrebbe mai affrontare compiutamente processi generativi così ampi e complessi. E questo comporta orgoglio di ciò che siamo ma anche consapevolezza che l’autonomia scolastica deve essere aggiornata e le forme di partecipazione rinnovate e rese più funzionali di fronte all’evolvere delle sfide. Abbiamo la possibilità di contribuire a costruire un mondo nuovo che sembra finalmente guardare nel suo complesso alla straordinaria innovatività proprio di quei modelli che ispirarono tanti anni fa l’adozione dell’autonomia scolastica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

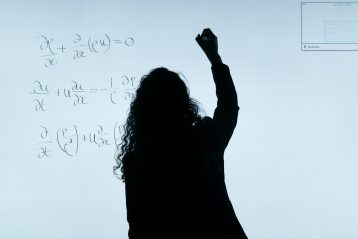





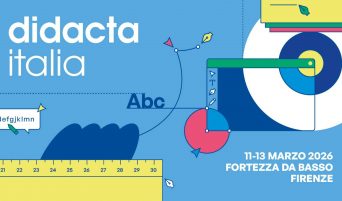
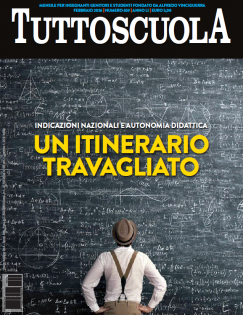




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via