
Il Rapporto INVALSI 2025/2. Il secondo ciclo

Anche per le superiori rimane una sostanziale stabilità e si inseriscono le competenze digitali considerate ad un obiettivo intermedio. Nella seconda in italiano quasi i due terzi raggiungono il dato medio, ma continua la disparità territoriale nord-sud. L’alunno coglie il tema fondamentale del testo, riconosce tecniche narrative e svolge compiti grammaticali che richiedono la conoscenza della struttura della lingua.
I licei conseguono i migliori risultati e si raggiunge il livello medio in tutti gli indirizzi, nei tecnici il risultato è inferiore e nei professionali c’è il dato più basso. In matematica il 24,4% è nella media, rispondendo a domande che richiedono semplici ragionamenti. I tecnici sono di poco sopra, mentre nei professionali non si raggiunge mai la soglia dell’accettabilità, con un calo dal 2019.
Per la quinta superiore c’è un calo dopo la pandemia, la ripresa fatica a consolidarsi in italiano. Il livello medio è raggiunto da poco più della metà degli studenti. Prosegue anche per costoro in italiano la ricerca sui testi con un lessico anche settoriale muniti di una sicura forma grammaticale. In matematica meno della metà raggiunge il suddetto traguardo, nel tentativo di riconoscere le proprietà dei principali oggetti matematici e risolve problemi. Meglio i licei scientifici, meno negli altri licei e istituti tecnici, non accettabili gli istituti professionali. Il 55,3% consegue buoni risultati nelle prove di inglese: in tutte le regioni si raggiunge il livello B2, tranne che in Campania, Calabria e Sicilia dove siamo fermi al B1.
I dati anche quest’anno non sono incoraggianti, sia dal punto di vista degli apprendimenti, sia per l’equità del sistema. La variabilità tra le scuole è da riferirsi all’eterogeneità del territorio ed alle già citate condizioni socio-economico-culturali della popolazione, che ne condizionano i risultai e fanno sì che le opportunità non siano uniformemente distribuite.
Il tentativo di segnalare studenti con esiti più elevati ha lasciato piuttosto delusi, anche se recentemente è stato presentato un disegno di legge per i “superdotati”: non solo costoro sono ancora in calo, ma quest’anno si tratta del risultato più basso dall’inizio della rilevazione.
L’unico dato confortante, di cui la politica praticamente si è occupata, è stato quello positivo e cioè il calo della dispersione, suffragato anche da un’analoga indagine ISTAT; si tratta di uno degli indicatori che l’Italia ha centrato rispetto al PNRR.
Il rapporto esprime soddisfazione anche per la presenza delle competenze digitali, vedremo come questo dato sarà confermato a seguito dei provvedimenti inibitori circa l’uso dei dispositivi digitali personali, che magari conseguivano un risultato in assenza di un’adeguata attrezzatura da parte delle scuole.
Forse gli interventi infrastrutturali del PNRR hanno costretto il ministero ad intervenire nelle regioni del sud, alcune delle quali così hanno migliorato i risultati, ma il quadro conferma le necessità di programmare a partire dalle esigenze specifiche di territori e scuole, che poi significa dalla personalizzazione dei curricoli. Il decantato piano sud non è che poi abbia prodotto per ora soluzioni miracolistiche: oltre ai necessari investimenti da mettere a disposizione delle scuole stesse, occorre maggiore autonomia nella gestione delle risorse economiche e di personale, per la troppa eterogeneità della popolazione scolastica, ed una corresponsabilizzazione degli enti territoriali, che nelle recenti operazioni del PNRR, soprattutto al sud, non hanno brillato per efficienza e sollecitudine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

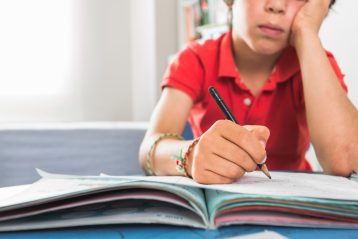










Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via