
Figli da PMA in coppie di donne: la Consulta apre al doppio riconoscimento. Cambiano i riferimenti anche per le scuole

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68 del 22-28 maggio 2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 della Legge n.40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), laddove non consente che il nato in Italia, a seguito di Procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero da una coppia di donne, venga riconosciuto come figlio anche alla c.d. madre intenzionale che, insieme alla madre biologica (la donna cha ha partorito) abbia dato il consenso alla pratica fecondativa e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
La PMA in Italia e all’estero
Per richiamare, pur nei tratti essenziali, il percorso logico-giuridico realizzato dalla Corte, è necessario accennare, in via preliminare, a quale sia in Italia la disciplina legislativa che presiede alla PMA e cosa la differenzi dalla legislazione di altri Paesi.
La PMA, in generale, è costituita da un insieme di tecniche mediche intese ad aiutare le coppie che hanno difficoltà nel concepire in modo naturale. E poiché essa tocca un elemento estremamente sensibile della vita delle persone – la scelta procreativa – è stata appositamente regolamentata. In Italia, infatti, è proprio la legge n.40/2004, con gli artt. 4 e 5, che stabilisce i requisiti e i soggetti che hanno titolo a praticare la PMA, ovvero:
- Le coppie in condizioni di sterilità o infertilità documentate da apposite certificazioni mediche;
- le coppie che, pur fertili, sono portatrici di malattie genetiche trasmissibili;
- le coppie viventi di maggiore età, coniugate o conviventi, di sesso diverso e potenzialmente fertili.
Quindi la legge esclude, oltre ai single, le coppie omosessuali dal novero dei soggetti che possono praticare in ambito nazionale la PMA; coppie che, di solito, si recano all’estero, vale a dire in uno dei Paesi che non hanno tali limitazioni legali, per portare avanti il trattamento di fertilità.
Ma non basta, c’è di più.
Anche le coppie di donne omoaffettive italiane – che hanno svolto all’estero con esito positivo la terapia medicale e decidono di far nascere i figli in Italia – riscontrano un ulteriore e aggiuntivo impedimento: l’art. 8 della legge n. 40/2004, prevede il riconoscimento dei figli solo ed unicamente per le donne che hanno partorito e non anche per le conviventi (cc.dd. madri intenzionali) che pure hanno espresso il loro consenso alla PMA.
La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, della L. n.40/2004
Ed è proprio la situazione di una di queste coppie di donne italiane quella sottoposta al vaglio della Consulta, che ha cosi constatato, in danno del minore, la violazione, congiunta, di tre profili costituzionali.
In particolare:
- dell’art. 2 Cost., atteso che il mancato riconoscimento da parte della madre intenzionale induce nel nato una precaria situazione giuridico-affettiva e, di conseguenza, una dimensione lesiva dell’integrità relazionale dello stesso;
- dell’art. 3. Cost., poiché la inosservanza del principio di uguaglianza deriva dal solo carattere omosessuale del nucleo familiare;
- dell’art. 30 Cost., in quanto il diniego al riconoscimento della madre intenzionale viola il diritto del minore dall’essere cresciuto ed accudito da ambedue le figure genitoriali.
Inoltre la Corte, per la fattispecie in esame, rileva anche la inadeguatezza dell’adozione, a motivo:
- della lunghezza dei tempi “…posti dalla natura stessa dell’istruttoria richiesta per tale procedimento”;
- della non rispondenza di detto istituto “…alle esigenze del riconoscimento dello stato di figlio sin dal momento della nascita quale conseguenza che discende, come nella generalità dei casi, dal comune impegno genitoriale assunto all’inizio del relativo percorso attraverso la PMA”.
Tuttavia, la inadeguatezza rilevata dalla Corte – come puntualmente precisato – non riguarda l’adozione in sé considerata, bensì una non adeguatezza che attiene alla specifica situazione esaminata: il mancato riconoscimento del figlio da parte della madre d’intenzione, pur a fronte di una situazione familiare che è tale sin dalla nascita del minore.
Infine, la Corte tiene a chiarire che la situazione oggetto di scrutino “… si distingue radicalmente dall’ipotesi di ricorso alla cosiddetta maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso ad una pratica che l’ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna”.
Queste, in estrema sintesi, le motivazioni che hanno condotto la Corte a dichiarare la incostituzionalità dell’art. 8 della legge n.40/2004 e, in conseguenza di ciò, consentire alla madre intenzionale il riconoscimento del figlio, al pari della madre partoriente; riconoscimento – è bene ribadirlo – derivante da un unico e preminente interesse: il diritto del minore ad esigere, sin dalla nascita, il doveroso accudimento e le relazioni affettive di due genitori, non incidendo negativamente, per l’assunzione di dette responsabilità, l’orientamento sessuale degli stessi.
Le modalità applicative della sentenza
Per le modalità applicative della sentenza – in attesa della circolare del Ministero dell’Interno – è possibile fin d’ora indicare il percorso di filiazione in almeno due situazioni, quelle di probabile maggior ricorrenza.
- Per i figli e le figlie nati dopo la sentenza, la madre intenzionale potrà, innanzi all’Ufficiale di stato civile, effettuare la dichiarazione di riconoscimento del nato da sola o unitamente alla madre biologica.
- Per i figli e le figlie nati prima della sentenza, la madre intenzionale potrà, sempre innanzi all’Ufficiale di stato civile, effettuare il riconoscimento postumo nel rispetto delle seguenti e contestuali condizioni, ovvero:
- che la madre biologica figuri, nell’atto di nascita, come solo genitore e che la stessa formalizzi, preventivamente, il proprio consenso al riconoscimento da parte della madre intenzionale.
Il percorso evidenziato, del tutto analogo a quello stabilito dal Codice civile (cfr. art.250 e ss.) per le coppie eterosessuali, non dovrebbe essere gravato da altre richieste da parte dell’Ufficiale di stato civile.
Le conseguenze dell’iscrizione nel registro di stato civile
Dunque, se la procedura di riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale ha esito positivo, ovvero risulta dall’apposita iscrizione nei registri dello stato civile, lo status di filiazione ha valore giuridico costitutivo. Detto altrimenti, la madre intenzionale risulta, a tutti gli effetti di legge, genitore del nato.
Dal che, il conseguente accesso della madre intenzionale ad alcuni istituti giuridici preposti alla tutela della genitorialità, quali, ad esempio:
- il congedo parentale, per la parte di competenza (art. 32, D.lgs. n.151/2001);
- i riposi giornalieri, alternativamente alla madre partoriente (idem, artt. 39 e 40);
- i congedi per malattia del figlio da 0 a 3 anni e da 3 a 8 anni, sempre in modo alterno rispetto alla madre partoriente (ibidem, art. 47).
Non solo. La madre intenzionale – giusta un’altra sentenza della Consulta (n. 115/2025), di cui ci occuperemo più compiutamente in un successivo intervento – ha titolo a fruire anche del “congedo obbligatorio di paternità” (cfr. art. 27-bis, del D.lgs. n. 151/2001).
© RIPRODUZIONE RISERVATA



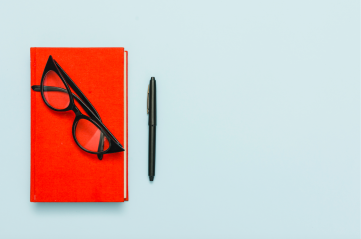




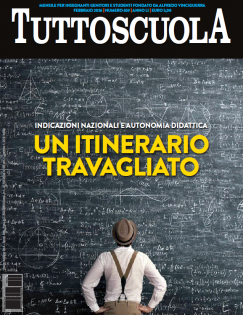




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via