
Edifici scolastici: il 90% non è a norma di sicurezza

ESCLUSIVO / DOSSIER EDILIZIA SCOLASTICA
Riaprono le scuole per oltre 7 milioni di studenti e per un milione di lavoratori del settore. Sono luoghi sicuri?
Dei 40 mila edifici scolastici statali, ben 36 mila non dispongono di una o più certificazioni obbligatorie in tema di sicurezza. E quasi uno su 10 non ne dispone neanche di una. La mappa dei 3.600 edifici “totalmente irregolari”, dove studiano o lavorano in 700 mila. E nelle zone ad alto rischio sismico la situazione è peggiore della media. Ai Campi Flegrei e nell’area vesuviana, di recente oggetto di frequenti scosse, un quadro da rabbrividire. Il caso Abruzzo.
A 23 anni dalla tragedia di San Giuliano di Puglia, a 17 dal crollo del soffitto del liceo Darwin a Rivoli, in cui perse la vita lo studente Vito Scafidi, la radiografia sull’edilizia scolastica non è all’altezza degli standard di un Paese del G7.
In attesa che gli investimenti del PNRR producano un miglioramento (parziale), le famiglie hanno diritto di conoscere lo stato delle “seconde case” dei loro figli. E lo stesso vale per il personale della scuola.
(Servizio in aggiornamento)
Sono oltre sette milioni gli alunni delle scuole statali di ogni ordine e grado che tra pochi giorni riempiranno di vita i 40 mila edifici scolastici italiani. Vi trascorreranno oltre duecento giorni, per un totale in media di mille ore. Con loro (e per loro), sotto lo stesso tetto, un milione tra docenti, dirigenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici.
Si può dire che quei 40mila edifici scolastici siano come la “seconda casa” per la fascia più preziosa della popolazione italiana, oltre che il luogo di lavoro di chi si occupa della loro educazione.
Ma queste seconde case come sono? Quali servizi offrono a sostegno delle attività scolastiche? E soprattutto, sono sicure?
Poche settimane fa il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato nella sezione Open Data dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica i dati completi relativi all’anno scolastico 2023-24[1].
Tuttoscuola li ha analizzati in un report dettagliato che descrive le condizioni generali di sicurezza dei 39.993 edifici scolastici (per la prima volta si è scesi sotto la soglia dei 40 mila, un effetto del trend demografico).
In tema di sicurezza sono 5 le certificazioni fondamentali previste dalla normativa: Certificato di agibilità, Certificato di prevenzione incendi, Certificato di omologazione centrale termica, Piano di evacuazione, Documento di valutazione dei rischi. I primi tre sono rilasciati da enti esterni, gli ultimi due sono prodotti dall’istituzione scolastica a cui fanno capo gli edifici. Ciascuno dei cinque documenti riguarda aspetti essenziali per l’incolumità di chi entra a qualsiasi titolo in un immobile.
Fino a oggi tutte le indagini e gli studi sull’edilizia scolastica (inclusi quelli di Tuttoscuola) hanno fornito un quadro complessivo sull’esistenza o meno delle diverse certificazioni a livello nazionale o territoriale, per singola certificazione. Questo Dossier non solo aggiorna il quadro con gli ultimi dati riferiti all’anno scolastico 2023-24, ma per la prima volta analizza la situazione a livello di singolo edificio, verificando di quante certificazioni dispone ciascuno dei 39.993 edifici. Il dossier restituisce così un quadro di sintesi di quanti edifici sono a norma e quanti no.
L’anagrafe del MIM infatti mappa puntualmente l’esistenza o meno di queste certificazioni per ciascuno dei 39.993 edifici. Grazie all’incrocio e alla rielaborazione dei dati curati da Tuttoscuola è possibile fornire un quadro completo e puntuale, e inedito, dello stato dell’edilizia scolastica, per Regione fino al singolo immobile.
Anticipiamo subito un dato, che è difficile non definire preoccupante se non disarmante: meno di un edificio su 10 dispone di tutte e cinque le certificazioni fondamentali previste, cioè di quello che dovrebbe essere la norma per uno standard di sicurezza all’altezza di un paese evoluto.
36.088 edifici scolastici (cioè 9 su 10) sono infatti privi di una o più certificazioni obbligatorie previste dalla normativa. Insomma, o non sono stati fatti i collaudi (oppure, peggio, non sono stati superati), o non sono stati elaborati i piani che valutano i rischi e stabiliscono le regole di evacuazione.
Vuol dire che c’è un pericolo per chi si trova all’interno? No, o almeno non è detto. Ma si può dire che non vi sono le garanzie legali di sicurezza. Insomma non sono conformi alle prescrizioni di legge, e quindi sono tecnicamente irregolari. Quel che è certo è che sono circa 60-70 l’anno i casi di crolli, cedimenti o altri incidenti in edifici scolastici censiti dall’Osservatorio di Cittadinanzattiva. Non pochi, e il trend è in aumento. Del resto il patrimonio immobiliare messo a disposizione delle scuole da Comuni e Province ha un’anzianità media che si avvicina a sessant’anni, ma alcuni immobili risalgono al XIX secolo o prima ancora (1.526 edifici sono stati costruiti prima del 1920, secondo quanto comunicato dal MIM alcuni anni fa).
Nel report di Tuttoscuola sono conteggiati uno a uno gli edifici che sono mancanti di una certificazione, oppure di due, di tre, di quattro e… Il dato al contempo clamoroso e drammatico è che vi sono 3.588 edifici (il 9% del totale) che – secondo quanto riportato nel Portale dati del Ministero dell’istruzione – sono totalmente privi delle certificazioni di sicurezza. Neanche una delle cinque obbligatorie. Si possono definire edifici totalmente irregolari dal punto di vista della normativa sulla sicurezza.
Facendo una stima in base ai dati medi, in questi edifici di cui nessuno ha testato o comunque certificato la sicurezza, studiano o lavorano circa 700 mila persone, tra studenti e personale della scuola. Ed è giusto che le famiglie e il personale sappiano se l’edificio in cui passano tanto tempo i propri figli o essi stessi possiede o meno le certificazioni previste.
Il report di Tuttoscuola contiene la mappa completa di questi istituti “totalmente irregolari”, che sono, in proporzioni diverse, praticamente su tutto il territorio nazionale, anche se per due terzi si concentrano nel Mezzogiorno (dove è situato solo il 38% del totale degli edifici scolastici italiani). O almeno questa è la realtà dei dati che popolano l’Anagrafe, inviati da Comuni e Province, con il coinvolgimento delle Regioni, al Ministero dell’istruzione, che li valida e li pubblica dopo apposita attività di verifica e controllo della qualità.
Come si è potuti arrivare a questa condizione? Si è stratificata nei decenni, l’inadeguatezza può definirsi “strutturale” in tutti i sensi. L’edilizia scolastica può rappresentare una buona cartina di tornasole dell’evoluzione storica del Paese, della mancanza di programmazione, della tendenza ad affrontare i problemi solo quando diventano emergenze. E l’argomento non può essere oggetto di “schermaglie” politiche, perché dal dopoguerra a oggi si sono alternate tutte le forze politiche. E’ un limite nazionale, che ha molto a che fare con la scarsa priorità storicamente attribuita al sistema di istruzione.
Le motivazioni delle mancate certificazioni possono essere le più svariate (il report ne evidenzia numerose: la carenza di finanziamenti, la burocrazia, lo scarico di responsabilità tra diversi soggetti, il fatto che il 17% degli edifici sono nati con una destinazione diversa e solo in un periodo successivo sono stati adibiti a scuola, oppure sono in corso attività di ristrutturazione, e così via). Sta di fatto che ad oggi mancano quei documenti di legge, e quindi va verificato – edificio per edificio – se è così, perché e va fatto un piano di messa a norma dove applicabile. Non si può continuare con questa situazione cristallizzata nell’insicurezza. Tuttoscuola – che da 50 anni racconta il mondo della scuola con inchieste, analisi e proposte – mette a disposizione questo lavoro basato su analisi e comparazione di migliaia di dati per ogni singolo edificio anche per favorire questo passaggio.
Va ricordato che gli edifici scolastici sono di proprietà degli Enti locali (o da essi presi in affitto), che per legge ne garantiscono la realizzazione, il funzionamento, l’agibilità e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gli edifici che accolgono scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I grado sono di proprietà dei Comuni, mentre quelli in cui sono inseriti istituti secondari di II grado sono proprietà delle Amministrazioni provinciali. Una spiegazione delle cause profonde di questo stato di cose la diede qualche anno fa l’Upi, l’Unione delle province, che lamentava: “Due le emergenze a cui far fronte ora. La prima sono le pochissime risorse, insufficienti a coprire il reale fabbisogno in termini di investimenti in messa in sicurezza e manutenzione” (e citava la Legge di bilancio di quell’anno, che riservava alle scuole superiori “solo 450 milioni a fronte dei 2,5 miliardi di fabbisogno accertato”). “La seconda mancanza è caratterizzata dalle procedure burocratiche talmente complesse che fanno passare anche tre anni da quando i soldi sono stanziati a quando arrivano agli enti”.
Gli enti locali sono proprietari e hanno responsabilità in materia per legge. Ma nessuna istituzione, a partire da Governo e Regioni, può chiamarsi fuori per realizzare un piano di regolarizzazione e messa in sicurezza che, per le dimensioni del problema, non può che essere declinato su un orizzonte temporale di lungo termine.
[1] Ai primi di agosto 2025 il MIM ha pubblicato con grande tempestività anche i dati relativi all’a.s. 2024-25, al momento mancanti di alcune province, non essendo stati ancora forniti dagli enti locali competenti. Per questa ragione abbiamo preferito basare le analisi di questo dossier sui dati relativi al 2023-24, che sono completi e definitivi
– Edifici scolastici: il 90% non è a norma di sicurezza
– I numeri che preoccupano, nel Belpaese a rischio sismico
– Solo un edificio scolastico su dieci possiede tutte le certificazioni per la sicurezza
– La mappa degli edifici ‘totalmente irregolari’
– Quel 10% di edifici scolastici a norma di sicurezza
– Collaudo statico degli edifici scolastici al 53,3%. Il Mezzogiorno al 44%, il Nord al 66%
© RIPRODUZIONE RISERVATA







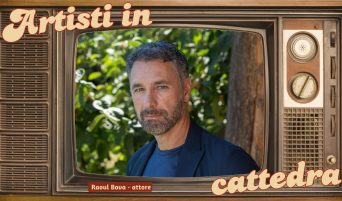





Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via