
Come riformerei (davvero) l’esame di maturità
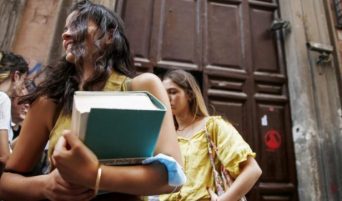
Cambiato mille volte, mai riformato davvero
Negli ultimi trent’anni l’esame conclusivo delle scuole superiori è stato sottoposto a ritocchi di ogni genere, oscillando tra prove aggiunte, tolte e rimesse, commissioni allargate o ridotte, crediti modificati, orali reinventati.
Ogni ministro ha lasciato la propria impronta, introducendo piccole modifiche. Così l’esame, invece di diventare più solido, ha finito per apparire fragile e instabile, prigioniero di micro-correzioni scollegate tra loro, senza toccare un punto fondamentale: cosa intendiamo certificare alla fine del quinquennio.
Un esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, adatto a giovani di 18/19 anni, dovrebbe certificare almeno tre aspetti:
- La crescita culturale: non solo conoscenze, ma capacità di usare i saperi in modo critico, di collegarli, di argomentare.
- La maturazione personale: autonomia, senso di responsabilità, capacità di affrontare una prova pubblica, di gestire tempo ed emozioni.
- Le competenze trasversali: comunicazione chiara, pensiero critico, attitudine a lavorare con metodo e a riflettere sul proprio percorso.
In altre parole, dovrebbe attestare che lo studente è diventato un giovane adulto capace di orientarsi e di scegliere, pronto ad entrare nell’università, nel lavoro o nella società, con solidi strumenti intellettuali e umani.
Se guardiamo ai Paesi che occupano stabilmente i primi posti nelle classifiche internazionali come PISA, emerge un dato interessante: quasi nessuno affida la valutazione finale a un unico esame “spartiacque”. In Finlandia, ad esempio, lo Ylioppilastutkinto è una prova nazionale importante, ma il voto finale integra anche le valutazioni del percorso scolastico. In Estonia, il Paese europeo con i risultati più alti, il diploma si ottiene senza un esame conclusivo uniforme, puntando invece sulla continuità della valutazione e su un forte uso del digitale. Nei Paesi scandinavi in generale il percorso pesa molto e le prove finali hanno una funzione di verifica più che di condanna. All’opposto, nei sistemi asiatici come Singapore e Corea, i punteggi eccellenti arrivano attraverso esami finali durissimi e selettivi, che decidono direttamente l’accesso all’università: un modello che produce risultati alti, ma al prezzo di una pressione enorme sugli studenti, ben lontano dalla cultura educativa europea. Il Canada si colloca in una via intermedia, con valutazioni continue integrate da prove standardizzate provinciali. In sintesi: i sistemi più coerenti con la nostra tradizione educativa non riducono la maturità a un esercizio di sopravvivenza disciplinare, ma la valutano dentro un quadro che intreccia percorso, competenze e prove conclusive.
Brevissima e parziale cronistoria dell’esame: nel 1997 la riforma Berlinguer introdusse il nuovo “esame di Stato” con tre prove scritte e commissione mista; nel 1999 venne introdotta la terza prova scritta; nel 2001 la Moratti tolse i commissari esterni, ad esclusione del presidente, modalità ripresa provvisoriamente in epoca Covid (esami del 2021 e 2022); nel 2007 Fioroni reintrodusse la terza prova scritta, multidisciplinare, dopo la sua sospensione nel 2000; nel 2010 la Gelmini irrigidì le regole di ammissione; nel 2019, per effetto del D. Lgs. 62/2017, venne eliminata la terza prova scritta e vennero ridefiniti i crediti, il colloquio orale si svolse senza la tesina interdisciplinare, sostituita da materiale fornito dalla commissione; nel 2020 e 2021 la pandemia portò a un esame solo orale, con discussione di un elaborato concordato con i docenti, tenendo conto del curriculum dello studente e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo; dal 2022 in poi si è tornati gradualmente alla normalità, ma con nuovi ritocchi. Oggi, con la proposta del Ministro Valditara, si annunciano ulteriori cambiamenti, a partire dalla riduzione della commissione a quattro membri.
In ogni aggiustamento c’è stato, forse, qualcosa di buono.
La “tesina”, che se ben seguita valorizzava il percorso personale; la commissione composta solo da docenti interni, che garantiva coerenza; persino la terza prova multidisciplinare, che avrebbe potuto avere un senso se costruita con intelligenza didattica. Ma tutto è apparso e scomparso secondo l’inclinazione del ministro di turno, senza una visione stabile. Il risultato è un esame che, invece di misurare la crescita globale dello studente, continua a ridursi a una prova di resistenza disciplinare, trascurando quelle competenze trasversali, relazionali e personali (le cosiddette non-cognitive skills) che sono il vero segno della crescita personale.
Un cantiere perenne, dunque, dove ogni ministro ha messo mano a pezzi diversi senza mai avere il coraggio di immaginare una riforma complessiva.
Un esame che dovrebbe essere un momento decisivo di crescita è diventato il simbolo della frammentarietà.
Dal punto di vista degli studenti, lo dico per esperienza diretta, ogni cambiamento dell’esame viene accolto più con ansia che con fiducia. Ogni anno si crea un’attesa per quello che verrà deciso, in un clima di incertezza e disorientamento.
Cavie di un sistema instabile, i ragazzi si adattano alla continua altalena di norme (tesina sì, tesina no; terza prova sì, poi abolita; orale con materiali a sorte, poi di nuovo diverso), ricavandone l’impressione che l’esame sia un gioco delle parti, più legato alla politica che al loro percorso di crescita. La preparazione diventa una corsa ad ostacoli, da superare con strategie di sopravvivenza (studiare solo ciò che serve, prepararsi alle domande più probabili, dimostrarsi come la commissione ti vuole, non come sei realmente). Non a caso, tra gli stessi studenti è diffusa l’idea che la valutazione finale dipenda più dalla fortuna (la commissione, le tracce, la giornata) che da cinque anni di lavoro.
Il rischio è che la maturità perda il suo valore: invece di rappresentare un momento di riconoscimento della crescita, appare come una pratica imposta dall’alto, spesso percepita come lontana dalla realtà che i ragazzi vivono e dal mondo a cui stanno per affacciarsi.
Un merito, però, questa nuova riforma lo ha: il ritorno alla dicitura “esame di maturità”. Non è un dettaglio linguistico. “Esame di Stato” riportava più che altro all’atto burocratico, utile solo all’amministrazione per certificare. “Maturità”, invece, restituisce centralità agli studenti, segnala un passaggio di crescita personale e culturale, un rito di transizione verso la vita adulta. È una parola che rimette al centro l’esperienza formativa. D’altra parte, né nei media né nel linguaggio comune avevano mai smesso di chiamarla così.
Peccato che a questa scelta non corrisponda un impianto coerente con altre decisioni.
La composizione della commissione, ad esempio, è un nodo cruciale. Ridurla a quattro membri (esterni… interni… ?) significa, di fatto, trasmettere agli studenti che soltanto quelle materie contano davvero, con il rischio che già da gennaio le altre vengano trascurate.
Inoltre, se sono previsti quattro commissari, è scontato che le discipline delle prove scritte debbano venir riproposte anche all’orale, insieme a due sole altre. L’intero esame si appiattisce su un numero limitatissimo di saperi, cancellando la ricchezza del percorso.
Credo, invece, che la soluzione migliore sia una commissione composta da docenti interni, con un presidente esterno. I docenti interni conoscono gli studenti, ne hanno seguito i progressi e le difficoltà, e sono in grado di offrire una valutazione autentica. Il presidente esterno, da parte sua, garantisce trasparenza e uniformità. In questo modo si responsabilizzano i consigli di classe, si restituisce dignità a tutte le discipline e si rafforza la coerenza tra percorso ed esame.
Tra le novità annunciate spunta anche l’idea di una formazione specifica per i commissari d’esame. Una scelta che lascia perplessi: non ha senso addestrare i docenti alla valutazione finale, con un corso lampo a ridosso delle prove. La vera formazione non è certo estemporanea e occasionale, ma accompagna i docenti lungo l’intero percorso, aiutandoli a costruire strumenti di valutazione coerenti e condivisi. Pensare di risolvere tutto con un pacchetto formativo last minute significa trattare l’esame come un’operazione burocratica da gestire, non come il culmine di un cammino educativo.
Anche le prove scritte meritano un ripensamento radicale.
Nel 2025 costringere i ragazzi a scrivere a mano elaborati complessi è un anacronismo. La scrittura, la produzione di testi, la rielaborazione critica avvengono ormai in ambiente digitale. Usare il computer agli scritti significherebbe rendere la valutazione più equa, includere chi ha difficoltà grafiche o disturbi specifici dell’apprendimento, eliminare disparità dovute alla calligrafia o alla velocità manuale, e produrre testi più leggibili e meglio valutabili. Scrivere al computer non significa solo “battere a macchina” invece che usare la penna: vuol dire avere la possibilità di rivedere, correggere, riorganizzare il pensiero in modo più consapevole ed efficace. La scrittura digitale non è solo l’ambiente naturale del mondo universitario e professionale (relazioni, articoli, report, perfino la comunicazione quotidiana passano da lì); ormai è anche parte integrante della vita scolastica degli stessi studenti delle superiori. Molti compiti e lavori di ricerca vengono consegnati in digitale, così come presentazioni, relazioni di PCTO, tesine, elaborati multimediali. Pretendere che all’esame finale tutto questo venga dimenticato, per tornare alla penna e al foglio protocollo, significa introdurre una frattura artificiale tra ciò che si fa in classe per cinque anni e ciò che si chiede nell’ultimo, decisivo passaggio.
Non è una questione tecnica, ma culturale: la scuola deve allinearsi al mondo che i ragazzi già abitano.
Il colloquio orale è forse la parte che più tradisce il senso della parola “maturità”. Oggi si riduce ad uno spezzatino di domande disciplinari, con collegamenti forzati e spesso banali tra materie, che raramente vengono trattati nel percorso ordinario. In questo modo si produce un artificio retorico e ipocrita, che non misura la maturità dello studente, ma soltanto la sua capacità di ripetere nozioni frammentarie.
Il colloquio dovrebbe invece essere un momento unitario, capace di mostrare non solo le conoscenze, ma anche le competenze trasversali: la chiarezza espositiva, la capacità di argomentare, di fare sintesi, di collegare in modo personale esperienze scolastiche e non scolastiche.
In questo quadro si potrebbe valorizzare davvero il “capolavoro” che gli studenti sono già tenuti a realizzare: un elaborato o un prodotto che rappresenti la sintesi del loro percorso, delle competenze e delle passioni coltivate. Portare questo “capolavoro” al centro del colloquio significherebbe dare senso all’esame, permettere ai ragazzi di raccontarsi e di dimostrare maturità non come somma di nozioni, ma come capacità di costruire la propria identità culturale.
Infine, il rapporto tra percorso ed esame va ribaltato. Oggi l’impianto normativo attribuisce troppo peso alla performance finale, come se cinque anni di studio potessero essere annullati da una giornata storta. È una concezione ingiusta e pedagogicamente fragile. Il percorso deve valere di più, fino a determinare la sufficienza, mentre l’esame dovrebbe avere funzione di verifica conclusiva e di coronamento, non di ghigliottina. Solo così si responsabilizzano gli studenti nel tempo lungo, si valorizza il lavoro costante e si restituisce dignità alla funzione formativa della scuola.
Nell’estate 2025 alcuni studenti si sono presentati all’orale scegliendo volutamente di restare in silenzio: volevano dimostrare che, con i punteggi già accumulati, il diploma era comunque assicurato. Un gesto provocatorio, che ha messo in luce il vero problema: se la scena muta è possibile senza conseguenze, significa che il sistema dei punteggi ha svuotato di senso la prova orale. La risposta ministeriale, arrivata con questa nuova “riforma”, dispone la bocciatura. Ma un approccio del genere rischia di confondere i piani: il problema non sono i ragazzi che hanno voluto segnalare una stortura, bensì il meccanismo che rende possibile trasformare l’esame in un calcolo aritmetico. Non è con la punizione che si restituisce valore al colloquio, ma ridisegnandolo, perché diventi davvero un momento di crescita e di sintesi del percorso.
Riformare davvero la maturità significa, dunque, restituirle il suo senso: non un ostacolo burocratico, non una somma di frammenti disciplinari, ma un passaggio che valorizza il percorso, responsabilizza i docenti e mette al centro gli studenti. Tutto il resto rischia di restare maquillage normativo, utile per qualche titolo di giornale ma incapace di incidere sul futuro dei ragazzi.
In fondo, se volessimo davvero cambiare la maturità, le linee guida sarebbero semplici:
- Commissione interna con presidente esterno: chi conosce i ragazzi li valuta, chi garantisce terzietà vigila.
- Le prove. Due scritti: il primo scritto nazionale di italiano, per verificare le competenze linguistiche, argomentative e critiche, ma con attenzione a differenziare le tracce a seconda del percorso di studi. Il secondo scritto di indirizzo, per testare le competenze specifiche del profilo in uscita. In tutti i casi, possibilità di utilizzare la scrittura digitale e strumenti idonei alle competenze da dimostrare. Un colloquio orale unitario, centrato sul “capolavoro” dello studente e capace di intrecciare i saperi disciplinari con le competenze trasversali. Non interrogazioni in sequenza, ma un confronto che faccia emergere anche le competenze non cognitive.
- Più peso al percorso che alla performance finale: cinque anni devono contare più di pochi giorni. Invertire i crediti (60 punti al percorso e 40 all’esame) sarebbe la soluzione più sensata.
Solo così l’esame tornerebbe a essere ciò che promette il suo nome: una prova di maturità, non un rito burocratico.
*già dirigente scolastica, autrice e formatrice.
© RIPRODUZIONE RISERVATA














Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via