
Stili genitoriali e scuola

di Giovanni Cogliandro* e Chiara Pazzaglia**
Lo stile educativo nel tempo è notevolmente cambiato e insieme ad esso gli studi pedagogici e delle neuroscienze hanno portato notevoli evidenze scientifiche nel modo di interpretare l’educazione. Gli approcci educativi e disciplinari considerati validi fino a pochi anni fa, sono stati ritenuti inefficaci e per giunta deleteri per un sano sviluppo psicofisico dei bambini.
Andando nel dettaglio possiamo riscontrare come l’educazione messa in atto dalla società del secolo precedente si basava su un clima di rispetto assoluto verso la figura adulta. Il bambino veniva visto come un contenitore da riempire di nozioni e informazioni al fine di trasformarlo in un adulto capace di essere, senza il bisogno di chiedere. La disciplina ricorreva ad un sistema di regole severe, l’adulto comandava sul bambino con un approccio inflessibile che non prevedeva cedimenti, altrimenti visti come segno di debolezza. I bambini dovevano obbedire senza se e senza ma, con un “si fa così e basta”. Non c’era spazio alla protesta, al poter esprimere i propri sentimenti o la propria idea in disaccordo a quanto era stato detto e stabilito. I bisogni dei bambini non venivano messi in primo piano e con essi anche le emozioni. L’educazione di tipo autoritario basata sulle regole, sul controllo e sulla punizione prevedeva che se il figlio sbagliava riceveva lo schiaffo o la sculacciata “educativa” e magari si finiva anche a letto senza cena.
Il fondamentale tratto umanistico della Scuola la indirizza invece ad essere luogo di benessere, oltre l’utilitarismo e il normativismo, attuando un’etica di stile eudaimonistico propria di una pedagogia ricca di empatia, un luogo di relazioni che si proietta verso un nuovo umanesimo, per non cadere sotto gli attacchi della crescente barbarie nelle relazioni dentro e fuori le famiglie.
La gestione del sistema scolastico dovrebbe a nostro parere scoprire sempre di più la centralità della dimensione del benessere che può andare a caratterizzare lo stile educativo di ogni comunità scolastica e – fatto forse innovativo – lo stile genitoriale delle famiglie che fanno parte di questa stessa comunità. La creazione di uno stile genitoriale focalizzato sul benessere degli studenti è allo stesso tempo presupposto e punto d’arrivo: è necessario un intenso lavoro sugli aspetti delle relazioni e della comunicazione interpersonale affinché si stabilizzi un clima positivo che sappia restare saldo al sopraggiungere di imprevisti.
Esemplarismo e genitorialità
Nel 1998 l’American Academy of Pediatrics si discosta dalla pratica delle cosiddette “sculacciate” come pratica educativa: la tesi supportata è che non si possa correggere un comportamento sbagliato con un altro comportamento sbagliato. Vi è un profondo connotato esemplarista in questo, ovvero che non si può insegnare ai bambini a non usare la violenza quando l’esempio insegna l’opposto.
Gli studi effettuati dai pedagogisti e dai neuroscienziati hanno evidenziato come un’educazione basata sulla prevaricazione comprometta innanzitutto il rapporto tra genitori e figli, in secondo luogo non permetta al bambino di capire il comportamento sbagliato producendo in lui solo sentimenti di inadeguatezza, frustrazione, vergogna, tristezza e incentivando paura, bassa autostima e una comunicazione assertiva basata sulla mancanza di dialogo ed empatia. Lo stile genitoriale autorevole ha generato nelle nuove generazioni di genitori uno stile educativo che proponga l’opposto di quello che hanno subito. Perciò, è stato intrapreso uno stile educativo permissivo dove i figli sono liberi di poter fare quello che ritengono sia appropriato per loro, senza limiti o regole. I genitori si comportano come amici per i loro figli non capendo che essi hanno il bisogno di una guida che sia accogliente ed empatica ma che allo stesso tempo li accompagni nella strada della vita. Questa tipologia di stile educativo evita ogni forma di conflitto, perché i genitori che attuano ciò non hanno imparato né ad affrontare il conflitto attraverso il dialogo, in quanto non era consentito lo scambio di opinione, né a stare all’interno del conflitto con tutte le emozioni che ne scaturiscono.
Al riguardo giova ricordare velocemente quanto alcuni filosofi morali negli ultimi anni hanno affermato in tema di etica delle virtù e di psicologia positiva, sull’importanza delle figure esemplari, quindi provare a incrociare la tematica del paternalismo liberale, moderato o meno, con la ricerca contemporanea in tema di esemplarismo morale. Quest’ultima potrebbe fornire alcune linee di condotta fondate su psicologia morale e pedagogia non oppressiva ma promozionale che potrebbe utilmente integrare la riflessione con una concezione di flourishing come scopo della società repubblicana che voglia concretamente sottrarsi a logiche di dominio.
Nel contesto attuale di deprivatizzazione dell’esperienza comunitaria ben descritto tra i pensatori viventi in particolare da Taylor[1] e Habermas[2] è possibile descrivere l’esperienza sociale a partire da alcuni effetti connessi, includendo nella descrizione disposizioni del carattere come l’umiltà e la compassione che appaiono connesse tra di loro, contribuendo a una analisi multilivello delle possibilità di piena realizzazione (fioritura, eudaimonia) del soggetto stesso anche quando in maniera solo apparentemente paradossale comportano un abbassamento di sé. Si inserisce qui in maniera potente la recente questione dell’esemplarismo che ha riproposto Zagzebski nel suo ultimo libro, classificando santi saggi ed eroi come i tre tipi di esemplari più rilevanti per una morale basata sulla mimesis di esistenze eccelse[3]. Zagzebski, che si è dedicata allo sviluppo dell’etica delle virtù, sviluppa la sua teoria morale a partire dall’emozione dell’ammirazione, usando esempi che mostrano una linea di condotta da seguire, sfuggendo alle logiche di dominio. L’ammirazione è strumento fecondo di pratica scolastica al primo ciclo per l’apprendimento esemplare che vada ad integrare la trasmissione di conoscenze fornendo un completo strumentario di cittadinanza ai giovani allievi.
Diventare genitori
Diventare genitori non è facile, si impara attraverso l’esperienza di vita, crescendo insieme ai propri figli. Innanzitutto, dobbiamo accettare e comprendere che la nostra identità si ribalta: da figli diventiamo genitori. Diversi studi hanno constatato come la miglior strategia da intraprendere in questo percorso di vita è la disciplina dolce o educazione gentile. Essa non è né permissiva o lassista né tantomeno autoritaria. Si tratta di un tipo di educazione autorevole dove l’educazione non viene vista come una destinazione ma come un viaggio da intraprendere “mano nella mano”. Questa tipologia di approccio pedagogico si basa sull’empatia, sull’ascolto, sull’accoglienza e l’accettazione incondizionata, sulla collaborazione e una guida positiva. Il genitore pone dei limiti e delle regole chiare e coerenti, ma le spiega con amorevole fermezza accettando il punto di vista del bambino, ascoltandolo e accompagnandolo nel trovare una decisione condivisa. Il genitore si pone come figura accogliente, non umiliando ma incoraggiando e valorizzando il proprio figlio. La disciplina dolce parte dall’assunto che il bambino è nel pieno del suo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo.
Emozioni ed educazione gentile
Il bambino non fa i capricci per fare un dispetto, ma è il suo modo di comunicare ciò che sente. Questo tipo di approccio richiede impegno, amore, costanza, pazienza, delicatezza. Aiutare il bambino a dare un nome alle sue emozioni, canalizzarle nella giusta direzione senza farsi male o far del male agli altri. Accompagnare il bambino alla scoperta di sé e del mondo circostante aiutandolo a trovare soluzioni invece di imporre le proprie, valorizzando le sue conquiste e costruendo in tal mondo la sua autostima. Facendogli apprendere il motivo del perché una determinata azione si possa eseguire o meno, interiorizzando le regole non per paura della punizione ma perché condividano il pensiero del genitore. È stato osservato come urla incentivino altre urla, il fuoco del genitore alimenti il fuoco del bambino. Riteniamo che un utile antidoto a questa escalation antieducativa si possa instaurare con pratiche pedagogiche che i docenti testimoniano ai genitori
A Scuola si apprende infatti una cittadinanza non solo politica, ma anche morale ed estetica, intese quali riferimenti ineludibili delle sfaccettature di un’antropologia che non può essere ridotta alla cittadinanza digitale oggi tanto – forse troppo – valorizzata nel dibattito politico e pubblico in generale. Riteniamo invece sia necessario tornare ad analizzare le domande fondamentali derivanti dall’interrogazione filosofica, quali la domanda sul bene, sul giusto, sul bello.
Essere genitori è essere porto sicuro, creare armonia, dialogo e spazio dove essere ciò che si è, dove poter esprimere le proprie emozioni e i propri pensieri senza essere giudicati. Significa essere il modello dal quale i figli apprendono tramite l’esempio; inoltre significa abbassarsi alla loro altezza, esserci e accompagnargli alla scoperta del mondo. L’educazione gentile è lo stile genitoriale più adeguato allo sviluppo psicofisico del bambino e quindi del futuro adulto. Questo tipo di disciplina permette di acquisire autostima, permette di apprendere tramite l’esempio l’importanza del mettersi in ascolto, del capire le necessità dell’altro, di dialogare e trovare un accordo. Consente di arrivare consapevolmente a delle scelte e di saper legittimare le emozioni che si proveranno durante tutta la vita.
* Dirigente Scolastico IC “W. A. MOZART”
** Educatrice, Counselor e Formatrice
[1] C. Taylor, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009.
[2] J. Habermas, Verbalizzare il sacro. Sul lascito religioso della filosofia, Laterza, Roma-Bari 2015.
[3] L. Zagzebski, Exemplarist Moral Theory, Oxford University Press 2017.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


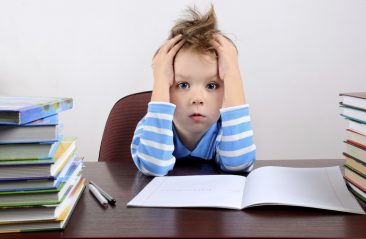






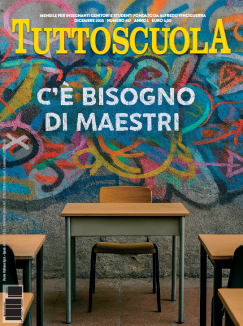




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via