
La necessità dell’arte durante tutto l‘arco della vita

Di Clara Rech*
La recente vittoria del partito laburista nel Regno Unito vedrà un importante cambiamento nel curricolo scolastico, come annunciato dalla ministra dell’istruzione Bridget Phillipson fin dalla presentazione del programma di governo. Ci si riferisce, in modo specifico, alla previsione di introdurre nel curricolo obbligatorio fino a 16 anni le discipline arte, musica e teatro. Il rafforzamento dell’asse umanistico e, in particolare, delle aree che maggiormente chiamano in causa la creatività, si prefigge di garantire una preparazione più armonica e completa a tutti gli studenti, non solo a quelli le cui famiglie possono affrontare i costi di discipline extracurricolari. Oltre a rispondere ad una istanza di equità, il Paese, quindi, potrà contare su giovani più preparati ad affrontare le sfide complesse del mondo attuale.
I giovani del Regno Unito avranno a disposizione maggiori chiavi di lettura per decifrare il passato e vivere il presente preparandosi al futuro non solo perché in possesso di conoscenze più ampie ma, soprattutto, perché la scienza ha provato che le discipline afferenti all’arte attivano entrambi gli emisferi cerebrali, quello sinistro che regola le funzioni razionali e il linguaggio, e quello destro specializzato nel pensiero creativo, nelle emozioni e nell’intuizione. In tal modo si è predisposti in modo più attivo alla comprensione anche di altri ambiti disciplinari.
La decisione del nuovo governo inglese trova affinità e sostanza nella moderna branca delle neuroscienze definita “neuroestetica”[1], che indaga in modo scientifico i processi che regolano la produzione e la percezione del prodotto artistico – in campo visivo ma anche musicale – con i suoi correlati neurali ed esperienziali.
Che forme e colori possiedano la capacità di attivare processi mentali è cosa ben nota fin dal passato perché è un dato che rientra nell’esperienza di ciascuna persona, come pure lo studio dei meccanismi che sottostanno a questi processi; basti qui il richiamo ampiamente noto agli scritti di Leonardo in cui si indaga il processo visivo in base al quale si percepiscono le modificazioni delle proporzioni, la natura dei colori, le luci e le ombre. Riflessioni tutte che rendono la pittura del sommo maestro del tutto innovativa al suo tempo.
Più di recente, un artista come Van Gogh e, dopo di lui, gli artisti espressionisti, hanno colto, valorizzato e verbalizzato al massimo le proprietà simboliche insite nei colori, specie se potenziate dall’associazione alle diverse forme. Per giungere al pittore che forse più di ogni altro ha indagato l’essenza profonda di forme e colori perché ha ricondotto l’arte ai suoi costituenti primari: colore, linea, punto, superficie (meglio, “su” superficie, come titola un suo testo fondamentale del 1926), vale a dire Wassily Kandinskij, come dimostrò nel Primo acquerello astratto del 1909.
Quell’anno nasceva l’arte che sarebbe più corretto definire “non figurativa” più che astratta, dal momento che non si stacca dalla realtà ma, anzi, ne riproduce gli elementi di cui “tutta” la realtà è costituita e, contemporaneamente, non raffigurando nessun oggetto, è libera di rappresentarli tutti.
Grazie a questa intuizione rivoluzionaria, Kandinskij comprese l’enorme potenza della forza dell’arte. L’artista aveva creato un campo infinito, privo di qualunque steccato e barriera, tecnica come culturale. Come tale, l’opera acquistava valore universale, inclusivo di ogni specificità e di ogni particolarità.
Infatti, quanto più in un’immagine diminuiscono i “significati”, tanto più se ne amplia a dismisura il “senso” e la possibilità che ogni persona possa vivere l’esperienza dell’arte in modo personale e profondo. In ogni momento la stessa persona, a seconda del suo stato psichico, può cogliere significati diversi nell’infinità semantica dell’opera. Si stabilisce così un nesso continuo tra artista, opera e “spett-attore”, nel senso che quest’ultimo ha un ruolo attivo. Nel momento in cui l’immagine interagisce con l’interiorità – l’inconscio di Freud teorizzato in quegli stessi anni – ogni individuo reagisce in modo proprio. La strada dell’associazione arte-psiche, come due sfere che si stimolano a vicenda, era ufficialmente aperta.
La psicologia della forma indagata dall’artista trova fondamento nelle ricerche sulle forme elementari quali il triangolo, il cerchio e il quadrato associate, rispettivamente, ai tre colori primari rosso, blu e giallo. A riprova di questa visione integrale e complessa dell’arte, è interessante il parallelismo che Kandinskij istituisce tra immagine visiva e musica, giungendo a titolare le sue opere “impressioni” e “improvvisazioni” proprio perché l’arte è un unicum in grado di far nascere il “suono interiore”.
La comprovata capacità dell’arte di indurre benessere in modo del tutto inclusivo, perché aperta a tutti, oltre ogni barriera culturale, ha un suo fondamento nell’essere attività gratuita, non finalizzata a nessuna utilità pratica ma solo alla stimolazione del piacere che la contemplazione della bellezza comporta. L’esperienza dell’arte inoltre favorisce l’interazione sociale e la costruzione di relazioni, rispondendo ad un bisogno costituivo della natura umana. Valendosi della capacità dell’esperienza artistica di ridurre lo stress e indurre emozioni positive che favoriscono il benessere dell’individuo e la sua crescita vitale, negli ultimi decenni molti musei hanno dato vita a progetti sperimentali, soprattutto in area anglosassone ma anche in Italia.
Parimenti, per la riprovata efficacia dell’arte sulla psiche in termini di riduzione di vari disturbi e patologie mentali come la depressione e l’Alzheimer, è ormai prassi consolidata che molti reparti ospedalieri di terapia intensiva, di pediatria e di oncologia offrano ai pazienti ambienti in cui possano fare esperienze artistiche visive e musicali, riscontrando molteplici effetti positivi su molte aree e facoltà cerebrali, come il recupero della memoria e la riduzione dell’ansia. Talvolta si è arrivati anche a prescrivere visite reiterate ai musei per contrastare depressione e ansia, esattamente come si prescrivono i farmaci.
Per tornare al punto di partenza, da quanto si è fin qui detto, risalta come sia lungimirante una politica scolastica che enfatizzi l’apporto dell’arte sia per il portato culturale in sé, sia come chiave metodologica da applicare allo studio di altre discipline: è ampiamente sperimentato che veicolare contenuti disciplinari attraverso immagini visive o con accompagnamenti musicali ne facilita la comprensione e la memorizzazione.
Dunque, il potenziamento delle discipline artistiche può garantire enormi benefici nel processo di apprendimento in tutti i livelli scolari, dall’infanzia all’istruzione secondaria, compresa quella per gli adulti, fino alla formazione terziaria e, ben vedere, anche oltre: per stare bene durante tutto l’arco della vita, la persona ha necessità di non smettere mai di imparare e l’arte è un fenomenale alleato per l’innesco di questo processo vitale. Un farmaco quanto mai piacevole da assumere e con plurimi e benefici effetti collaterali.
*Presidente ANISA aps e Dirigente scolastica
[1] Per un inquadramento di sintesi, cfr. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2019.00739/full
© RIPRODUZIONE RISERVATA

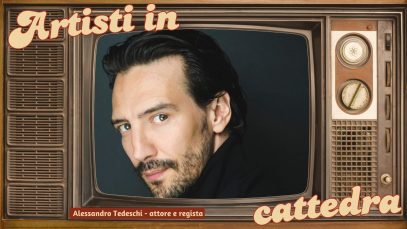
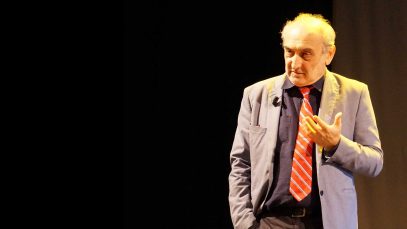
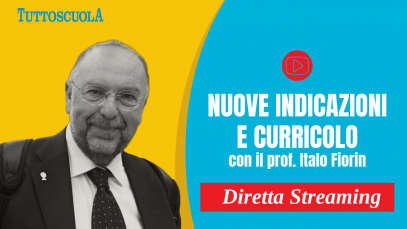




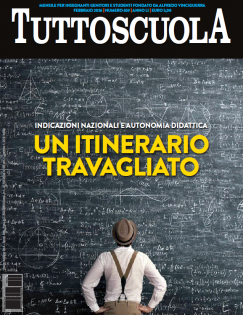




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via