
Neet, abbandono scolastico e disuguaglianze sociali: le conseguenze della pandemia nel rapporto dell’Istat

La pandemia rischia di aggravare il quadro complessivo dell’istruzione italiana. Ad affermarlo è l’Istat che, anche nell’ottava edizione del rapporto sul benessere equo e sostenibile (Bes), dedica un corposo capitolo all’istruzione e alla formazione. I numeri non lasciano spazio a dubbi, In Italia, nonostante i miglioramenti conseguiti nell’ultimo decennio, non si è ancora in grado di offrire a tutti i giovani le stesse opportunità per un’educazione adeguata. Basta guardare cosa è accaduto durante l’emergenza da Covid 19. Con il passaggio dalle lezioni in presenza alla DAd durante il primo lockdown, l’8% dei bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado è rimasto escluso da una qualsiasi forma di didattica a distanza. Una quota che sale al 23% tra gli alunni con disabilità. Risultato: la chiusura delle scuole per contenere il diffondersi della pandemia hanno acuito le disuguaglianze.
Ancora troppi i NEET e i ragazzi che escono precocemente dal sistema di istruzione e formazione
Secondo quanto riportato dal rapporto dell’Istat, la quota di coloro che non studiano e non lavorano, i neet appunto, tra i giovani di 15-29 anni rimane alta e ritorna a crescere, dopo alcuni anni di diminuzioni, fino a interessare il 24% di giovani nel secondo trimestre 2020 (era il 21,2% nel secondo trimestre del 2019). Incide particolarmente la componente dovuta all’inattività, specie nelle regioni del Centro-Nord, dove la ricerca di lavoro ha subito una brusca interruzione dovuta alla pandemia di Covid 19.
Altrettanto alta è la quota di giovani che abbandonano l’istruzione e la formazione dopo aver conseguito al più il diploma di terza media. Nel secondo trimestre 2020, in Italia, il 13,5% dei giovani tra 18 e 24 anni ha abbandonato scuola e università, valore che risulta stabile rispetto al secondo trimestre del 2019.
Il fenomeno dell’uscita dal sistema di istruzione e formazione preoccupa l’Istat, soprattutto, in termini di disuguaglianze. Attraverso l’esame dei dati del 2019, con i quali è possibile avere una fotografia delle caratteristiche di chi lascia la scuola prematuramente, emerge come la prosecuzione nel percorso formativo, le competenze apprese e le scelte successive sono determinate ancora in maniera elevata dal contesto socio-economico di provenienza.
Le competenze dei ragazzi diseguali per estrazione sociale
La dispersione scolastica è soltanto la punta di un iceberg. La difficoltà di alcuni ragazzi/e a proseguire in maniera soddisfacente il percorso scolastico e formativo inizia precocemente all’interno della scuola e i livelli di competenza sono influenzati in maniera diseguale da alcune caratteristiche: genere, cittadinanza, condizione socioeconomica e culturale della famiglia. Le competenze inadeguate si perpetuano negli anni e influenzano la scelta del percorso scolastico, l’apprendimento e, in ultimo, la decisione di abbandonare la scuola. Nell’anno scolastico 2018/19 la quota di ragazzi del secondo anno delle scuole di secondo grado, che non hanno raggiunto un livello di competenza alfabetica sufficiente, è stata del 30,4%, con variazioni molto ampie sul territorio, passando dal 41,9% nel Mezzogiorno al 20,7% nel Nord (Figura 7). Le disuguaglianze sono ampie anche per genere, classe sociale e cittadinanza, con il 34,4% di insufficienti nelle competenze alfabetiche tra i ragazzi contro il 26,3% tra le ragazze; il 54,2% tra i ragazzi stranieri. Inoltre, la quota di insufficienti è più elevata tra gli studenti degli istituti professionali (66,7%) che tra gli studenti dei licei (16%). La competenza matematica inadeguata riguarda un collettivo di ragazzi più ampio (37,8% in media in Italia) e ricalca le caratteristiche emerse nelle competenze alfabetiche, con un’unica differenza per il genere (Figura 8): in matematica le ragazze non hanno raggiunto livelli sufficienti nel 42,2% dei casi mentre i maschi nel 33,5%.
Al netto dei fattori fin qui emersi , è interessante analizzare quali altri stimoli possano essere protettivi rispetto al rischio di non raggiungere un livello di competenze adeguate nelle due materie quali: avere a disposizione nella propria abitazione libri, una connessione internet e un pc; aver frequentato la scuola dell’infanzia; parlare in casa prevalentemente italiano piuttosto che un’altra lingua. In particolare, poter contare su una ricca presenza di libri in casa (più di 100), a parità di altre condizioni, si associa ad una probabilità di raggiungere competenze sufficienti 2 volte e mezzo più alta rispetto a non aver a disposizione libri o averne meno di 25. L’effetto protettivo della frequenza alla scuola dell’infanzia è più debole ma comunque significativo, con un 34% di probabilità in più tra chi è andato alla scuola dell’infanzia di avere competenze adeguate rispetto a chi non l’ha frequentata. Parlare in famiglia in italiano anche per gli scambi quotidiani facilita le competenze (63% in più rispetto a chi parla abitualmente una lingua diversa dall’italiano). Possedere un pc e una connessione ad internet aiuta nello sviluppo di competenze: 59% di probabilità in più rispetto a chi non ha una connessione e un pc. Tra i ragazzi che provengono da famiglie svantaggiate è interessante notare come poter utilizzare un pc e una connessione di rete faccia aumentare la probabilità di avere competenze adeguate (69%).
Le nuove sfide della didattica a distanza: connessione a internet, disponibilità di pc e competenze digitali
Nel 2020 il percorso scolastico dei ragazzi ha subito una delle più profonde e improvvise trasformazioni, passando da una didattica totalmente in presenza a una a distanza per gli ultimi mesi dell’anno scolastico 2019/20 e a una didattica mista (prevalentemente a distanza per i ragazzi delle scuole superiori di secondo grado) nei primi mesi dell’anno scolastico 2020/21. Diventa quindi ancora più importante avere a disposizione una buona connessione e un pc o dispositivo elettronico per poter interagire con la scuola e con gli insegnanti. L’indagine Istat sull’integrazione degli alunni con disabilità nella scuola statale e non statale, a cui hanno risposto le scuole nell’anno scolastico 2019/20, ha evidenziato come gli istituti scolastici si siano attrezzati in varie forme di didattica a distanza, ma nonostante gli sforzi delle istituzioni scolastiche, dei docenti e delle famiglie, l’8% dei bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado è rimasto escluso da una qualsiasi forma di didattica a distanza e non ha preso parte alle video-lezioni con il gruppo classe, quota che sale al 23% tra gli alunni con disabilità. In questa fase molto particolare della didattica avere a disposizione la connessione e il pc, oltre ad essere un fattore predittivo fondamentale per un adeguato sviluppo di competenze, diventa un requisito per l’accesso all’istruzione. L’impatto della didattica a distanza e della chiusura delle scuole ha, quindi, inciso su una popolazione di studenti percorsa già da profonde disuguaglianze di opportunità e, nonostante le politiche nazionali e locali, gli sforzi delle istituzioni scolastiche, dei docenti e delle famiglie, gli effetti sulle competenze e sull’abbandono scolastico, soprattutto nelle fasce più vulnerabili della popolazione, potrebbero essere particolarmente gravi. Oltre alla disponibilità di dispositivi informatici, la improvvisa e necessaria introduzione della didattica a distanza si è scontrata con le difficoltà nelle competenze digitali della popolazione italiana, che presenta una delle situazioni peggiori in Europa. Nel 2019, tra gli individui di 16- 74 anni, soltanto il 22% ha dichiarato di avere competenze digitali elevate (contro il 31% nella Ue27), cioè di essere in grado di svolgere diverse attività nei 4 domini dell’informazione, della comunicazione, nel problem solving e nella creazione di contenuti. La maggioranza degli individui è in possesso di competenze basse (32%) o di base (19%), mentre il 3,4% ha competenze praticamente nulle e il 24% dichiara di non aver usato internet negli ultimi 3 mesi. L’età rimane un fattore importante: i giovani di 20-24 anni hanno livelli avanzati di competenze nel 41,5% e i ragazzi di 16-19 anni nel 36,2% mentre la quota diminuisce all’aumentare dell’età e arriva al 20,3% tra le persone di 45-54 anni e al 4,4% tra le più anziane di 65-74 anni.
Nell’agenda per le competenze per l’Europa della Commissione europea, uno degli obiettivi è quello di avere, entro il 2025, 230 milioni di adulti, pari al 70% della corrispondente popolazione dell’Ue, con un livello almeno base nelle competenze digitali. Questo obiettivo è stato per ora raggiunto soltanto nei Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Germania e Danimarca; l’Italia, con il 42% di persone con competenze elevate e di base, si pone al terzultimo posto in Europa.








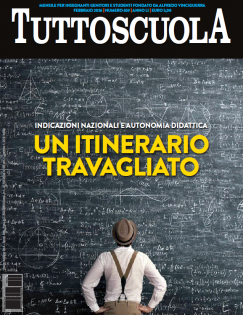




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via