
Voto in condotta: si torna all’antico/2
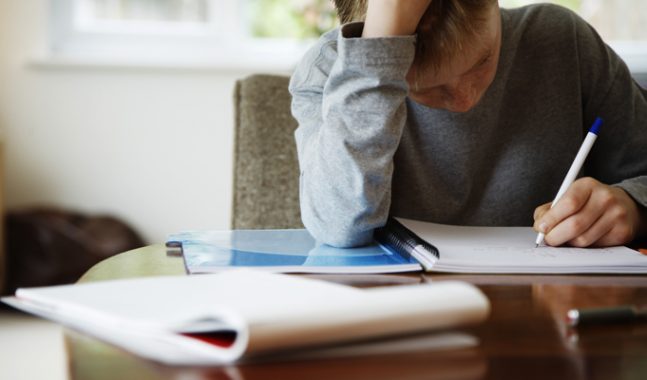
Con i patti educativi di comunità si è cercato di calmierare certe intemperanze o difficoltà di comunicazione, facendo in modo che i diversi soggetti assumessero precise responsabilità, anche in solido, rispetto a danneggiamenti che si potevano produrre. Pur volendo in qualche modo ripristinare i tempi favorevoli alla collaborazione attraverso la formula più impegnativa del patto, non si sono ottenuti i risultati sperati e nel frattempo è andato peggiorando il clima tra gli adulti e sono riprese le occupazioni degli edifici da parte degli allievi, quando assemblee e autogestioni avevano realizzato momenti costruttivi e arricchenti.
Con lo statuto degli studenti e delle studentesse si era arrivati al massimo della promozione della cultura democratica nella comunità scolastica, si sono messi nero su bianco i diritti dei giovani nella scuola, si sono trasformate le punizioni escludenti in doveri responsabilizzanti, in modo che anche in momenti delicati non venisse meno lo spirito inclusivo, con lo sganciamento del comportamento dal rendimento scolastico, in modo che ciascuno potesse godere del proprio trattamento personalizzato.
Patto e statuto non hanno avuto la necessaria preparazione pedagogica, sono sembrati documenti un po’ burocratici, come siamo abituati a vivere tra le mura scolastiche, e quindi non hanno avuto incidenza; l’atmosfera si era caricata di tensione e spesso si erano allertate le forze dell’ordine di fronte a fatti gravi e i media hanno fatto la loro parte nel sollecitare l’opinione pubblica.
Che fare? Le strade sembravano due: una già sperimentata circa trent’anni fa con il “progetto giovani”, che ha comportato una forte iniezione di pedagogia, attraverso un’azione sulle relazioni, sul benessere dei giovani per contrastare il disagio e sull’innovazione didattica, che ha influito anche sui genitori ed ha lasciato in eredità i Centri di Informazione e Consulenza che ancora oggi potrebbero vedere la presenza di docenti particolarmente formati e di professionisti esterni. L’altra strada è quella intrapresa di ripristinare le punizioni, mediante una profluvie di norme di carattere securitario recentemente emanate, che non solo cerchi di inibire i comportamenti devianti con sanzioni di carattere economico o penale, per quanto riguarda le azioni più gravi da parte di giovani o adulti perseguibili, ma venga usata come forma di ricatto sul versante del percorso scolastico. Ritorna il voto di condotta, anche se era sparito per poco tempo, con le conseguenze sulle bocciature, e le sospensioni, mutuando dallo statuto, prevedono i lavori socialmente utili dentro o fuori la scuola. E’ lo stesso che accade ai condannati quale modalità di espiazione della pena alternativa al carcere, quasi che sia la rieducazione l’obiettivo da perseguire al quale si pervenga assimilando la scuola ad un luogo di reclusione.
In queste condizioni c’è il serio pericolo che il muro venga ricostruito ad excludendum e a poco servirà la retorica dei bravi e dei cattivi, perché la scuola non può avere due anime, una educativa e l’altra punitiva; rinvigorire lo spirito costituzionale significa una nuova iniezione pedagogica, un supporto da parte di figure tutoriali, maggiore autonomia per le scuole affinché possano inserirsi nel loro territorio e fare rete con altre realtà educative perché i giovani, ma anche i genitori, si possano sentire all’interno di un ambiente in cammino verso la crescita e lo sviluppo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA













Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via