
‘Orientare significa connettere scuola e lavoro’: il presidente di ADAPT, Matteo Colombo, spiega perché serve una nuova alleanza educativa

In un Paese dove il disallineamento tra formazione e occupazione resta una delle sfide più urgenti, l’orientamento non può essere considerato un momento isolato del percorso scolastico, ma un processo continuo che accompagna i giovani lungo tutto l’arco della loro crescita.
Secondo Matteo Colombo, presidente della Fondazione ADAPT, serve un cambio di paradigma: non più un orientamento “a valle”, che arriva quando le scelte sono già fatte, ma un sistema capace di unire scuola, formazione e imprese in un progetto educativo comune.
Con lui abbiamo parlato del ruolo dell’educazione al lavoro nella scuola italiana, delle politiche per i giovani e della necessità di costruire ponti stabili tra i luoghi dell’apprendimento e quelli della produzione, perché – sottolinea Colombo – “l’orientamento non è una scelta tra opzioni, ma un percorso di senso verso la realizzazione personale e professionale”.
L’orientamento non è solo scelta professionale, ma anche processo formativo e identitario. In che modo la scuola può accompagnare gli studenti in questa direzione?
“L’orientamento oggi non può più essere pensato come un momento isolato in cui si “sceglie cosa fare da grandi”. È, piuttosto, un percorso formativo che aiuta i giovani a conoscersi, a riconoscere le proprie attitudini e a costruire un progetto di vita e di lavoro coerente con sé stessi e con la realtà che li circonda. La scuola, in questo senso, ha un ruolo fondamentale: deve diventare il luogo in cui si impara non solo “cosa” sapere, cosa imparare, che mestiere fare, ma “chi” si vuole essere.
Dalla nostra ricerca, condotta come comitato tecnico-scientifico di OrientaTalenti, emerge chiaramente che la scuola può accompagnare gli studenti in questa direzione se trasforma l’orientamento in un processo continuo e integrato nel curricolo, non in un’attività episodica o burocratica. Serve un orientamento “diffuso”, che attraversi le discipline e che utilizzi metodologie attive e laboratoriali: esperienze in contesti reali, progetti, incontri con professionisti, visite aziendali, momenti di riflessione personale. Sono tutte occasioni che permettono agli studenti di misurarsi con il mondo e di scoprire, nel concreto, come i propri interessi possono tradursi in competenze.
Fondamentale, poi, è il ruolo dei docenti e degli orientatori, che devono essere formati per accompagnare i ragazzi non solo nelle scelte di studio, ma anche nei passaggi di crescita, nei dubbi, nei riorientamenti. L’orientamento diventa così educazione alla scelta, ma anche alla consapevolezza, e si costruisce giorno dopo giorno, con un lavoro corale che coinvolge scuola, famiglie e territorio”.
Nelle vostre ricerche emerge spesso l’importanza di integrare formazione accademica e formazione in contesti di lavoro. Quali modelli europei possono ispirare l’Italia?
“L’Italia ha molto da imparare da alcuni modelli europei che hanno saputo coniugare scuola e lavoro in modo virtuoso, senza contrapporli. Il riferimento scontato va ai Paesi del c.d. “sistema duale”, come Germania, Austria e Svizzera. Qui la formazione è coprogettata e cogestita da enti di formazione e imprese, realizzando non solo una mera alternanza tra luoghi e tempi dell’apprendimento, ma una vera integrazione virtuosa, circolare, tra queste due dimensioni. Più in generale, l’importanza di coniugare formazione e lavoro è diventata un elemento ricorrente in diverse agende di riforma di Paesi europei, penso anche alla Spagna o alla Francia. La stessa Commissione Europea è tornata su questo tema più volte. L’obiettivo non deve essere quello di una strumentalizzazione della formazione a favore del lavoro, che la riduca ad essere una banale anticamera rispetto allo svolgimento di un mestiere; piuttosto, proprio le esperienze dei Paesi citati dicono di una collaborazione paritetica, resa possibile da una governance condivisa e grazie al ruolo decisivo dei corpi intermedi, di sindacati e associazioni di categoria in particolare, chiamati a garantire la qualità e il valore della formazione realizzata in questi percorsi.
Pensando al contesto italiano, non si tratta di replicare, banalmente, esperienze radicate da tempo in contesti diversi dal nostro: ma piuttosto di comprendere che solo grazie alla costruzione di reti a livello locale tra scuole, enti di formazione, imprese, parti sociali e corpi intermedi è possibile progettare percorsi che sappiano rispondere, da una parte, ai fabbisogni delle imprese e, dall’altra, garantire una vera occupabilità e soddisfacenti percorsi di carriera ai giovani. L’integrazione tra formazione e lavoro, in altre parole, non si costruisce “copiando” modelli, ma sviluppando un metodo collaborativo e reti territoriali tra scuola e impresa”.
Il mismatch di competenze è anche culturale, non solo tecnico. Quanto pesa la difficoltà del nostro sistema educativo a valorizzare il lavoro manuale e tecnico?
“Pesa sicuramente molto. Ancora oggi i lavori più manuali sono visti come scelte “di serie B”. E di rimando, più un percorso formativo si avvicina al mondo del lavoro, più è vittima di pregiudizi per cui queste esperienze – penso ai percorsi di formazione professionale, ad esempio – sono destinati a chi non vuole formarsi ma solo un rapido accesso al mondo lavorativo. Questa visione distorta alimenta poi tutta una serie di problemi. Scarsa attrattività di alcuni mestieri, che però dietro gli stereotipi diffusi offrono ottime possibilità professionali; scarsa attrattività di interi segmenti formativi. L’orientamento è spesso parte del problema, riducendosi a strumento utile ad indirizzare, deterministicamente e spesso in base ai voti conseguiti, i giovani verso una scelta e non a formare loro l’autoconsapevolezza utile a decidere come proseguire il proprio percorso di studi o di lavoro. Oppure quando a determinare la scelta è l’indicazione ad evitare di frequentare percorsi per i quali ci si sente portati ma che sono riconosciuti come “inferiori” ad altri. Da qui ha origine anche l’alto tasso di abbandoni scolastici, e i problemi che le pratiche di riorientamento sperimentano nel nostro Paese, così come il disallineamento tra competenze attese e offerte che caratterizza il nostro sistema educativo.
Questi pregiudizi, ancora oggi molto radicati, possono essere contrastati grazie alla condivisione di storie ed esperienze di quei tanti giovani che, scegliendo lavori tecnici, hanno costruito carriere solide e soprattutto gratificanti, corrispondenti ai loro interessi. E soprattutto facendo sperimentare il mondo del lavoro agli studenti e alle studentesse, affinché possano vedere da vicino quei mestieri, incontrare le imprese, capire che la competenza manuale e quella intellettuale possono integrarsi virtuosamente. Solo restituendo dignità e valore culturale al lavoro in tutte le sue forme (e a tutti i percorsi formativi) è possibile costruire un orientamento davvero libero e consapevole”.
Cosa significa oggi “apprendere lavorando”? E come rendere questa dimensione formativa un’esperienza qualificante, non sostitutiva della scuola?
“Significa fare esperienza diretta del lavoro come spazio di conoscenza, di scoperta e di crescita, dove è possibile imparare e non solo mettere in pratica quanto già appreso. Non è, però, un processo automatico: valorizzare la dimensione formativa dell’esperienza lavorativa richiede un’attenta progettazione, incentrata sull’accompagnamento del giovane in azienda, e soprattutto esige che sia integrata in maniera strutturale con il curriculum scolastico, non una parentesi esperienziale all’interno del percorso. L’apprendimento più profondo avviene quando la teoria incontra la pratica, quando ciò che si studia trova applicazione concreta e ritorna alla scuola sotto forma di riflessione e rielaborazione. Esperienze come quelle promosse da OrientaTalenti, mostrano che si può fare. Si tratta di costruire ponti stabili fra scuola e impresa, di investire nella formazione dei tutor aziendali, di utilizzare strumenti digitali per riconoscere formalmente ciò che gli studenti apprendono sul campo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

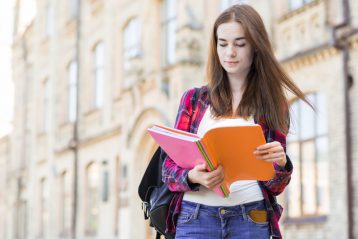











Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via