
Invalsi 2024, uso e abuso dei dati: torniamo ad assumerci la responsabilità di una lettura critica
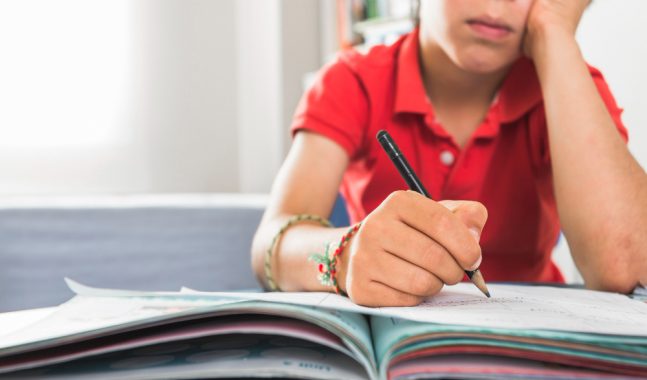
Di Cristiano Corsini
Anche quest’anno, l’appuntamento con la pubblicazione dei dati ricavati dalle rilevazioni INVALSI non regala grandi sorprese rispetto alle precedenti indagini. A livello macroscopico, infatti, a parte lievi scostamenti, si confermano tendenze già riscontrate nel corso degli anni: in generale la scuola primaria evidenzia, rispetto alla secondaria di I e di II grado, un rendimento migliore e iniquità più contenute, con la forbice a svantaggio del mezzogiorno che si amplia col procedere dei gradi scolastici. Aguzzando la vista è tuttavia possibile notare, a livello di dettaglio, conferme e variazioni rispetto alle precedenti edizioni. La classe finale della scuola primaria continua a evidenziare le quote più elevate di studentesse e studenti in grado di raggiungere almeno il livello base nelle prove di Italiano (75%), Matematica (68%) e Inglese (95% Reading, 86% Listening) e mostra un miglioramento generalizzato rispetto allo scorso anno.
Inoltre, la “dispersione scolastica implicita” – che secondo la definizione dell’INVALSI contrassegna le studentesse e gli studenti “che non raggiungono nemmeno lontanamente i livelli di competenza che ci si dovrebbe aspettare dopo tredici anni di scuola” (in pratica: chiunque vada male nelle tre prove) – si attesta al 6,6% e scende per la prima volta sotto il dato del 2019 (7,5%), primo anno di impiego dell’indicatore. La quota di “studenti accademicamente eccellenti” – etichetta che l’INVALSI impiega per indicare chi raggiunge livelli elevati nelle tre prove – si attesta sul 15% (in aumento rispetto agli ultimi anni ma al di sotto del 18,3% fatto registrare nel 2019). In ogni caso, variazioni a parte, sia la “Dispersione implicita” sia la quota di “Studenti accademicamente eccellenti” continuano a evidenziare una notevole eterogeneità nella loro distribuzione geografica. Quest’anno, la quota di “Studenti accademicamente eccellenti” varia tra il 7,8% (Sud e Isole) e il 22,1% (Nord Est), mentre la “Dispersione implicita” passa dal 2,5% del Nord Est all’11,8% del Sud.
Imprescindibilità dei dati INVALSI
Esattamente due anni fa, Carmela Bucalo, allora responsabile scuola per Fratelli d’Italia, tuonava contro le prove INVALSI sostenendo che costassero troppo e che non ve ne fosse bisogno. Fortunatamente, una volta al governo, il partito di Bucalo si è ben guardato dal dare seguito a quanto affermato in campagna elettorale. Fortunatamente: perché per un paese civile ottenere informazioni valide e affidabili sullo stato di salute del sistema d’istruzione è vitale e non v’è dubbio che l’INVALSI a tale scopo offra un contributo fondamentale.
È vero che i dati INVALSI tendono a offrire un quadro pressoché immutabile della realtà scolastica italiana. Come rilevato, gli elementi di invarianza rispetto al passato sono più evidenti delle novità. Sappiamo da più di mezzo secolo, ovvero da quando abbiamo iniziato a partecipare alle indagini internazionali IEA, che i nostri problemi dal punto di vista educativo tendono ad acuirsi col procedere dei gradi scolastici. In particolare, le scuole secondarie di I e II grado fanno registrare rispetto alla primaria lacune più rilevanti nella preparazione di studentesse e studenti e, allo stesso tempo, vedono rafforzarsi il legame tra rendimento e livello socioeconomico della popolazione. Inoltre, sappiamo dagli anni Settanta che esistono differenze significative tra Nord e Sud nelle relazioni tra il punteggio ottenuto alle prove standardizzate e la valutazione data a studentesse e studenti dalle Commissioni degli Esami di Stato al termine della scuola secondaria. Sappiamo anche che sarebbe assurdo pensare di affrontare questa incoerenza modificando i processi valutativi senza prima agire sulle evidenti iniquità di natura sociale ed economica che caratterizzano i diversi contesti.
Il fatto che vi sia una continuità pluridecennale rispetto a questi dati non appare tuttavia un argomento a svantaggio delle prove INVALSI, visto che il problema rilevante non è rappresentato dalla presenza di dati, ma dall’adeguatezza del loro utilizzo dal punto di vista delle politiche scolastiche e dall’accuratezza della loro lettura.
Abuso dei dati INVALSI
Se la polemica sulla necessità dei dati è del tutto immotivata, appare utile riflettere criticamente sulla loro ricezione e sul loro impiego. Da questo punto di vista, va segnalato come nel corso degli ultimi anni si siano fatte scelte poco fondate dal punto di vista pedagogico e scientifico. L’INVALSI nasce un quarto di secolo fa allo scopo di valutare il sistema d’istruzione: in pratica, aveva la funzione di sottoporre alla prova dell’esperienza l’efficacia delle scelte effettuate in tema di politica scolastica. Nel corso degli anni, tuttavia, questa fondamentale funzione di controllo scientifico – rispetto alla quale lo strumento delle prove standardizzate è in effetti quello più adeguato – è passata decisamente in secondo piano. Col procedere del tempo, e in base a precise direttive ministeriali, la valutazione dell’efficacia delle scelte politiche è stata marginalizzata e di fatto sostituita dalla valutazione delle competenze raggiunte da ogni singolo studente e da ogni singola studentessa. E così, vasi di coccio tra vasi di ferro, agli studenti e le studentesse, dopo che per anni è stato ribadito che le prove non avrebbero valutato i singoli individui ma lo stato di salute del sistema (o, al limite, delle scuole), vengono variamente assegnate etichette di “dispersione implicita” o “eccellenza”. Inoltre, dal prossimo anno gli esiti alle prove INVALSI entreranno a far parte del curriculum di studentesse e studenti.
Questo riorientamento dalla valutazione di sistema a quella degli apprendimenti di singoli individui avrebbe richiesto un’autentica rivoluzione metodologica della quale però non v’è alcuna traccia, per cui le categorie di “dispersione implicita” o “eccellenza” sono di dubbia validità. Infatti, se è vero che le prove standardizzate sono valide per ottenere informazioni sulle conoscenze e sulle abilità di fasce più o meno ampie di popolazione, è anche vero che esse mostrano limiti noti da decenni in merito alla capacità di ottenere informazioni sulle competenze di singoli individui. Questo per tre motivi.
In primo luogo, perché le competenze hanno caratteristiche che rendono del tutto insufficiente l’impiego di prove standardizzate ai fini della loro valutazione e certificazione. Le competenze hanno dimensioni cognitive, situate, dinamiche, sociali, metacognitive, attive, emotive. Una cosa è impiegare, con senso della misura, anche delle prove standardizzate assieme ad altri dispositivi valutativi; altra cosa è definire “competente”, “eccellente” o “fragile” un individuo esclusivamente in base ai risultati ottenuti a prove standardizzate.
In secondo luogo, perché le misure raccolte con le prove INVALSI comportano un margine d’errore sicuramente tollerabile su fasce ampie di popolazione ma non sul singolo individuo o sulla singola classe.
In terzo luogo, considerare le prove standardizzate un obiettivo da raggiungere nel corso dell’attività didattica tende a comportare un peggioramento della qualità dei processi di insegnamento e apprendimento.
Analizzare criticamente i dati
Le rilevazioni INVALSI rappresentano un fondamentale elemento informativo per il sistema scolastico. Tuttavia, la preoccupante involuzione verso l’etichettamento individuale rischia di compromettere la loro utilità. Va considerato che tale utilità è stata già messa nel corso degli anni a dura prova da altre scelte discutibili. Tra queste, è utile ricordare la decisione di passare dal campione alla popolazione. Questa decisione per motivi di costi ha comportato un’ipersemplificazione delle prove e in particolare la rinuncia a formulare un numero adeguato di domande a risposta aperta e complessa. Inoltre, se prima era possibile per ogni scuola ottenere informazioni sulle risposte fornite da studentesse e studenti alle singole domande, col passaggio alla somministrazione computer-based e alla secretazione delle prove questa informazione potenzialmente preziosa dal punto di vista didattico è stata sostituita da dati molto più vaghi e imprecisi e non riferibili alle singole domande.
Se vogliamo difendere la portata informativa delle prove INVALSI è necessario riassumersi la responsabilità di una loro lettura critica. Nel 2013, gran parte della comunità scientifica composta da ricercatrici e ricercatori di area metodologico-didattica di diverse università ha indirizzato una lettera pubblica all’allora ministra Carrozza sul rischio di un uso disinvolto di indicatori ottenuti attraverso le prove standardizzate nazionali. Se è vero che quelle preoccupazioni si sono purtroppo rivelate fondate è anche vero che, nel complesso, nel volgere di pochi anni la comunità scientifica sembra avere in buona parte smarrito la competenza e/o il coraggio utili per posizionarsi criticamente rispetto ai dati istituzionali. Si tratta di un’involuzione piuttosto preoccupante. Infatti, un’analisi critica delle indagini valutative apporterebbe benefici a tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dall’INVALSI.
© RIPRODUZIONE RISERVATA









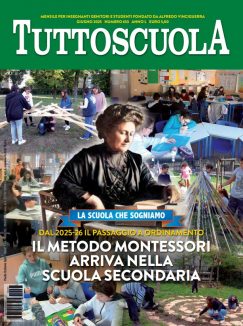




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via