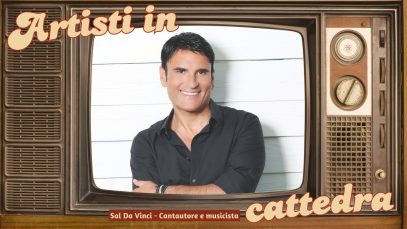
Intelligenza Artificiale, sarà utile se complementare agli insegnanti (ma va cambiata subito la formazione)

Lo straordinario interesse che si è creato in tutto il mondo intorno a ChatGPT e agli altri algoritmi di Intelligenza Artificiale generativa ha contagiato la scuola italiana: sempre più si discute di come l’IA stia cambiando l’insegnamento e anche noi non ci sottrarremo. Due sono gli aspetti su cui concentrarsi: da un lato, le competenze che gli studenti e le studentesse dovranno sviluppare per evitare i rischi di disoccupazione tecnologica legati all’IA; dall’altro, in che misura gli algoritmi dell’IA potranno essere uno strumento utile per le attività di insegnamento dei docenti. Occorre però sottolineare sin dall’inizio come l’attuale sia una fase nuova – e ancora inesplorata – dell’IA.
Fino a fine 2022, infatti, i modelli erano capaci di svolgere attività come il riconoscimento visivo, l’analisi del testo e dei dati: essenzialmente la prima generazione di IA era rappresentata da algoritmi di apprendimento e di classificazione di input esistenti. Tutto questo sta cambiando rapidamente. Le forme di IA generativa, come ChatGpt, Google Bard o MS Copilot, producono contenuti del tutto nuovi (testi, immagini, video, codici, ecc.) grazie a estrapolazioni probabilistiche di conoscenze preesistenti: da questo punto di vista, non sono molto diversi dall’intelligenza umana.
La prima questione da affrontare, quella delle competenze richieste dagli sviluppi tecnologici, non è nuova: già nella prima fase della diffusione dell’IA e dell’automazione industriale ci si è domandati quali cambiamenti avrebbero comportato per le competenze nel mercato del lavoro. La letteratura recente si è chiesta quali siano le competenze umane meno soggette al rischio di sostituzione da parte delle “macchine” e, quindi, su cui l’istruzione deve sempre più puntare per garantire a chi studia opportunità di impiego. In primo luogo, vi è l’intelligenza creativa, ossia la capacità di avere idee originali e brillanti per risolvere un dato problema, seguita dall’intelligenza sociale, ossia l’abilità nell’interazione con le persone, tenendo conto della loro sfera emotiva.
Infine, fra le competenze difficili da sostituire con la tecnologia è stata di recente aggiunta la capacità di prendere decisioni in condizioni di incertezza: fare scelte, generalizzando informazioni scarse, è infatti una delle più straordinarie abilità della mente umana. I lavori privi di queste caratteristiche sono destinati prima o poi a essere soppiantanti dall’automazione, come è già accaduto per le mansioni ripetitive e alcuni compiti manuali sempre uguali a sé stessi; per contro, la prima generazione dell’IA e l’automazione non sono state in grado di sostituire le occupazioni con un forte contenuto intellettivo (ricercatori, insegnanti, consulenti) o, all’altro estremo, quelle che richiedono una forte interazione sociale, come la cura delle persone. Tutto questo potrebbe però cambiare con l’avvento della seconda generazione di IA: l’ambito dei lavori a rischio si sta infatti ampliando, coinvolgendo attività a elevato contenuto intellettuale, come la ricerca di informazioni complesse, l’analisi dei legami fra fenomeni, l‘assunzione di decisioni operative, la comunicazione dei risultati. Questo però non deve suscitare un sentimento “luddista” nei confronti dell’IA. Esiste una chiara complementarità fra intelligenza umana e artificiale: gli algoritmi vanno molto più in profondità nella conoscenza di un tema rispetto a noi umani (pochi conoscono i nomi di tutti i fiumi nel mondo), mentre noi abbiamo una capacità di ragionare assai più varia nei temi e flessibile nei passaggi fra un tema e l’altro.
Una volta apprezzato che intelligenza umana e artificiale possono integrarsi, chiediamoci: come l’IA può essere utilizzata a scuola? Qui siamo all’inizio di un percorso assai lungo e forse contrastato: la reazione al crescente uso di ChatGPT svela il timore dei docenti che l’IA sia destinata a rimpiazzarli o quanto meno a sconvolgere il loro modo di insegnare. Dunque, è probabile che nei prossimi anni si assisterà a una lotta titanica fra chi si oppone all’introduzione di IA nell’insegnamento e chi, invece, ne vede chiaramente i benefici. L’esito non è scontato.
Questo è solo un estratto dell’articolo presente all’interno del
numero di giugno della rivista Tuttoscuola.
Per leggere l’articolo sfoglia la rivista cliccando qui.
Non sei ancora abbonato? Clicca qui e scopri come abbonarti (a partire da 2,50 euro al mese)
Chi è l’autore
Andrea Gavosto
Direttore della Fondazione Agnelli
Di più all’interno dell’ultimo numero di Tuttoscuola
Nidi e sc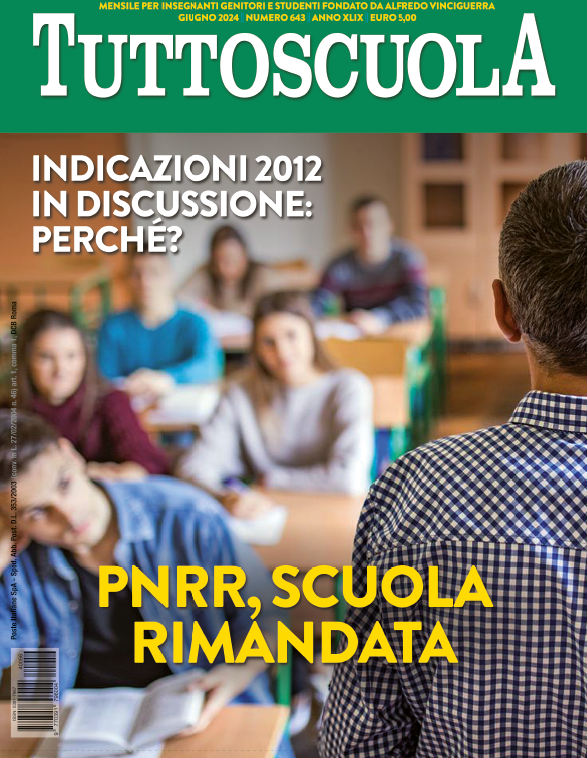 uole dell’Infanzia, ristrutturazione delle scuole, mensa e tempo pieno. E poi ancora: costruzione di nuove scuole, nuovi linguaggi, didattica digitale e divario Nord-Sud. Per ognuno di questi capitoli abbiamo visto lo stato di avanzamento della spesa e provato a capire a che punto siamo. Ma nell’ultimo numero di Tuttoscuola andiamo anche oltre il PNRR. Per esempio parliamo di tempo scuola, autonomia e LEP e delle sfide dell’istruzione correlate alla migrazione. L’ex ministra dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, prova invece a capire quale futuro si prospetta per l’AFAM, mentre Andrea Gavosto prova a capire quanto sarà utile nella scuola l’intelligenza artificiale. Presente il nostro consueto inserto dedicato alla didattica, con articoli di Claudio Girelli, Franca Da Re, Moira Stefini, Carlo Macale, Alessio Moro e tanti altri. Per la rubrica “Gestire la scuola”, Stefano Stefanel parla invece di scuole e di progettazione senza paracadute, mentre Monia Meraviglia, nell’angolo del DSGA, parla invece di nuove incombenze per gli uffici. Un numero da non perdere!
uole dell’Infanzia, ristrutturazione delle scuole, mensa e tempo pieno. E poi ancora: costruzione di nuove scuole, nuovi linguaggi, didattica digitale e divario Nord-Sud. Per ognuno di questi capitoli abbiamo visto lo stato di avanzamento della spesa e provato a capire a che punto siamo. Ma nell’ultimo numero di Tuttoscuola andiamo anche oltre il PNRR. Per esempio parliamo di tempo scuola, autonomia e LEP e delle sfide dell’istruzione correlate alla migrazione. L’ex ministra dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, prova invece a capire quale futuro si prospetta per l’AFAM, mentre Andrea Gavosto prova a capire quanto sarà utile nella scuola l’intelligenza artificiale. Presente il nostro consueto inserto dedicato alla didattica, con articoli di Claudio Girelli, Franca Da Re, Moira Stefini, Carlo Macale, Alessio Moro e tanti altri. Per la rubrica “Gestire la scuola”, Stefano Stefanel parla invece di scuole e di progettazione senza paracadute, mentre Monia Meraviglia, nell’angolo del DSGA, parla invece di nuove incombenze per gli uffici. Un numero da non perdere!
Sfoglia il numero 643 di Tuttoscuola
Abbonati a Tuttoscuola
© RIPRODUZIONE RISERVATA


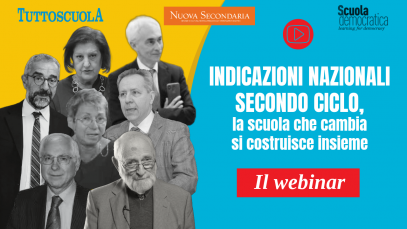





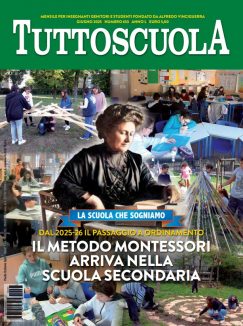




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via