
Divieto di smartphone in classe: ecco perché ci troviamo di fronte a una contraddizione

Con la C.M. 5274 dell’11 luglio 2024, il ministro Valditara ha disposto “il divieto di utilizzo in classe dei telefoni cellulari”. La disposizione ha trovato approvazione e sconcerto in egual misura, come testimoniano gli interventi sulla stampa specializzata e non. Un paio di considerazioni quasi ovvie vanno proposte in via preliminare, riguardo la contrapposizione “repressione vs educazione” (risolta evidentemente a favore della prima) e quella “utilizzo/possesso dello smartphone vs concentrazione ed attenzione in classe” (non occorre scomodare autorevoli studi internazionali per riportare una banale constatazione empirica).
La classe diventa (diverrebbe) così un’enclave, una bolla di security e di salute mentale e cognitiva, mentre tutto intorno (a partire dalle mura domestiche) sono in primo luogo gli adulti a fare un uso smodato e compulsivo dei telefoni cellulari. Nel frattempo la società della conoscenza è impegnata a confrontarsi con la rivoluzione epocale dell’IA che, come è stato osservato, costituisce il terzo balzo, la terza grande trasformazione nella comunicazione e nella produzione di pensiero dopo l’invenzione della scrittura e quella della stampa.
Intanto, centinaia di milioni di euro sono investiti nella scuola italiana, non solo nella formazione alla transizione digitale del personale della scuola (PNRR mis. 2.1, D.M. 66/2023), ma nel dotare le classi delle più fantasmagoriche tecnologie per entrare nella “realtà aumentata” e dintorni (PNRR, Mis. 4.0). Quindi, da un lato facciamo entrare nelle classi i visori 3D – notoriamente di uso comune e quotidiano – mentre dall’altro espelliamo il cellulare, ad ogni evidenza oramai prolungamento cognitivo e articolare di ogni adolescente.
La circolare cita, opportunamente, il documento DigComp 2.2, per ricordarci di non accantonare la didattica digitale, dimenticando che proprio queste linee guida propongono, in più luoghi, l’uso dello smartphone per le due dimensioni fondamentali nella vita di ogni cittadino, lo “scenario d’uso” e lo “scenario di apprendimento”. Riportiamo un paio di indicazioni desunte dai quadri di competenze per i cittadini:
-“utilizzando un’interfaccia di programmazione semplice (ad esempio Scratch Jr), sono in grado di sviluppare una app per smartphone per presentare il mio lavoro ai miei compagni di classe”;
– “È consapevole che alcune applicazioni su dispositivi digitali (ad esempio gli smartphone) possono favorire l’adozione di comportamenti salutari, monitorando e avvisando l’utente sulle proprie condizioni di salute (ad esempio, fisica, emotiva e psicologica). Tuttavia, alcune azioni o immagini proposte da tali applicazioni possono anche avere un impatto negativo sulla salute fisica o mentale (ad esempio la visualizzazione di modelli di corpo “idealizzati” può causare ansia)”[1].
Ma è tutto l’approccio alla conoscenza digitale così come rappresentato dalla dimensione 1 di DigComp 2.2 “Alfabetizzazione su informazioni e dati”, che si fonda proprio su un utilizzo intelligente dello strumento di più comune diffusione. Valutare dati e informazioni e contenuti digitali significa “Analizzare, confrontare e valutare in maniera critica la credibilità e l’affidabilità delle fonti dei dati, delle informazioni e i contenuti digitali. Analizzare, interpretare e valutare in maniera critica dati, informazioni e contenuti digitali”.[2]
Quindi ci troviamo di fronte ad una curiosa contraddizione: educare ad un uso consapevole, attento e sicuro delle informazioni della Rete, tenendo fuori dalle classi lo strumento principale e maggiormente diffuso a livello planetario di accesso alla Rete stessa.
Su questo fronte non solo la scuola italiana è rimasta pressoché inerte nel considerare gli aspetti etici, epistemologici del rapporto fra conoscenza e Rete, ma adesso ne rifiuta il mezzo per educare alla gestione responsabile e consapevole di questa forma di conoscenza diffusa e planetaria.
Infine, mentre ci gingilliamo con visori 3D e aule a realtà aumentata alla “Minority report”[3], le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale e generativa in grado di produrre conoscenza di seconda mano, sulla base dell’elaborazione in tempo reale di milioni di informazioni presenti in Rete, ci offrono oramai quotidianamente (e non è un modo di dire) nuovi prodotti e nuove opportunità sia nel campo degli scenari di apprendimento, che negli scenari d’uso. Ecco, è su questo fronte che occorrerebbe un presidio immediato, informato e innovativo sia rispetto le implicazioni di carattere etico, che rispetto alle capacità di produrre conoscenza, informazione e comunicazione (lettura, comprensione e produzione di testi generalisti e specialistici) . L’IA non va demonizzata o contrastata, ma deve entrare a pieno titolo nei curricula scolastici per educare ad un uso responsabile dello strumento dalle potenzialità ancora in fieri, ma che non deve ridursi a una delega ad uno strumento digitale col rischio di perdere la capacità di discernere tra contenuti veri e contenuti inaffidabili.
In questo scenario in continuo movimento, il divieto dell’uso dei cellulari in classe, se non compensato da un’educazione profonda all’interazione con il digitale in senso lato, e con il mondo della Rete, si riduce ad una vana battaglia di retroguardia che, in ultima analisi, limita l’attuazione e il conseguimento di una cittadinanza piena ed autonoma dell’adolescente nel mondo attuale come riportano le molteplici e dettagliate indicazioni delle aree di DigComp2.2.
Lasciare il cellulare fuori dall’aula significa, molto banalmente, lasciare fuori il mondo degli adolescenti con l’aggravante di circoscrivere, nell’immaginario degli studenti, l’uso del cellulare a funzioni meramente ludico-ricreative e di intrattenimento prive di connessioni con l’apprendimento e l’acquisizione di conoscenza.
La determinazione del ministro, pertanto, pare più figlia di un atteggiamento che di fronte al vorticoso rincorrersi di processi di trasformazione epocali e di notevole complessità, si rifugia in facili scorciatoie dal sapore conservatore, come quando si tenta di contrastare/affrontare il multiculturalismo della società globale con il richiamo velleitario e abbastanza bizzarro al tema dell’identità nazionale.[4]
[1] DigComp 2.2 Il Quadro delle Competenze Digitali per i Cittadini Con nuovi esempi di conoscenze, abilità e attitudini, pp. 34 e 116
[2] Ibidem p. 11.
[3] Si tratta del celeberrimo film del 2002 tratto dall’omonimo romanzo del genio visionario della fantascienza Philip K. Dick’s
[4] Come è noto si tratta della proposta della prof.ssa Loredana Perla, chiamata a coordinare la commissione per la revisione delle Indicazioni nazionali del I ciclo, vedi Galli della Loggia-Perla “Insegnare l’Italia. Una proposta per la scuola dell’obbligo”, Editrice Morcelliana, Brescia, 2023.
© RIPRODUZIONE RISERVATA









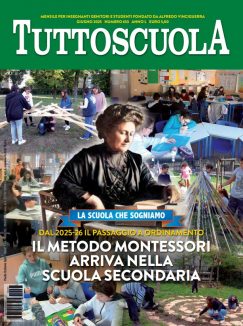




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via