
La scuola che non c’è più

Il sistema scolastico italiano appare oggi come un organismo complesso e stratificato, risultato di riforme parziali che hanno inciso su singoli aspetti senza mai intervenire sull’architettura complessiva del percorso formativo. Curricoli, valutazione e governance sono stati più volte modificati, ma la struttura dei cicli, l’uso del tempo scuola e l’organizzazione degli organici sono rimasti sostanzialmente invariati. Si tratta, in larga misura, di un impianto anacronistico, che aveva una sua coerenza storica quando la scuola media rappresentava un segmento realmente orientato alla preparazione al mondo del lavoro e alla differenziazione precoce dei percorsi. Venuta meno quella funzione, la scuola media ha progressivamente perso identità, trasformandosi in un passaggio formale che non prepara né al lavoro né agli studi successivi. Il risultato è un sistema disomogeneo, segnato da passaggi traumatici, da una dispersione spesso invisibile e da un paradosso sempre più evidente: studenti formalmente diplomati, ma cognitivamente e metodologicamente fragili nel momento in cui accedono all’università, agli ITS o al mondo del lavoro. Una riforma autentica deve, quindi, intervenire non solo su ciò che si insegna, ma su quando, come e con quali risorse professionali lo si fa.
Infanzia più uno: investire precocemente per ridurre le disuguaglianze
Il primo pilastro della riforma riguarda la scuola dell’infanzia, che dovrebbe essere riconosciuta a pieno titolo come parte strutturale del sistema educativo. Il modello “infanzia più uno”, con l’ingresso nel percorso scolastico a sette anni, consentirebbe di rispettare in modo più coerente i tempi di maturazione emotiva, linguistica e cognitiva dei bambini. Un anno aggiuntivo, non scolasticizzato in senso tradizionale, ma orientato allo sviluppo del linguaggio, delle competenze relazionali, simboliche ed espressive, avrebbe un forte valore preventivo.
Allungare il ciclo della scuola dell’infanzia avrebbe, inoltre, un rilevante impatto territoriale e sociale. Consentirebbe di mantenere aperti presidi scolastici che oggi rischiano la chiusura per calo demografico, soprattutto nelle piccole comunità, nelle aree interne e nei contesti urbani degradati. In questi territori la scuola dell’infanzia rappresenta spesso l’ultimo presidio pubblico stabile, un luogo di coesione sociale, di supporto alle famiglie e di contrasto alla marginalità educativa. Rafforzarne la funzione significherebbe non solo investire sull’educazione precoce, ma anche presidiare il territorio, riducendo l’isolamento e prevenendo forme di dispersione che hanno radici sociali prima ancora che scolastiche.
Nei sistemi europei più avanzati, in particolare in Finlandia, Svezia e Norvegia, l’educazione prescolare è considerata una leva decisiva di equità sociale e di sviluppo comunitario. L’investimento precoce sulla qualità dell’esperienza educativa riduce drasticamente le disuguaglianze di partenza e limita il ricorso a interventi compensativi successivi, spesso meno efficaci e più costosi. Adottare un modello analogo significherebbe spostare l’asse della politica educativa dalla riparazione del fallimento alla sua prevenzione strutturale, rafforzando al contempo la presenza dello Stato nei territori più fragili.
Un ciclo unico di istruzione di base fino ai 16 anni
Il cuore della proposta è l’istituzione di un ciclo unico di istruzione di base dai 7 ai 16 anni, ottenuto attraverso l’estensione della scuola primaria, il superamento della scuola media come segmento autonomo e l’inclusione del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado all’interno del ciclo di base. Questa scelta risponde a una solida evidenza pedagogica: la continuità educativa favorisce apprendimenti più profondi, riduce la dispersione implicita e consente una valutazione realmente formativa. L’attuale separazione tra primaria e secondaria di primo grado produce, invece, uno strappo organizzativo e relazionale che si colloca proprio nella fase più delicata dello sviluppo, quella preadolescenziale.
Nei paesi nordici l’istruzione di base è lunga, unitaria e progressiva: la distinzione tra ordini ha valore prevalentemente amministrativo, mentre sul piano didattico prevalgono la continuità degli ambienti, delle metodologie e delle relazioni educative. In Germania, pur in un sistema federale articolato, l’orientamento avviene in modo graduale e accompagnato, evitando selezioni precoci e irreversibili. Nei Paesi Bassi, la valutazione continua e la flessibilità dei percorsi consentono passaggi, riallineamenti e seconde possibilità, riducendo l’impatto sociale dell’errore educativo.
Un ciclo unico fino ai 16 anni permetterebbe ai docenti di lavorare su traiettorie di apprendimento lunghe, di monitorare in modo sistematico lo sviluppo delle competenze e di intervenire tempestivamente sulle fragilità, prima che si trasformino in insuccesso strutturale. La valutazione assumerebbe un carattere longitudinale e formativo, orientato al progresso dello studente. A sedici anni, ogni ragazzo dovrebbe uscire dal ciclo di base con una solida alfabetizzazione culturale, competenze realmente spendibili e una prima consapevolezza orientativa.
Revisione degli organici e razionalizzazione del tempo scuola
Una riforma dei cicli non è praticabile senza una revisione coraggiosa degli organici e del tempo di servizio. L’attuale differenziazione dell’orario settimanale tra docenti della scuola primaria e docenti degli altri ordini rappresenta un’anomalia nel panorama europeo e costituisce un fattore di rigidità organizzativa che ostacola la costruzione di un ciclo unico coerente.
L’uniformazione dell’orario di insegnamento delle docenti della primaria a 18 ore settimanali, in linea con quello degli altri gradi di istruzione, non risponderebbe a una logica correttiva o penalizzante, ma a un’esigenza sistemica di equità, razionalità e sostenibilità. Tale scelta consentirebbe una distribuzione più equilibrata del carico di lavoro e renderebbe possibile una diversa organizzazione del tempo scuola, con maggiore spazio per il recupero, la personalizzazione degli apprendimenti e il lavoro collegiale.
Nel ciclo unico 7–16, i docenti della secondaria verrebbero progressivamente impiegati come specialisti disciplinari, in particolare nella fascia 11–16 anni, contribuendo a un innalzamento qualitativo dell’insegnamento senza ricorrere a una moltiplicazione delle cattedre. Compresenze, moduli interdisciplinari e progettazione condivisa diventerebbero elementi strutturali, come avviene in molti sistemi europei, superando la rigida separazione tra ordini e valorizzando pienamente le competenze professionali.
La secondaria ridotta a due anni: una cerniera verso il futuro
La scuola secondaria di secondo grado, nella sua configurazione attuale, appare sempre meno efficace nel preparare realmente alle scelte post-diploma. I cinque anni di durata tendono a diluire gli apprendimenti, a frammentare l’orientamento e a rinviare la verifica delle competenze a un momento successivo all’uscita dal sistema scolastico, quando l’insuccesso assume forme più dolorose e spesso irreversibili. La proposta prevede una ridefinizione della secondaria in un biennio intensivo e propedeutico, successivo al ciclo di base.
Questo biennio costituirebbe una vera cerniera tra istruzione di base e percorsi post-secondari. In due anni si concentrerebbero obiettivi oggi dispersi: consolidamento delle competenze avanzate (comprensione dei testi complessi, scrittura argomentativa, matematica applicata, logica), sviluppo di un metodo di studio autonomo di livello universitario o professionale, verifica concreta della coerenza tra aspirazioni personali e competenze possedute. In Francia, le classi preparatorie svolgono da tempo questa funzione; in Germania e nei Paesi Bassi il raccordo tra scuola, formazione tecnica e università è strutturato e progressivo, riducendo drasticamente i fallimenti tardivi.
Preparare, non selezionare tardi
Uno dei fallimenti più evidenti del sistema italiano è la selezione differita che avviene nel primo anno universitario o attraverso i test a numero chiuso. Molti studenti arrivano a questi snodi con una vocazione chiara e un progetto di vita già delineato: il desiderio di diventare medico, ingegnere, insegnante, tecnico specializzato, professionista dell’area sanitaria o scientifica. Si tratta spesso di scelte maturate nel tempo, sostenute da motivazioni profonde e da un’immagine di sé già orientata verso un ruolo sociale preciso. Tuttavia, a fronte di questa chiarezza vocazionale, mancano frequentemente competenze decisive sul piano metodologico e cognitivo: capacità di studio autonomo, padronanza del linguaggio disciplinare, solidità logico-matematica, comprensione dei testi complessi. Il risultato è un alto tasso di insuccesso iniziale, impossibilità di accedere a determinati percorsi nonostante la vocazione, cambi di corso non sempre consapevoli e abbandoni precoci che generano frustrazione personale e spreco di capitale umano.
In questa prospettiva, i test di accesso verrebbero superati e progressivamente aboliti. La selezione non avverrebbe più attraverso prove estemporanee e standardizzate, spesso scollegate dai reali percorsi di apprendimento, ma all’interno del biennio propedeutico, mediante una valutazione continua, pubblica e trasparente. Sarebbe il percorso stesso, e non una prova episodica, a certificare il livello di preparazione e la reale idoneità dello studente all’accesso ai diversi percorsi.
Il biennio propedeutico diventerebbe così il luogo in cui la selezione si trasforma in accompagnamento formativo: uno spazio in cui lo studente può misurare concretamente la distanza tra aspirazioni e competenze, rafforzare le basi necessarie e, se necessario, riorientare il proprio progetto di vita senza vissuti di fallimento. In questo modello, l’accesso all’università, agli ITS o al mondo del lavoro qualificato non sarebbe più affidato a un test, ma all’esito documentato di un percorso di apprendimento, restituendo alla scuola la piena responsabilità dell’orientamento come costruzione reale di possibilità.
Tre sbocchi, pari dignità
Al termine del biennio, lo studente potrebbe accedere a tre sbocchi chiaramente definiti e socialmente riconosciuti: università, ITS e mondo del lavoro qualificato. La scelta non avverrebbe per esclusione o per ripiego, ma come esito coerente di un percorso di orientamento verificato nei fatti.
Gli ITS rappresentano, in questa architettura, un canale strategico ma oggi ancora incompiuto. Pur ispirandosi ai modelli duali e professionalizzanti diffusi in Europa, il sistema italiano degli ITS soffre di un limite strutturale evidente: la debolezza del coinvolgimento diretto delle grandi imprese nazionali nella progettazione dei percorsi e, soprattutto, nella costruzione di filiere reali di reclutamento. In molti casi, il legame con il mondo produttivo resta formale, episodico o affidato a singole realtà territoriali virtuose.
A differenza di quanto avviene in paesi come Germania, Austria o Svizzera, dove le grandi aziende investono stabilmente nella formazione tecnica superiore perché la considerano parte integrante della propria strategia di sviluppo, in Italia i grandi gruppi industriali e infrastrutturali partecipano solo marginalmente. Realtà come Ferrovie dello Stato, grandi aziende energetiche, logistiche o manifatturiere dispongono di un potenziale enorme per la costruzione di percorsi professionalizzanti di alto livello, ma raramente strutturano canali formativi direttamente collegati al reclutamento del personale. Ne deriva un sistema ITS che, pur producendo buone esperienze, fatica a diventare un vero asse nazionale di formazione e inserimento lavorativo.
In questo quadro, il biennio propedeutico assumerebbe anche una funzione di riequilibrio preparando studenti realmente pronti ad accedere agli ITS, rafforzandone il prestigio e la qualità, e al tempo stesso costringendo il sistema produttivo a una maggiore assunzione di responsabilità formativa. Il successo formativo, in questo modello, non coinciderebbe più con il semplice accesso all’università, ma con la coerenza tra competenze, attitudini e percorso intrapreso, riducendo lo spreco di talenti, il fallimento universitario e l’inefficacia dei canali professionalizzanti.
Riferimenti espliciti ai sistemi educativi europei
La proposta qui delineata non nasce in un vuoto teorico, ma si colloca consapevolmente all’interno di una traiettoria europea già ampiamente tracciata. Nei principali sistemi educativi dell’Unione Europea, la struttura dei cicli, l’uso del tempo scuola e il rapporto tra istruzione generale, formazione tecnica e mondo del lavoro sono stati ripensati da tempo in chiave di continuità, responsabilità e accompagnamento delle scelte di vita.
Nei paesi nordici, come Finlandia, Svezia e Norvegia, l’istruzione di base si sviluppa in un ciclo lungo e unitario, che accompagna lo studente per gran parte della crescita senza fratture istituzionali. La selezione precoce è evitata, l’orientamento è progressivo e la valutazione ha prevalentemente una funzione formativa. Questo modello ha consentito di ridurre le disuguaglianze sociali e di garantire livelli elevati di competenze di base per l’intera popolazione studentesca.
In Germania e nei paesi di area mitteleuropea, il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo produttivo è strutturale. Il sistema duale non si fonda su prove episodiche di accesso, ma su percorsi progressivi, certificati e condivisi tra istituzioni formative e imprese. La transizione verso il lavoro o verso l’istruzione superiore è accompagnata, monitorata e sostenuta, riducendo drasticamente l’abbandono e l’insuccesso tardivo.
In Francia, infine, l’esistenza di percorsi propedeutici e di classi preparatorie rende esplicita una funzione che nel sistema italiano resta implicita e spesso affidata al caso: quella di preparare realmente agli studi superiori e di verificare in modo rigoroso, ma non traumatico, la coerenza tra aspirazioni e competenze. La selezione, laddove presente, è parte integrante del percorso formativo e non un evento isolato.
L’Italia, in questo quadro, appare oggi come uno dei pochi grandi paesi europei a concentrare la selezione nei momenti di passaggio finali, scaricando sull’università e sugli studenti il peso di una scelta che avrebbe dovuto essere accompagnata prima. La riforma proposta mira a riallineare il sistema italiano a queste esperienze europee, non per imitazione, ma per convergenza verso modelli che hanno dimostrato maggiore equità, efficacia e sostenibilità.
Una riforma possibile, non utopica
Questa proposta non richiede rivoluzioni irrealistiche, ma un cambio di paradigma profondo e realistico: meno frammentazione dei percorsi, più continuità educativa; meno rigidità contrattuali e organizzative, più razionalità nell’impiego delle risorse professionali; meno selezione tardiva e opaca, più responsabilità educativa assunta all’interno del sistema pubblico di istruzione.
Ripensare cicli e organici non significa comprimere il tempo della scuola, ma redistribuirlo in modo intelligente lungo l’arco della crescita, investendo di più nei momenti decisivi e riducendo sprechi, duplicazioni e passaggi improduttivi. Significa riconoscere che il tempo educativo ha valore solo se è accompagnato da continuità, qualità della relazione didattica e chiarezza di finalità.
In questa prospettiva, la scuola italiana può tornare a essere un’istituzione capace non solo di trasmettere saperi, ma di accompagnare realmente i percorsi di vita degli studenti, sostenendone le vocazioni, prevenendo i fallimenti e rendendo possibile l’accesso equo e consapevole alle opportunità formative e professionali. È in questa visione sistemica, insieme pedagogica, sociale e civile, che la scuola può ritrovare coerenza, equità e futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA









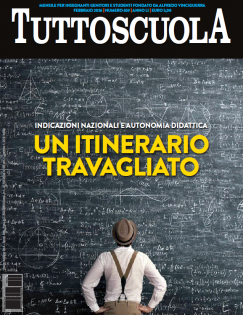




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via