
Prove Invalsi: “Trattati come polli in batteria?”
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un ricco contributo del dott. Roberto Ferrari, esperto dei sistemi di valutazione, sui test Invalsi, al centro del dibattito nelle settimane scorse.
“Scatta il boicottaggio”, “Trattati come polli in batteria”, “Alunni messi davanti al foglio a mettere crocette a tempo”, così il Manifesto di martedì 6 maggio.
“Un clima effervescente in cui alle proteste e agli scioperi dei docenti, contro il potenziale uso strumentale dei risultati, si associano le contestazioni degli studenti delle scuole-quiz”, così Italia Oggi del 6 maggio.
“No ai testi Invalsi, gli studenti di Milano occupano il Teatro Lirico”, Corriere della Sera del 13 maggio.
A fronte delle proteste che tuttavia hanno coinvolto solo gruppi sparuti di studenti ed ancor meno di docenti, cui però solitamente fanno da cassa di risonanza alcune importanti testate giornalistiche, credo sia utile interrogarci sul perché e sulle ragioni che supportano tali movimenti, anche al di là del fatto che poi in realtà il 98,50 % delle scuole primarie e il 98,21% delle scuole secondarie di secondo grado hanno sostenuto regolarmente i test Invalsi (dati ufficiali trasmessi dall’istituto Nazionale di valutazione al termine delle prove).
Ho ragione di ritenere che le proteste soprarichiamate non dipendano tanto dal fatto che anche in passato qualche item fra i tanti sia stato formulato dagli esperti in modo ambiguo o con un indice di difficoltà troppo elevato rispetto al livello delle classi deputate alla somministrazione, quanto dalla volontà politica di alcune sigle sindacali o di gruppi di studenti facenti riferimento quasi sempre all’area dell’Autonomia, di contrastare il funzionamento del Sistema Nazionale di Valutazione. Spesso e volentieri cercando di far credere, nonostante le permanenti smentite dello stesso Invalsi, che i test servono essenzialmente per valutare i docenti .
Venendo ai test somministrati dall’Invalsi è bene ricordare che nel caso delle domande ritenute troppo difficili è sempre opportuno ed auspicabile confrontare i risultati della propria classe con i risultati del gruppo campionario sul quale i singoli test vengono standardizzati (per così dire collaudati) e, successivamente, quando i risultati complessivi saranno restituiti in settembre alle singole scuole sarà sempre possibile confrontare il risultato dei propri alunni con quelli delle altre classi del proprio istituto, con quelli dell’area geografica di appartenenza, con quelli a livello nazionale. Ancor di più, vi è modo anche di confrontare i risultati delle proprie classi con quelli di classi con lo stesso bakground culturale. Non solo. Anche per le classi con numero elevato di alunni stranieri l’Invalsi restituisce i risultati in modo disaggregato rispetto agli alunni italiani in modo da permettere alle singole scuole di tenere sotto controllo i progressi o le difficoltà incontrate anche da questa tipologia di studenti, sempre più numerosi nella scuola italiana.
Solo così sarà possibile trarre le conseguenti considerazioni sulla difficoltà o meno delle singole prove.
In effetti il problema per una classe nasce allorché il risultato complessivo in italiano o in matematica si discosta in modo significativo (di almeno quattro-cinque-sei punti) dai risultati complessivi sopracitati, con particolare riferimento a quelli delle scuole nelle stesse condizioni soicioeconomiche o con alte percentuali di alunni stranieri.
E’ proprio sulla base di questi confronti che i risultati delle singole classi assumono quel significato che l’Invalsi ha sempre inteso attribuire alle proprie rilevazioni. Chiaramente non una valutazione dei docenti, come molti cercano di far credere, bensì la scelta di fornire agli insegnanti utili strumenti di riflessione sui possibili usi didattici delle prove.
Ad esempio, che cosa ci dicono le prove di italiano e di matematica appena svolte nelle classi seconde e quinte della scuola primaria? Essenzialmente esse offrono elementi fondamentali per verificare l’efficacia dei propri metodi di insegnamento da cui, per buona parte, dipendono i risultati dei propri alunni.
Da un semplice confronto tra le prove Invalsi di alcuni anni fa e le ultime, emerge, ad esempio, che la matematica non consiste più prevalentemente nell’insegnamento del calcolo o di semplici problemi quanto piuttosto essa si rappresenta come logica, probabilità, rappresentazioni, proiezioni, interpretazioni, grafici, tabelle. In breve non soltanto conoscenze ma piuttosto competenze indispensabili perché gli alunni sappiano muoversi nel mondo complesso che li circonda. In pratica non più o non solo conoscenze ma soprattutto competenze.
Identiche considerazioni valgono per le prove Invalsi di italiano, basate sulla comprensione dei testi scritti, con le quali non si tende più o prevalentemente a rilevare contenuti, ma piuttosto si richiede di saper interpretare il testo letto, di capire le intenzioni dell’autore, di manipolare il testo ma sempre più spesso di rilevare soprattutto inferenze, cioè la capacità dello studente di produrre conclusioni da determinate premesse oppure di trarre le conseguenze da uno o più enunciati.
Altro elemento significativo conseguente alla restituzione dei dati da parte dell’Invalsi è il confronto che ogni docente può fare , sempre nell’ottica dell’autovalutazione, circa la correlazione tra il voto assegnato quadrimestralmente in italiano e in matematica ed il risultato di ciascun alunno conseguito mediante questo genere di prove.
E’ per tutto ciò che ritengo valido, anche sulla base di una mia pluriennale esperienza nel campo della valutazione, l’attuale sistema dei test (attenzione: le prove Invalsi, che non sono tutta la valutazione scolastica ma soltanto una parte di essa, non sono costituite soltanto da test a risposta chiusa cui si risponde con la famigerata crocetta, ma sempre più spesso si tratta anche di domande aperte per rispondere alle quali lo studente deve essere in grado di fare un discorso più articolato) soprattutto perché evidenzia la necessità di un rinnovamento della didattica e dei metodi di insegnamento che fortunatamente molti docenti stanno mettendo in atto pur a fronte di una carenza di proposte e di obblighi di formazione che l’amministrazione scolastica da anni sembra aver completamente dimenticato.
Ferrari Roberto, ex dirigente scolastico di Luzzara (Reggio Emilia)


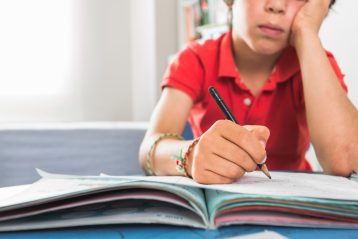




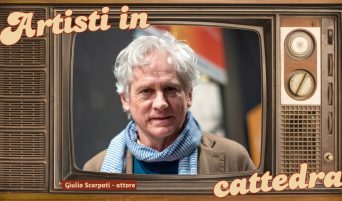





Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via