
Nuove Indicazioni Nazionali, la Storia sarà il baricentro. Oggi termina la consultazione delle scuole

“Solo l’Occidente conosce la Storia”. Questa affermazione dello storico Ernesto Galli della Loggia ha scatenato un duro confronto tra mondialisti e occidentalisti, ma sarà proprio la visione della Storia a esprimere l’asse culturale complessivo delle nuove Indicazioni Nazionali.
Comunque lo si voglia giudicare (le polemiche sono partite già prima che se ne conoscesse il testo), penso che il documento prodotto dalla Commissione presieduta dalla pedagogista Loredana Perla – incaricata dal ministro Valditara di predisporre una nuova versione delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo”, la cui prima edizione risale al 2012 (ministro Francesco Profumo) – è un testo base, peraltro assai strutturato (153 pagine con allegati), che va comunque ben al di là di quanto le scarse informazioni filtrate sui lavori della Commissione avevano fatto supporre. Sul testo, pubblicato sul sito del MIM l’11 marzo 2025, si è un aperto un dibattito pubblico e alle scuole interessate (quelle del primo ciclo) è stato intanto inviato un questionario, al quale le scuole devono rispondere entro oggi, 17 aprile 2025 (ma con la possibilità di inviare testi più ampi a una apposita casella di e-mail inserita dal MIM nel suo sito).
Tempi necessariamente serrati per poter applicare le nuove Indicazioni dall’anno scolastico 2026-2027, come annunciato dal ministro Valditara. Tempi che tradiscono la volontà di assicurarsi un risultato “politico” in tempi ravvicinati. Dibattito aperto, come detto, sulle proposte relative alle varie discipline, ma è su quelle riguardanti la storia e il suo insegnamento – tema sul quale ha lavorato il team guidato da Ernesto Galli della Loggia – che si è acceso il confronto, anche perché è dalle scelte che saranno fatte in materia di storia che va individuato, ad avviso di chi scrive, l’architrave culturale delle nuove Indicazioni. Ne abbiamo parlato anche in un webinar realizzato insieme alla Fondazione Agnelli e che è possibile rivedere di seguito:
Il nodo della Storia
All’origine della disputa sulla storia sta questa affermazione, contenuta nell’introduzione alle proposte del gruppo di lavoro, ispirata al pensiero dello storico Marc Bloch: “Solo l’Occidente conosce la Storia”. Infatti, si spiega a pagina 68, “Altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo; allo stesso modo, per un certo periodo della loro vicenda secolare anche altre civiltà, altre culture, hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica. Ma quell’inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo; quindi non segnando in alcun modo la propria cultura così come invece la dimensione della Storia ha segnato la nostra”: quella dei Paesi occidentali, a partire da quelli europei, e naturalmente anche quella dell’Italia. Ma come studiarla? Anche qui si nota una non troppo velata polemica con gli esperti che hanno ispirato le Indicazioni del 2012 e 2018: “Anziché mirare all’obiettivo, del tutto irrealistico, di formare ragazzi (o perfino bambini!) capaci di leggere e interpretare le fonti, per poi valutarle criticamente magari alla luce delle diverse interpretazioni storiografiche, è consigliabile percorrere una via diversa”, si legge a pagina 70.
“E cioè un insegnamento/apprendimento della storia che metta al centro la sua dimensione narrativa in quanto racconto delle vicende umane nel tempo. Non è pertanto necessario che i discenti imparino tutto ciò che di più o meno notevole è avvenuto in ciascuna epoca, bensì che apprendano quanto è stato davvero determinante, in primo luogo nella vicenda storica italiana”. I ripetuti riferimenti dello studio della storia (come anche, per altri versi, dell’italiano) alle radici storico-culturali dell’Occidente e alla formazione delle sue nazioni, tra le quali quella italiana, riflettono con evidenza la linea di pensiero sviluppata nel tempo da Galli della Loggia, e difesa con forza in un suo intervento pubblicato sul Corriere della Sera lo scorso 17 gennaio 2025, in risposta alle prime avvisaglie di critiche alla sua impostazione da parte degli storici che avevano redatto le Indicazioni del 2012-2018.
Ecco che cosa aveva scritto: “Sapere di storia non significa sapere quattro nozioni appiccicate alla bell’e meglio. Significa riuscire a connettere fatti e personaggi di un Paese o di una civiltà, a padroneggiarne un minimo il contesto geografico economico religioso, a saperne lo sviluppo nel tempo. E allora si faccia avanti chi pensa davvero che dei bambini di 8, 9 anni, o anche dei ragazzi di 15, 16 possano spaziare con un minimo di agio dalla Cina al Giappone, dall’America Atzeca e Inca ai regni africani, dall’India del Mogul all’Orda d’oro e all’impero mongolo. Non si può sapere tutto, ahimè, e chi pretende il contrario, chi pretende che a scuola si possano insegnare due millenni di storia mondiale è semplicemente un imbroglione. Ma se dunque è inevitabile scegliere, si può decentemente dubitare, mi chiedo, che la scelta non debba cadere sull’Italia, sulla sua storia, e insieme sul più vasto contesto geo-storico-culturale con cui essa è venuta in contatto, alle cui vicende le sue si sono alimentate e che queste hanno alimentato, cioè sulla storia dell’Occidente?”.
Questo è solo un estratto dell’articolo presente all’interno del numero 651 di Tuttoscuola.
Per leggere l’articolo sfoglia la rivista cliccando qui.
Non sei ancora abbonato? Clicca qui e scopri come abbonarti (a partire da 2,50 euro al mese)
Chi è l’autore?
Orazio Niceforo
Esperto di politica scolastica, autore di testi sulla storia della scuola italiana, dirigente dell’ufficio scuola del PSI dal 1978 al 1993, membro dell’assemblea nazionale del PSI, candidato al Senato nelle elezioni del 1992, presidente del Consiglio nazionale della FNISM. Ha fatto parte del Consiglio direttivo del CNITE (Comitato Nazionale Italiano Tecnologie Educative) e della Commissione italiana dell’Unesco (1989-1992). Membro del Consiglio direttivo del CEDE (Centro Europeo dell’Educazione) dal 1991 al 1999, responsabile del settore ‘Innovazione’. Vicepresidente della SICESE (Sezione Italiana della Comparative Education Society in Europe), direttore responsabile della rivista trimestrale ‘Scuola democratica’ dal 1982 al 2001, componente del Comitato scientifico della nuova serie della stessa rivista dal 2010. Redattore di Tuttoscuola. Docente di ‘Sistemi scolastici contemporanei’ nell’Università di Roma Tor Vergata, componente del Collegio del Dottorato internazionale di ricerca in Scienze dell’Educazione dell’Università di Roma Tor Vergata.
Di più all’interno del numero di Tuttoscuola di aprile
Nel numero di aprile un focus dedicato alle nuove Indicazioni Nazionali e un approfondimento sull’Istruzione Tecnica Superiore. La Scuola che Sogniamo di questo numero è curata da Fondazione Carolina che punta i fari sul bullismo e sul cyberbullismo. Nel Cantiere della Didattica, Cristiano Corsini scrive di scelte valutative e qualità delle scuole, Gregorio Iannaccone della valutazione dei dirigenti e Roberto Franchini del curricolo intelligente. Franco Lorenzoni ci parla invece di scrittura creativa e lettura collettiva. Presenti come sempre approfondimenti dedicati a DS, DSGA e genitori. Da non perdere!
© RIPRODUZIONE RISERVATA

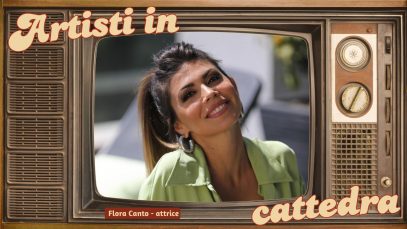











Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via