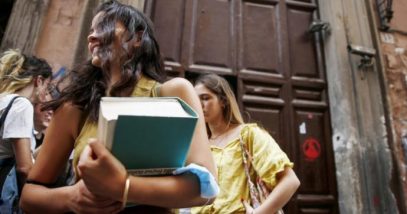
Maturità, la riflessione di un nostro lettore

Pubblichiamo una riflessione di un nostro lettore, Gianmarco Proietti, in seguito ai fatti che vedono protagonisti tanti studenti rifiutarsi di sostenere il colloquio orale dell’esame di Stato e alle considerazioni della dirigente scolastica Laura Biancato che abbiamo pubblicato qui su Tuttoscuola.
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. È lo splendido incipit dell’art. 33 della Costituzione.
Gustavo Zagrebelsky nel saggio del 2014 Fondata sulla cultura. Arte, scienza e costituzione commenta l’articolo come sostanziale nella Carta Fondamentale: il diritto alla cultura appare concepito come un fondamento dello Stato, soprattutto se letto insieme con l’articolo 9 che tutela l’arte, il paesaggio e la libertà di ricerca, con l’articolo 21 che garantisce la libertà di espressione e soprattutto con l’articolo 2 che parla di pieno sviluppo della persona umana.
All’incipit così libero e liberante, seguono una serie di commi riguardanti esclusivamente proprio la scuola, il rapporto tra scuole statali e non statali e infine l’istituzione di un esame di stato al termine di ogni ciclo di studi.
Nel leggere l’interessante dibattito tra i padri e le madri costituenti[1], spicca, proprio come ultimo commento prima della votazione degli emendamenti proposti da Giuseppe Dossetti, una illuminante dichiarazione di Luigi Einaudi. Il deputato, che diverrà il secondo Presidente della Repubblica Italiana, vide nell’istituzione di un esame di stato al termine dei cicli di istruzione un limite a quella libertà così elegantemente e assertivamente sancita nell’incipit dell’art. 33.
Una libertà limitata proprio dall’esame finale, che, a detta del costituente liberale, condizionerebbe i programmi di studio e gli insegnamenti che così non sarebbero più completamente liberi. I Costituenti risposero argomentando che spetterà al legislatore e ai ministri costruire un esame di Stato che valorizzi il percorso di studi senza condizionarlo, quindi garantendo quella libertà sancita dallo stesso articolo 33 (si leggano le dichiarazioni di Dossetti, Codignola, Gronchi).
Ad oggi, dunque, al termine di ogni ciclo di istruzione e per l’accesso agli ordini professionali, è necessario affrontare un esame di stato che nessun governo o parlamento può eliminare se non modificando la Costituzione. Per essere coerenti con lo spirito della Costituzione, il Parlamento e il Governo dovrebbero cercare di costruire esami finali dei cicli scolastici e dell’ammissione agli albi professionali che valorizzino i liberi percorsi seguiti.
Eppure, dal 1946 ad oggi, gli esami di stato a conclusione sia del primo sia del secondo ciclo di istruzione confermano radicalmente i timori di Luigi Einaudi, condizionando in modo evidente tutti gli anni di insegnamento della scuola secondaria.
Per la scuola secondaria di primo grado, l’esame è paradossalmente la ripetizione delle prove scritte di Italiano, Matematica e Scienze e Lingue Straniere già svolte per tutto l’anno, e di un colloquio orale pluridisciplinare a partire da un argomento scelto. Non è dato sapere come possa un Consiglio di Classe, dopo lo svolgimento di prove identiche a quelle già svolte dagli studenti e dalle studentesse, giustificare una valutazione differente da quella che lo stesso Consiglio di Classe aveva espresso alcuni giorni prima dopo un’osservazione lunga tre anni. Un paradosso tutto italiano, poiché nelle altre nazioni europee non ci sono esami di Stato corrispondenti a quello del termine del primo ciclo di istruzione. In ogni modo, proprio perché che le prove scritte sono identiche a quelle già svolte durante l’anno, appare evidente che l’esame condizioni essenzialmente in forma e contenuto il percorso di studi della scuola secondaria di primo grado.
Per la scuola secondaria di secondo grado, l’esame finale si differenzia da scuola a scuola per la seconda prova scritta. Come per l’esame di terza media anche le prove scritte della maturità (chiamato così anche nel dibattito in assemblea Costituente) sono la ripetizione delle prove svolte scritte nei cinque anni di scuola secondaria che diventano, inevitabilmente, cinque anni di preparazione all’esame. Le prove siano cambiate dopo la pubblicazione delle indicazioni nazionali del 2010 proprio perché è cambiato, o sarebbe dovuto cambiare, l’insegnamento nella scuola. Il Colloquio purtroppo rivela spesso la difficoltà dei docenti e delle docenti a saper valorizzare le competenze di uno studente o di una studentessa tramite l’implementazione di un discorso a partire da uno stimolo, difficoltà che si manifesta nella trasformazione di una solita interrogazione in cui si verificano conoscenze su almeno otto discipline dai programmi vastissimi.
In Europa, tutti i paesi prevedono un Esame di Stato a conclusione del percorso di studi e il sistema non è così differente da quello italiano in ogni paese Europeo è previsto un Esame al termine del percorso scolastico. Eppure in diversi paesi europei l’Esame di Stato non è collegato direttamente alla scuola secondaria, nel senso che mentre la scuola fornisce in uscita la certificazione del percorso seguito con la relativa valutazione, l’esame di stato che dà accesso all’Università o alle Professioni, può essere affrontato più volte in caso di non superamento senza ripetere l’ultimo anno di scuola.
Certamente una standardizzazione delle competenze dei cittadini e una seria valutazione delle stesse è un elemento caratterizzante la democrazia. Questa era l’argomentazione più credibile nel dibattito nell’assemblea costituente da parte dei proponenti l’art. 33.
Anche lo schema di regolamento delle Indicazioni Nazionali del 2010, prevedeva, all’art. 5, che il raggiungimento da parte degli studenti e delle studentesse degli obiettivi specifici di apprendimento fosse oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Attraverso le Indicazioni nazionali ogni istituzione scolastica aveva una cornice di riferimento entro la quale definire il proprio curricolo d’istituto, superando la logica dei programmi prescritti dall’alto: esse rappresentavano proprio un passo importantissimo verso la liberazione della scuola seguendo lo spirito della Costituzione.
Contrariamente, la recente modifica delle indicazioni nazionali del primo ciclo e il percorso attuato per la modifica di quelle del secondo ciclo, per quel poco che se ne possa sapere, indicano una decisa minore libertà da parte dei docenti e un ritorno ai programmi sempre più condizionanti: una limitazione ancor più evidente all’azione dell’incipit dell’art 33 della Costituzione
L’acquisizione di una competenza è un processo dinamico, sempre in evoluzione, va aggiornata e approfondita, rinnovata ed esercitata all’interno delle comunità in cui il soggetto vive ed opera. La competenza, infatti, è la manifestazione della mobilitazione di risorse interne (“conoscenze, abilità e disposizioni stabili”) e di risorse esterne (“persone, strumenti, materiali”) e, proprio per queste sue caratteristiche, non osservabile direttamente.
Dunque per poter accertare il possesso di una competenza è importante poter contare sull’osservazione di una molteplicità di prestazioni, sulla base delle quali si possa affermare che una competenza faccia parte stabilmente del patrimonio della persona.
Oggi per un educatore attento è evidente che i processi di apprendimento sono dunque inseparabili dai contesti fisici, sociali e culturali nei quali hanno luogo e perciò sono sostenuti dai processi di interpretazione, condivisione, trasformazione e costruzione della conoscenza attivati da una comunità di apprendimento. Dunque il successo scolastico e professionale di ognuno si deve ad una comunità perché la stessa comunità possa goderne: l’esatto contrario della interpretazione, così diffusa oggi, del merito scolastico, secondo la quale invece tutto dipende dal singolo.
Oggi è proprio la struttura dell’esame di stato e la sua invasività nella valutazione finale (50% nella scuola secondaria di primo grado e il 60% in quella di secondo grado) che condiziona gli insegnamenti e ne limita fortemente la libertà. Il condizionamento è così evidente che risulta difficile comprendere se durante l’anno si organizzino prove per simulare l’esame di stato o se siano le prove scelte per l’esame di stato a definire gli insegnamenti.
Sicuramente è necessaria un’indagine profonda per capire se la scuola possa realmente garantire agli studenti l’acquisizione consapevole delle competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del tempo presente, per proiettarsi al meglio nel futuro, per diventare cittadini attivi e responsabili, capaci di condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l’altro da sé.
Tale indagine, però, non può ricadere esclusivamente sugli studenti e sulle studentesse, ma deve coinvolgere i docenti e tutto il sistema di istruzione e formazione, in ogni livello. Prima di tutto perché non è con una prova standardizzata come pure con due prove scritte e un colloquio che si può costruire una valutazione oggettiva della competenza e inoltre perché non dovrebbero essere gli studenti e le studentesse a pagare eventuali inadempienze del sistema di istruzione e formazione sia nazionale che locale.
Per gli eletti e le elette nell’Assemblea Costituente sarebbe stato possibile costruire un esame che non limitasse la libertà di insegnamento e non condizionasse con programmi strutturati la cultura del paese.
Con la modifica strutturale e imposta senza alcun percorso partecipativo delle Indicazioni Nazionali, si è danneggiato in modo irrimediabile uno strumento liberante la didattica da condizionamenti e vincoli, che, per mancanza di formazione adeguata, il corpo docente non sapeva riconoscere, forse preferendo il rigido e imprigionante schema dei programmi.
In questo modo, però, si è data, forse inconsapevolmente, ancora più incisività ad un esame di stato che, pur non valutando competenze e ripetendo prove già svolte e già valutate, condiziona in modo decisamente invasivo il percorso di studi.
Avrebbe senso, oggi, una prova conclusiva del percorso di studi personalizzata: gli studenti e le studentesse potrebbero essere chiamati a presentare una propria tesi, progettata e argomentata con rigore scientifico. Tale prova darebbe quindi alcuni punti in più da aggiungersi a quelli che una comunità educante (i vari Consigli di Classe) ha assegnato con professionalità dopo un’osservazione di almeno cinque anni, come avviene con la tesi di laurea.
L’elaborazione di una tesi, con tutte le opportunità del digitale e dunque del multimedia, darebbe la possibilità di organizzare una qualificata sintesi di quanto studiato, dunque rappresenterebbe un cambio radicale di prospettiva: è il percorso di studi seguito che condizionerebbe l’esame e non, come avviene ora, il contrario.
Gli studenti e le studentesse sarebbero chiamati ad un lavoro di ricerca delle fonti, alla redazione di una bibliografia, all’argomentazione di una propria idea. Proprio Zagrebelsky, nel saggio citato all’inizio, continuando a commentare l’art. 33, sostiene che senza idee non ci sia cultura e di conseguenza senza cultura non vi sia società (e senza libertà di cultura non vi sia libertà della società). La scuola potrebbe così rispondere alla sua vocazione critica di costruzione del sapere lasciando il porto sicuro della ripetizione del già visto e del già scritto.
Oggi più che mai è necessario offrire agli studenti e alle studentesse la possibilità di correre il rischio di uscire dal conformismo per azzardare pensieri propri.
Così la scuola sarà davvero libera di affrontare percorsi culturali con creatività, dimensione alla base dell’amore per il sapere.
[1] https://www.nascitacostituzione.it/02p1/02t2/033/index.htm?art033-028.htm&2
© RIPRODUZIONE RISERVATA












Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via