
Diritto allo studio: in Italia è difficile accertare ‘merito’ e ‘bisogno’

Di Enzo Martinelli*
Quando a Milano presero avvio le lezioni al Politecnico (1863), la prima Università meneghina, il Comune di Bologna si preparava a celebrare gli otto secoli di vita dell’Alma Mater Studiorum e a Padova, Napoli, Siena e Pavia si discuteva l’ordine di graduatoria per definire l’anzianità dei rispettivi atenei, istituiti nei primi decenni del 1200.
Oggi all’ombra della Madonnina ferve un’operosa attività di una dozzina di Accademie che dopo aver recuperato nel secolo scorso il tempo perduto sulla frontiera dell’Istruzione Superiore, accolgono circa 250.000 studenti, una delle nuove risorse vitali della città. Già Capitale della finanza, dell’editoria, della pubblicità, della moda, del “pallone” (qualcuno dice anche della televisione), Milano insidia il primato di Roma (che ha il doppio di abitanti) per numero di studenti iscritti agli atenei pubblici e privati, alle Accademie di Alta qualificazione Artistica, Musicale, Design e agli Istituti Tecnici Superiori. Alcune di queste Istituzioni, benché giovani di età, hanno conquistato grande fama e prestigio a livello internazionale con riconoscimenti ufficiali da parte delle Agenzie mondiali all’uopo funzionanti e sono capaci di attrarre studenti da tutti i Continenti. Sono circa 30.000 gli studenti stranieri che frequentano i Corsi di laurea e di specializzazione degli atenei meneghini che offrono un’offerta formativa estesa e qualificata e dunque apprezzata, attrattiva, spesso costosa. Circa il 30 per cento degli studenti arriva a Milano dalle altre Regioni italiane.
Insomma la formazione del capitale umano è diventata un’attività fondamentale per lo sviluppo della Città metropolitana, ieri sede delle grandi fabbriche dismesse dell’Alfa Romeo, della Marelli, della Falk ecc. e oggi luogo di ricerca, di innovazione e perfino di turismo. L’edilizia universitaria, necessaria per dotare i nuovi atenei di adeguati e moderni spazi, ha consentito di riqualificare le periferie cittadine che, col nuovo e moderno assetto urbanistico, offrono ora adeguato decoro e buona vivibilità ai residenti. Gli strumenti locali di comunicazione, a cominciare dal Corrierone, accompagnano i tanti successi delle Università e gioiscono che a Milano, accanto al “Quadrilatero della Moda”, si sia ormai consolidato “l’Ottagono dei Campus”. Insomma per gli studenti nazionali Milano è… un traguardo. Ma come arrivarci? Col diritto allo studio universitario?
Siccome tutte le medaglie hanno il rovescio, accanto al quadro strutturalmente sano e positivo emergono problematiche che meritano analisi, riflessioni e sollecitano verifiche in rapporto alla gestione politica del diritto allo studio universitario da parte del Governo centrale e delle Regioni.
Il calo demografico, la moltiplicazione di atenei in tutto il territorio nazionale, lo sviluppo degli atenei telematici hanno avuto riflessi anche nella consolidata realtà universitaria di Milano che negli ultimi 10 anni ha perso un dieci per cento di iscritti. Il modesto ridimensionamento degli iscritti che studiano all’ombra della Madonnina è essenzialmente dovuto, oltre alle generalizzate cause sopra citate, alla reperibilità e al costo del “posto letto” da parte degli universitari che hanno organizzato proteste con le tende davanti a Palazzo Marino. Il sindacato degli universitari italiani ha infatti segnalato che a fronte di un costo medio mensile nazionale di 240 euro per un posto letto, a Milano chi affitta spazi agli studenti pretende più del doppio. Rispetto a una domanda giovanile di circa 75.000 posti letto il contesto meneghino ne offre poco più di 6.000 pubblici e altrettanti privati (ambiti e costosi). Viene dunque giustamente tirato in ballo il grande divario tra le attese e la realtà dei servizi gestiti da tutte le Regioni relativi al diritto allo studio universitario.
Al riguardo vanno precisate alcune note di contesto. Le immatricolazioni a livello nazionale nell’ultimo triennio sono stabili. In tutto il territorio nazionale gli atenei tradizionali perdono una quota di studenti a favore delle Università telematiche che sono in espansione. Comunque la formazione a distanza è e rimarrà nel tempo molto bassa rispetto a quella in presenza fornita dagli storici atenei. Ogni Regione si è data una propria organizzazione e diversificati regolamenti per la gestione delle attività assistenziali agli studenti “meritevoli e bisognosi” come prescritto dal testo costituzionale. Per risultare efficaci gli interventi pubblici necessitano di alcuni requisiti. Il primo, essenziale, attiene un’adeguata disponibilità di risorse finanziarie. L’Italia destina alle Università l’1,5% della spesa pubblica (l’1% del PIL). La Germania il 2,7, la Francia il 2,1, la Spagna il 2,1. La percentuale UE è attestata al 2,3 e quella OCSE al 2,7. Secondo una recente indagine l’Italia spende per ogni studente full time 12.663 dollari, rispetto ai 14.361 della Spagna, ai 18.880 della Francia e ai 20.760 della Germania. E’ evidente che se i soldi sono pochi i posti letto negli studentati, le mense universitarie e le borse di studio rimarranno del tutto insufficienti. Per rendere tuttavia efficaci i pur limitati interventi pubblici di sostegno è necessario individuare con buona certezza i soggetti “bisognosi e meritevoli” ai quali concedere i benefici. Purtroppo su questa trincea l’Italia fa acqua da tutte le parti.
Nella Penisola il lavoro nero è valutato in 170 miliardi annui, l’evasione fiscale è stimata intorno a 100 miliardi per ogni esercizio finanziario, l’85% dell’IRPEF è pagata da lavoratori dipendenti e pensionati (alla copertura del restante 15% provvedono 4 milioni di lavoratori autonomi, 450.000 società di persone e 400.000 società di capitale), l’1 per cento della popolazione detiene un quarto della ricchezza nazionale. In siffatta situazione e nonostante che l’Istat indichi 5.750.000 soggetti in stato di povertà, stabilire chi ha titolo al posto letto universitario diventa impresa ardua. Quanto al “merito” è utile riassumere le considerazioni del prof. Roger Abravanel (Corriere della Sera del 22 marzo u.s.). “Hanno allergia alla valutazione gli insegnanti che spesso suggeriscono le risposte agli alunni nelle prove INVALSI”. “Gli istituti scolastici non vogliono essere valutati”. “Le famiglie si oppongono alla valutazione individuale e al numero chiuso nelle università”. Esistono “mostruose differenze tra Licei e Istituti tecnici e professionali, tra Nord e Sud eppure i 100 e lode nel Mezzogiorno sono il doppio che al Settentrione”.
“La maturità da decenni non è né seria, né obiettiva”. Un quadro così negativo e privo di adeguati e seri strumenti di valutazione rende difficile, se non impossibile a chiunque individuare lo studente “bisognoso e meritevole” al quale accordare “il diritto” di dormire in uno studentato o di ricevere un contributo per pagare ai privati l’affitto di una stanza ed i pasti giornalieri sia a Milano che altrove. Finché i pubblici uffici preposti (finanziari e scolastici) funzionano per quotidiana inerzia e con esiti del tutto deludenti, gli obiettivi e i propositi contenuti negli artt. 33 e 34 della Costituzione possono attendere per essere realizzati. Intanto, ormai da decenni, molti giovani più o meno quadrupedi di famiglie benestanti continuano a soffiare il posto letto e la borsa di studio a bravi ragazzi di gente veramente bisognosa con buona pace per coloro che auspicano la ripresa dell’ascensore sociale. La strada da percorre per ottenere in futuro qualche efficace risultato e conseguire un diritto allo studio meno “distorto o affievolito”, è irta di ostacoli e tutta in salita. Governare è un’arte difficile, ma se si vuol perseguire il bene comune occorre cimentarsi con le vere cause che generano ingiustizie come quelle sommariamente sopra accennate.
*già Direttore Generale Miur
© RIPRODUZIONE RISERVATA


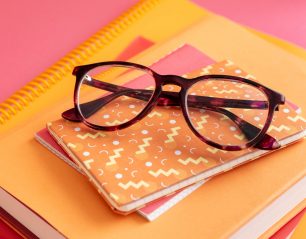





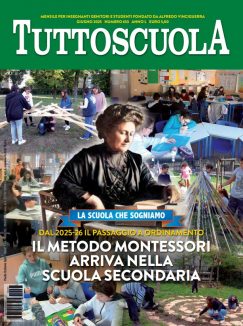




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via