
Leggere la Dichiarazione dei Diritti Umani come un sistema di assiomi
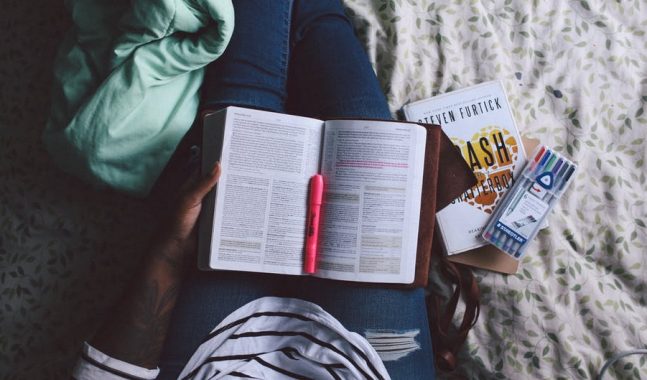
di Emilio Ambrisi
Una proposta per la scuola di oggi ispirata a Ennio De Giorgi e agli assiomi della ragione e della sapienza, come linguaggio civile. In un tempo in cui la scuola è sommersa da mille iniziative ma raramente chiamata a riflettere sulle sue fondamenta, vale la pena tornare a un’idea semplice e luminosa: leggere e commentare in classe la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948.
L’invito veniva da Ennio De Giorgi, uno dei grandi matematici del Novecento, scienziato di fama mondiale e pensatore di profonda umanità.
De Giorgi vedeva nella Dichiarazione non solo un testo giuridico, ma un modello di pensiero: un insieme di principi primi, simili agli assiomi della geometria, da cui può derivare un intero edificio di giustizia, libertà e pace.
Il testo, composto da trenta articoli, è pubblicato sul sito del Senato della Repubblica in conformità alla raccomandazione delle Nazioni Unite.
È uno dei documenti più alti del Novecento e, per la sua chiarezza e universalità, può diventare oggi — nelle scuole — un riferimento morale e civile di cui la nostra società avverte ancora profonda necessità.
Per comprendere meglio il senso di questa proposta, può essere utile ricordare che cosa sia un assioma in matematica: una verità che non si dimostra, ma da cui si dimostra tutto il resto.
Gli studenti ne fanno esperienza sin dalla scuola primaria, quando apprendono che “per due punti distinti passa una e una sola retta” — uno dei cinque assiomi con i quali Euclide, più di ventitré secoli fa, costruì il sistema assiomatico che ci è più familiare: la geometria!
Questo modo di costruire il pensiero — partire da principi evidenti e dedurne coerentemente le conseguenze — non appartiene solo alla matematica.
Ennio De Giorgi invitava a riconoscerne la presenza anche nei grandi testi morali della storia umana.
I Dieci Comandamenti, ad esempio, rappresentano un sistema assiomatico religioso: dieci principi semplici e categorici, da cui discende una visione completa della vita e della condotta.
Al centro vi è un precetto che egli considerava fondamento universale: “Ama il prossimo tuo come te stesso.”
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, a suo giudizio, traduce questo principio in linguaggio laico e universale.
È, potremmo dire, un sistema assiomatico civile, fondato su tre grandi verità evidenti — la dignità, la libertà e l’uguaglianza — da cui scaturiscono, con coerenza logica e forza etica, tutti i diritti e i doveri dell’uomo.
“La Dichiarazione va letta come un testo di fondazione, come un insieme di assiomi da cui discende tutto ciò che di umano e di giusto possiamo pensare.” (E. De Giorgi)
Leggere la Dichiarazione in questa chiave significa educare al pensiero strutturato, al rispetto della logica e delle connessioni: capire che anche la vita morale e politica si regge su una forma di coerenza, come un sistema scientifico.
Un esercizio di educazione civile e scientifica
Per De Giorgi, leggere la Dichiarazione nelle scuole non è un gesto retorico, ma un atto educativo.
È un modo per formare il pensiero alla coerenza e la coscienza al senso del limite e della verità.
Come la geometria insegna a dedurre con ordine, così la Dichiarazione insegna a pensare e a vivere con coerenza, unendo rigore intellettuale e responsabilità morale.
“Serve molto di più l’attenzione di chi la legge con spirito critico, medita sul suo contenuto, ne discute serenamente con altre persone.” (E. De Giorgi)
Leggere la Dichiarazione come un insieme di assiomi significa educare alla logica della convivenza: comprendere che la libertà non è arbitrio, ma conseguenza necessaria di principi condivisi.
Significa ancora, riconoscere che la scienza e l’etica condividono la stessa radice: la fiducia nella ragione umana e nella possibilità di costruire insieme un linguaggio comune.
In un tempo in cui le parole “valore”, “giustizia”, “verità” e “diritti” rischiano di diventare suoni vuoti, questa proposta assume un valore che sta al di sopra di tutte le altre: è un invito all’educazione morale, alla responsabilità, alla formazione di una coscienza etica.
È, in fondo, la finalità più alta — e insieme più semplice — che la scuola possa darsi.
L’articolo 26 della Dichiarazione, dedicato all’educazione, esprime perfettamente questo legame:
“L’educazione deve mirare al pieno sviluppo della persona umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.”
Per De Giorgi, questo articolo è il punto d’incontro fra ragione e amore, fra pensiero e compassione.
“Chi è meglio disposto alla tolleranza e all’amicizia cerca di superare le incomprensioni che rendono difficile il dialogo tra i diversi gruppi umani.” (E. De Giorgi)
Un testo scritto da buoni servi della Sapienza
“Mi sembra un testo scritto da buoni servi della Sapienza” — scriveva De Giorgi, riconoscendo nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani la stessa ispirazione che anima la vera conoscenza: quella che unisce rigore e umiltà, logica e compassione.
La matematica e la sapienza, nella visione di De Giorgi, sono due volti della stessa ricerca.
Entrambe cercano ordine e verità, non come dominio sull’altro, ma come servizio alla chiarezza, alla convivenza e al bene comune.
La prima costruisce relazioni vere tra idee e grandezze; la seconda costruisce relazioni giuste tra persone e culture.
In entrambe, l’atto iniziale è lo stesso: riconoscere alcuni principi e dedurne con coerenza tutte le conseguenze.
La scuola è il luogo naturale di questo incontro.
Ogni insegnante che aiuta i suoi studenti a capire un teorema o a riflettere su un diritto compie, in fondo, lo stesso gesto: educa alla coerenza, cioè alla verità.
“La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, come il Libro dei Proverbi, può essere letta e discussa nelle classi come un testo di fondazione, come un insieme di assiomi per la vita civile.”
(E. De Giorgi)
Tra le tante proposte che attraversano la scuola, poche possiedono la semplicità e la grandezza di questa.
Leggere la Dichiarazione significa restituire alla scuola la sua vocazione più autentica: formare la coscienza, coltivare il pensiero, insegnare la responsabilità.
È un atto di memoria e di futuro insieme: perché educare è continuare a credere che l’uomo possa comprendere, costruire e convivere.
L’invito di De Giorgi — oggi più urgente che mai — è che docenti e studenti diventino “servi della Sapienza”: persone che cercano la verità con umiltà e rigore, capaci di trasmettere coerenza e rispetto, di coniugare il pensiero scientifico con la responsabilità morale.
E come si legge nelle parole conclusive della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948:
“L’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, affinché ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.”
Così il pensiero di De Giorgi e il voto delle Nazioni Unite si incontrano in un unico ideale educativo: fare dell’insegnamento il luogo in cui l’uomo impara a pensare, a comprendere e a rispettare — con la stessa coerenza della scienza e la stessa luce della sapienza.
*Già Ispettore Tecnico del Ministero dell’Istruzione
© RIPRODUZIONE RISERVATA













Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via