
Platone IA e la nuova coscienza del pensiero digitale
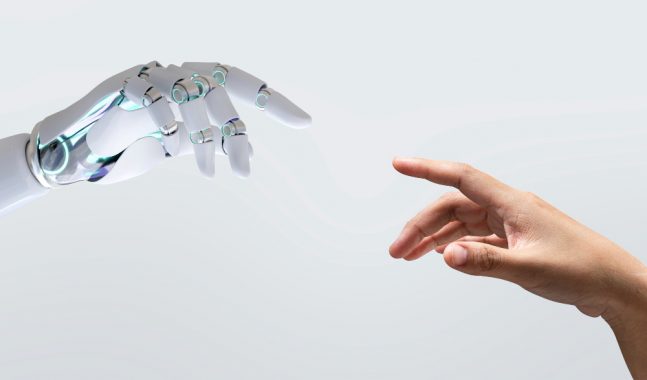
Di Tiziana Rossi
A Riva del Garda, nel cuore di Didacta Trentino (22-24 ottobre 2025), l’Indire ha presentato ‘Platone IA’, un motore di intelligenza artificiale progettato per accompagnare la formazione dei docenti e promuovere pratiche di apprendimento personalizzate. Non un semplice software didattico, ma un ambiente che tenta di integrare la logica della macchina con la complessità del pensiero umano.
Pochi giorni prima, il 4 ottobre sempre a Trento, un altro evento – ‘IA Coscienza 2025’, promosso dal ‘Comitato Coscienza’ neonato a Trento – ha riunito neuroscienziati, fisici, filosofi e informatici per affrontare una domanda ricorrente nella letteratura e nella filmografia fantascientifica da Asimov a ‘2001: Odissea nello spazio’ e oggi cogente: un sistema di intelligenza artificiale potrà mai sviluppare una vera coscienza?
La coincidenza temporale non è casuale. Da una parte, un’istituzione pubblica sperimenta strumenti per potenziare l’apprendimento umano attraverso l’IA; dall’altra, la comunità scientifica si interroga su cosa significhi “essere coscienti” in un mondo che affida sempre più attività cognitive e ‘decisioni’ fondate su algoritmi alle macchine.
Come ha ricordato il fisico Roberto Battiston nell’evento IA Coscienza, ‘l’innovazione sta aprendo la cassaforte del nostro sapere alle macchine’. Eppure, quella cassaforte custodisce molto più di meri dati: contiene la memoria, il dubbio, il senso stesso dell’esperienza. Nel corso del convegno del 4 ottobre, Giulio Tononi ha ribadito che la coscienza non è la capacità di rispondere o calcolare, ma l’esperienza soggettiva del vivere: la qualità unitaria di ciò che sentiamo, pensiamo, ricordiamo. Il fisico Federico Faggin ha aggiunto che il significato non nasce dai simboli o dai codici, ma solo dall’esperienza cosciente. E Maria Chiara Carrozza – da una dei massimi esperti di robotica qual è – ha invitato a guardare ai rischi cognitivi per le nuove generazioni, sempre più immerse in un ecosistema tecnologico che modella percezione e apprendimento. Il senso dell’apprendimento va riguadagnato e rinegoziato nella comunità educante che è la scuola.
Queste riflessioni si intrecciano con una constatazione inquieta: se è vero che l’IA non possiede coscienza, è altrettanto vero che l’intelligenza umana sembra progressivamente “robotizzarsi”. L’abitudine alla simultaneità – immagini, audio, flussi rapidi – riduce lo spazio dell’analisi, della connessione logica, del pensiero deduttivo e induttivo. La comunicazione digitale, sempre più dominante, ci riporta a forme di oralità e auralità preomeriche: viviamo in un tempo che ascolta molto e scrive poco, che reagisce, ma raramente rielabora.
La cultura occidentale, fondata sulla linearità della scrittura – quella che ci ha insegnato a pensare “da sinistra a destra”, dal prima al poi, dalla causa all’effetto, per così dire – sta forse attraversando una mutazione epigenetica epocale. Non è solo una questione di strumenti, ma di forma mentis: il nostro cervello si adatta a nuove modalità di fruizione culturale, dove la parola perde la sua durata e il pensiero la sua sedimentazione. La mente, abituata a elaborare sequenze e conseguenze, si riconfigura per operare in un mondo di istanti. È la sincronizzazione perenne dell’attenzione.
Eppure, come ogni trasformazione culturale, anche questa non coincide con un declino in senso assoluto. Forse non stiamo assistendo all’estinzione della tradizione scritta, ma a una ibridazione del pensiero: la parola che si fa immagine, la scrittura che dialoga con la voce, la memoria che si estende nel digitale senza dissolversi. Il rischio non è tanto tecnologico quanto antropologico: che la velocità diventi la nuova misura della comprensione e che la coscienza si riduca a una macchina di elaborazione priva di profondità temporale. Non sarebbe la prima volta che l’Occidente attraversa un passaggio di soglia. Dopo il crollo dell’Impero romano, furono gli amanuensi a custodire la memoria del pensiero classico, trascrivendo testi e idee in un mondo che pareva dissolversi. In quei monasteri si salvarono non solo le parole, ma la possibilità stessa di un futuro attraverso la trasmissione ai posteri del passato.
Oggi, tra milioni di dati generati da intelligenze artificiali, occorre la stessa resistenza: una nuova fedeltà alla memoria, al tempo lungo della riflessione, alla lentezza che fonda la coscienza. In questo quadro, progetti come Platone IA acquistano un significato che va oltre la sperimentazione tecnica. Il motore sviluppato da Indire si propone come uno spazio di mediazione: un sistema che non sostituisce il docente ma lo accompagna, stimolando la riflessione, il confronto, il dialogo. La figura prescelta è uno dei ‘punti di non ritorno’ nella dinamica del pensiero occidentale: Platone è il filosofo del dialogo, colui che trasformava la conoscenza in relazione e il sapere in ricerca comune, l’allievo di Socrate che nei ‘Dialoghi’ ha dato voce alla ricerca costante e alla domanda, al dubbio condiviso socialmente come sintesi suprema dell’essenza umana. Se l’IA può diventare uno strumento per tornare a interrogarsi, allora può aiutare a preservare la coscienza stessa del pensare, nonostante – o forse grazie a – la rivoluzione digitale. Il ‘chatbot filosofico’ di Indire mira ad affrontare i temi della cittadinanza attraverso le lenti della filosofia, riscoprendo la forza delle parole e dei concetti come strumenti di libertà. Come spiegano Samuele Calzone e Matteo Borri, il progetto non sostituisce i contenuti dell’educazione civica, ma li rilegge alla luce del pensiero critico. Tre le modalità di interazione che uniscono filosofia, tecnologia e didattica. La prima, ‘Paths con Platone’, consente di dialogare con il filosofo all’interno del suo tempo storico, esplorando le radici del suo pensiero e il significato originario dei concetti platonici. È un viaggio nel mondo delle idee che mantiene l’aderenza al contesto culturale dell’Atene classica, restituendo il senso originario del dialogo socratico come ricerca comune della verità. La seconda modalità, ‘Parla con Platone’, apre uno spazio di confronto più ampio: un dialogo virtuale che si muove intorno ai testi e alle opere, permettendo di approfondire i concetti e le nozioni fondanti della filosofia platonica. Un esercizio di conversazione intellettuale, che sollecita la curiosità e l’argomentazione logica. Provare, quindi, a chiedere a Platone cosa siano la felicità, l’amore, il bene comune, se la guerra sia giusta, se esista una guerra giusta e discutere le risposte del motore con gli studenti può essere un valido innesco iniziale a un dibattito vivo e lontano dai canoni della ‘storia delle filosofia’ così come tradizionalmente concepita in Italia. E’ Platone che parla attraverso i suoi Dialoghi che alimentano il database del software, ma è un Platone vivo che oltrepassa i manuali scolastici, per loro natura sequenziali e didascalici. La terza, ‘Pensa come Platone’, è la più sperimentale e quella più vicina alle esigenze formative degli istituti tecnici e professionali. Qui l’intelligenza artificiale invita gli studenti a riflettere su temi del presente – l’ambiente, il nucleare, le nuove tecnologie – attraverso la lente del pensiero filosofico. Si tratta di un vero laboratorio di pensiero critico applicato, in cui la filosofia non è più un sapere del passato, ma un metodo per interpretare il presente.
In questo modo, Platone 3.0 non è solo un omaggio al filosofo della dialettica, ma un modo per restituire senso alla parola ‘dialogo’ nella scuola contemporanea. La sua finalità non è rispondere, ma insegnare a interrogare: la realtà, le idee, e soprattutto se stessi. Un compito che, oggi più che mai, rappresenta la radice stessa dell’educazione alla cittadinanza.
Nel momento in cui affidiamo alle macchine le nostre memorie, i nostri testi, persino le nostre decisioni, il compito dell’educazione diventa quello di coltivare la lentezza dell’intelligenza umana: quella che riflette, che ricorda, che dubita. La vera sfida della scuola oggi non è addestrare studenti come macchine coscienti, ma non perdere la coscienza nell’uso delle macchine. Forse, come suggerisce l’esperimento di Indire, il futuro della formazione passerà da un’alleanza tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, dove la prima non pensa al posto dell’altra, ma insieme ad essa. Perché la risposta alle domande eterne sul senso del vivere non risiede nei dati, ma nel dialogo: nel dubbio condiviso che, da Socrate in poi, continua a fondare la nostra idea di coscienza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA













Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via