
Adolescenza tra tentativi di medicalizzazione ed etichette: il ruolo della scuola
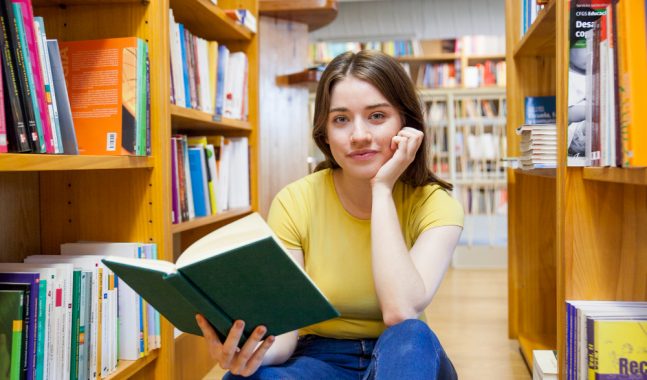
di Maria Angela Grassi* e di Paola Daniela Virgilio**
L’adolescenza non deve essere considerata un fenomeno da medicalizzare né un’etichetta diagnostica per semplificare il disagio. Si tratta di una fase intrinsecamente umana, complessa, spesso turbolenta e a volte dolorosa. Il problema risiede non nell’adolescenza in sé, ma nella carenza di strumenti collettivi che possano guidare gli individui attraverso questa trasformazione. In assenza di contesti, rituali e figure di accompagnamento, la riorganizzazione identitaria, un processo naturale, può bloccarsi, degenerando in isolamento, angoscia e, in molti casi, autolesionismo. La crisi giovanile contemporanea non è primariamente un fallimento individuale, ma riflette in larga misura la crisi delle transizioni sociali che storicamente facilitavano il passaggio all’età adulta.
La pedagogia, lungi dall’essere un mero vezzo culturale, rappresenta una pratica progettuale fondamentale. Essa si occupa di analizzare i contesti che favoriscono o ostacolano lo sviluppo, di elaborare metodologie per l’ascolto e la narrazione, e di rafforzare le connessioni tra scuola, famiglia e comunità. Per una strategia proattiva anziché reattiva, la pedagogia deve riacquisire il suo ruolo di asse strategico nell’istituzione scolastica, non come ornamento, ma come infrastruttura educativa essenziale.
Si propongono quattro linee d’azione concrete e realizzabili per dotare i giovani di strumenti efficaci per la loro crescita:
– Reintroduzione di rituali e percorsi di transizione: progettare momenti formali e informali (ad esempio, cerimonie simboliche, badge di competenza, percorsi di assunzione di responsabilità) che segnino il passaggio tra i cicli scolastici, coinvolgendo attivamente studenti, docenti e famiglie. L’attribuzione di simboli e narrazioni al processo di trasformazione personale contribuisce a mitigare l’ansia legata al vuoto identitario.
– Integrazione stabile di pedagogisti nell’organico educativo: questa figura non dovrebbe essere una consulenza sporadica, bensì un elemento strutturale della governance scolastica, con il compito di progettare laboratori relazionali, supervisionare le dinamiche di classe e formare gli insegnanti nella rilevazione dei segnali di rischio.
– Sviluppo di un curriculum della cura e della cittadinanza emotiva: l’obiettivo è insegnare il riconoscimento delle emozioni, la gestione dei conflitti e la costruzione di comunità. Le competenze acquisite dovrebbero essere valutate attraverso portfolio e progetti partecipativi, piuttosto che tramite voti che possono generare ansia.
– Riconcettualizzazione del tempo scolastico come tempo di comunità: è necessario ridurre la frammentazione degli orari e creare spazi extracurricolari obbligatori dedicati alla cooperazione, all’espressione artistica e alla responsabilità civica, intesi non come intrattenimento, ma come contesti per la costruzione di senso.
L’istituzione scolastica è troppo spesso divenuta un mero contenitore di contenuti, trascurando il suo ruolo di accompagnamento nelle transizioni vitali. Se non si restituiscono ai giovani rituali, responsabilità e narrazioni condivise, si continuerà a fronteggiare sofferenze che la terapia intercetterà sempre troppo tardi. La pedagogia non è un elemento accessorio; è il primo intervento di salute pubblica educativa.
L’idea che semplici protocolli e sportelli possano risolvere la solitudine giovanile è fuorviante; è indispensabile un’architettura educativa che prevenga l’isolamento. La formazione degli insegnanti, l’inserimento di pedagogisti, la revisione dei curricoli e la reintroduzione di rituali di crescita non sono spese superflue, ma rappresentano il mezzo concreto per offrire ai giovani la possibilità di crescere senza compromettere il proprio benessere.
Queste non sono utopie, bensì scelte amministrative e culturali precise. Si può iniziare immediatamente con azioni a basso costo e ad alto impatto: formazione obbligatoria sui processi di sviluppo, orari più coesi, budget per laboratori di comunità e riconoscimento professionale per i pedagogisti scolastici. Le grandi risorse saranno necessarie in seguito; i cambiamenti organizzativi e culturali possono essere avviati già oggi.
La scuola non può e non deve risolvere ogni problematica, né sostituirsi ai servizi sociali o alla famiglia. Tuttavia, se non si assume la responsabilità di progettare la crescita, i servizi e le famiglie saranno perennemente costretti a gestire emergenze. È una scelta di priorità: la prevenzione è più efficace e più giusta rispetto alla cura tardiva.
Continuando a trattare l’adolescenza come un problema da etichettare, si perderà l’opportunità di guidare le nuove generazioni verso una maturazione sana. Al contrario, restituendo centralità alla pedagogia e ricostruendo spazi, riti e percorsi che conferiscano significato alla transizione, si donerà ai giovani non solo salute, ma anche dignità, appartenenza e senso.
*Presidente Nazionale ANPE
**Vicepresidente Nazionale ANPE
© RIPRODUZIONE RISERVATA













Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via