
Esame di Stato: un confronto da aprire, non da chiudere

In diverse scuole del Veneto, alcuni studenti hanno fatto una scelta tanto semplice quanto spiazzante: si sono rifiutati di sostenere l’orale dell’esame di maturità.
Maddalena Bianchi, 19 anni, liceale di Belluno, ha deciso di restare in silenzio davanti alla commissione. Non per sfida o per provocazione, ma per lasciare parlare il testo che aveva preparato, con cui ha voluto raccontare il disagio profondo vissuto durante gli anni della scuola superiore.
Gianmaria Favaretto, a Padova, ha fatto più o meno lo stesso. E altri ancora.
Non si tratta di casi isolati. È una voce collettiva che, se vogliamo, comincia a farsi sentire.
Siamo abituati a giudicare il silenzio come un segnale negativo: mancanza di rispetto, immaturità, scarso impegno. Ma se, invece, fosse il contrario? Se quel silenzio fosse un messaggio? Un grido trattenuto, una forma di resistenza lucida e consapevole?
Leggere il presente senza lenti del passato
In questi giorni, tanti adulti hanno alzato la voce per condannare il gesto di chi ha scelto di non sostenere l’orale dell’esame. “Irresponsabili”, “viziati”, “poco rispettosi”. C’è chi ha parlato di mancanza di coraggio, chi di moda da social, chi ha evocato un pericoloso lassismo educativo. Sono osservazioni che, pur comprensibili sul piano emotivo, non colgono il cuore della questione.
Innanzitutto, quei ragazzi non hanno insultato nessuno, non hanno infranto le regole, non hanno preteso privilegi. Hanno solo deciso di usare, con consapevolezza, lo spazio che il sistema stesso concede loro. E lo hanno fatto per mandare un messaggio. Un messaggio che possiamo anche non condividere del tutto, ma che merita di essere ascoltato, non deriso.
Chi oggi invoca rigore e serietà appellandosi a ciò che ha vissuto trent’anni fa a scuola, probabilmente non conosce, o non vuole conoscere, la scuola di oggi. La realtà quotidiana di un istituto superiore nel 2025 è profondamente diversa da quella degli anni ’80 o ’90. Gli studenti sono cambiati. Le famiglie sono cambiate. Le problematiche sociali ed educative si sono moltiplicate. E il sistema scolastico, purtroppo, fatica ad adattarsi e a rispondere con strumenti nuovi.
Parlare di “ai miei tempi” ha poco senso se non si tiene conto delle storture non risolte, delle fragilità sistemiche, della pressione crescente che gli adolescenti subiscono. Chi oggi giudica con leggerezza quei ragazzi, dovrebbe prima visitare una scuola vera, viverla, ascoltare le storie degli studenti. Solo allora potrà capire che quel gesto non nasce da pigrizia o leggerezza, ma da un bisogno profondo di riconoscimento, di giustizia, di senso.
E poi, diciamolo con onestà: se uno studente rinuncia a un voto più alto per lanciare un messaggio di dissenso, non sta scegliendo la via più facile. Sta rischiando in prima persona. E questa, più che mancanza di responsabilità, è una forma rara e preziosa di consapevolezza.
Un esame anacronistico: liturgia commemorativa e sterile “rito di passaggio”
L’Esame di Stato dovrebbe rappresentare un momento di passaggio, il rito che segna il passaggio alla vita adulta. Ma nella sua forma attuale sembra sempre più un’antica liturgia da rispettare per tradizione, e non un’esperienza significativa per chi la vive. È un esame che non accompagna, ma giudica per frammenti. Che misura l’esecuzione, la memorizzazione, non la comprensione profonda. Che pretende rigore, ma offre poca coerenza.
Un esempio? La prova scritta di italiano. È uguale per tutti, indipendentemente dall’indirizzo frequentato. Che provenga da un tecnico commerciale, da un professionale agrario o da un liceo classico, lo studente ha a che fare con le medesime tracce. Dove sarebbe il senso pedagogico? Si finge equità, quando in realtà si ignorano competenze e percorsi.
Poi c’è l’aspetto più surreale: si scrive ancora tutto a mano, come se fossimo in un’era del tutto analogica. Nel 2025, chiediamo ai ragazzi – cresciuti con smartphone, tastiere, cloud e app – di scrivere un testo argomentativo senza usare strumenti che ormai persino uno scrittore usa ogni giorno. La possibilità di spostare paragrafi, di rileggere in sequenza e migliorare. Chi scrive molto ed è costretto a farlo bene, sa perfettamente che rileggere un testo scritto a mano pieno di asterischi, inserimenti, rimandi, cancellature è quanto di meno efficace ci possa essere, in termini di qualità finale del testo. È bene dirlo chiaramente: il copia-incolla non serve per copiare, ma per ripensare, riorganizzare, curare la coerenza del testo. Scrivere bene oggi significa anche saper usare gli strumenti digitali. Negarli è didatticamente miope.
E non finisce qui. La seconda prova di informatica dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali è stata svolta carta e penna. Sì, proprio così: futuri programmatori hanno dovuto scrivere codice a mano, senza computer, senza possibilità di eseguire o testare nulla. È come chiedere a un musicista di comporre senza poter ascoltare una nota, o a un cuoco di scrivere la ricetta senza toccare un ingrediente. Semplicemente, un’assurdità.
L’orale, nella maggior parte dei casi, si rivela uno “spezzatino” di domande che creano collegamenti forzati (giuro di aver assistito al “collegamento” tra la Resistenza e la resistenza come concetto di elettronica…), senza citare i “materiali” da cui si parte per una delle sezioni del colloquio (fotografie mal riprodotte, frasi decontestualizzate… altro che cultura e competenze!)
L’esame, così com’è, non racconta ciò che uno studente sa fare davvero. Non premia l’intelligenza viva, la capacità di costruire senso, la creatività che è ormai alla base di ogni professione. Misura solo l’abilità di aderire a un rituale obsoleto. E questa, francamente, non può più essere la nostra idea di “maturità”.
I commissari esterni: tra rivalsa e aria di conquista
Un altro tasto dolente riguarda i commissari esterni. Una figura nata, in teoria, per garantire equilibrio e imparzialità. Ma che in pratica (troppo spesso) si trasforma in una figura giudicante, fredda, distante. E a volte anche ostile. Togliamoci la maschera dell’ipocrisia. Chi lavora da anni nella scuola sa bene che in molti casi è così…
Certo, ci sono docenti eccellenti e rispettosi del percorso e del vissuto dei ragazzi. Ma, per contro, non sono pochi i commissari esterni (presidente compreso) che arrivano con l’idea di “mettere alla prova” gli studenti, più che valutarli con onestà. C’è chi cerca conferme alla propria autorità culturale. Chi entra in aula con il pregiudizio che “in questa scuola non si insegna abbastanza”. Chi, diciamolo, vive l’esame come una rivalsa personale, un’occasione per mettere in difficoltà il ragazzo, e per mostrare quanto “preparato” è lui.
È una fotografia amara e reale di ciò che spesso accade. E che nulla ha a che fare con la funzione educativa che dovrebbe avere l’esame.
Perché non ascoltiamo davvero i ragazzi?
Parliamo continuamente (nei convegni, nei documenti, nei PTOF) di competenze trasversali, cittadinanza attiva, spirito critico. Diciamo che vogliamo studenti protagonisti, capaci di pensare, di prendere posizione. Poi, appena qualcuno lo fa davvero, ci scandalizziamo. Lo zittiamo. Lo giudichiamo.
E se invece quel gesto fosse proprio la prova che qualcosa, in fondo, abbiamo seminato bene? Se quel silenzio non fosse un vuoto, ma un “urlo educato”? Una richiesta: “Guardami per chi sono, non per come rispondo”.
Il punto è che non sappiamo ascoltarli. Li osserviamo solo con il metro del voto, del rendimento, dell’obbedienza. Ma educare, lo sappiamo, non è addestrare.
Il peso (sopravvalutato) del voto finale
Un altro aspetto su cui è urgente fare chiarezza riguarda il valore reale del voto finale di maturità. Nella percezione di molte scuole – e spesso anche delle famiglie – quel numero rappresenta una sorta di “marchio” indelebile, un’etichetta che accompagnerà per sempre lo studente. Ma la realtà è ben diversa.
Le università, nella stragrande maggioranza dei casi, non considerano il punteggio di uscita come criterio di accesso o selezione, se non in modo marginale. Solo il 100 o il 100 e lode può talvolta fare la differenza, ad esempio per l’accesso a borse di studio, a premi simbolici, o alla cosiddetta “Carta del merito”. Ma tutti gli altri voti, pur formalmente diversi, hanno lo stesso identico peso pratico: nessuno. In molti casi, l’ammissione a un corso di laurea si basa su test d’ingresso standardizzati, spesso indipendenti dai risultati scolastici. Segno concreto ed inequivocabile di quanto l’università si “fidi” poco del percorso della secondaria di secondo grado.
Eppure, nelle scuole superiori, si continua a trasmettere l’idea che il voto finale sia il coronamento, la misura ultima del valore personale e scolastico. Una narrazione illusoria, che genera pressioni ingiustificate, tensioni familiari, senso di fallimento o di superiorità fondati su un numero che, nei fatti, non determina il futuro.
Forse è il momento di dircelo con onestà: non è il voto di maturità a fare la differenza, ma ciò che i ragazzi sanno e sanno fare davvero. E su questo dovremmo iniziare a costruire nuove forme di riconoscimento, più autentiche e coerenti con la realtà.
Ripensare l’esame: cinque proposte fondate sul percorso, non sulla performance
Criticare è facile, certo. Ma chi vive la scuola ogni giorno sa che la critica ha valore solo se apre la strada a una proposta. L’Esame di Stato non va abolito in blocco, né difeso a oltranza in nome della tradizione. Va ripensato radicalmente, perché oggi non misura più ciò che dovrebbe misurare: il percorso, la crescita, l’identità dello studente, le competenze che servono per la vita.
È tempo di uscire dalla logica del “si è sempre fatto così” e domandarci: che senso ha oggi questo esame? Serve davvero a chi lo sostiene? Riconosce il valore delle persone o solo delle prestazioni? Serve un nuovo patto educativo. Un nuovo esame. Più giusto, più utile, più umano.
Ecco, allora, cinque proposte concrete che vanno in questa direzione.
1. Il peso del percorso, non del momento
Alla fine del percorso, è il percorso stesso a contare. Lo studente ha già scritto decine di temi, ha sostenuto interrogazioni, ha prodotto materiali. Non ha senso proporre un’ultima prova slegata da tutto ciò. Serve una valutazione complessiva, pensata, condivisa. Non una prestazione finale “one shot”. Più peso ai crediti del percorso, che non dovrebbero essere compressi nel solo triennio conclusivo.
2. Elaborato personale come passaggio di identità
Ogni ragazzo dovrebbe arrivare all’esame con un “capolavoro”, un lavoro che lo rappresenti. Un progetto, una ricerca, un testo, qualcosa che dica: “Ecco chi sono diventato”. Questo avrebbe davvero valore formativo e simbolico. Il “capolavoro” è già stato introdotto, ma non ha peso, al momento.
3. Orale come dialogo, non come quiz
L’orale dovrebbe essere un momento di confronto, di scambio vero. Parlare di attualità, di esperienze, di idee. Basta con i “collegamenti” forzati tra Pirandello e il DNA. Basta con le domandine a raffica. I ragazzi lo capiscono subito quando si tratta di una prova “a trabocchetto”. E non imparano nulla.
4. Commissari esterni: formazione e rotazione
Chi arriva da fuori deve sapere dove arriva. Servono formazione, consapevolezza del contesto, chiarezza sul ruolo. E anche una rotazione continua, per evitare il rischio di personalismi, abusi o rivalse.
5. Valutazione descrittiva e multidimensionale
Oltre al numero finale, serve una valutazione che racconti. Che dica chi è il ragazzo, come lavora, quali attitudini ha. Le competenze trasversali – empatia, collaborazione, creatività, gestione dello stress – devono emergere. Perché sono quelle che fanno davvero la differenza nella vita.
Ascoltare senza paura
In più di quarant’anni nella scuola, ho visto di tutto: eccellenze luminose e fragilità invisibili. E ogni anno, davanti all’Esame di Stato, mi domando: stiamo davvero restituendo ai ragazzi ciò che meritano? Stiamo costruendo un ponte verso il futuro o solo ripetendo vecchi rituali?
Io credo che la protesta di Maddalena e degli altri sia un’occasione. Non per indignarsi, ma per rimettere in discussione il nostro sistema. Perché ascoltare non è debolezza. È coraggio. E forse oggi, il nostro dovere di adulti ed educatori è proprio questo: avere il coraggio di ascoltare davvero.
*Dirigente scolastica
© RIPRODUZIONE RISERVATA









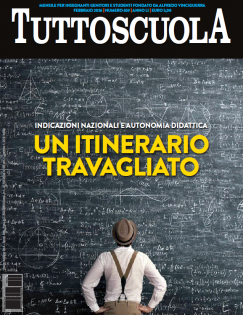




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via