
Il pensiero critico diffuso come argine strategico al ritorno della politica di potenza

Di Gaetano Domenici
Come ormai appare evidente dai fatti salienti accaduti nel mondo in questi ultimi quattro-cinque anni, alcuni dei più importanti paradigmi di riferimento, sul piano del diritto internazionale, nonché della organizzazione della vita sociale interna a ciascun Paese, ereditati dal passato e/o via via elaborati e condivisi dopo la tragedia del secondo conflitto mondiale, sembrano quasi del tutto infranti, “superati”. Certo, in forma più eclatante paiono trasgrediti e sorpassati quelli che a partire dal primo dopo guerra hanno caratterizzato le relazioni internazionali tra i diversi Paesi – democratici e non-. Da questo angolo visuale paiono drammaticamente emblematici tanto l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, nel febbraio del 2022, ovvero l’uso arbitrario della forza per risolvere conflitti di interessi da parte di un Paese più forte a scapito di uno pur indipendente e sovrano, ma militarmente più debole, quanto la messa a ferro e fuoco della striscia di Gaza e di parte del Libano da parte di Israele. Dichiarata come logica ritorsione israeliana dell’eccidio del 7 ottobre del 2023 perpetrato da Hamas, ha già causato in quindici mesi la morte di oltre 46mila civili inermi (stime ONU), in gran parte donne e bambini, senza che si registrasse nel mondo quella indignazione e quella reazione di cittadini e governi democratici (purtroppo non risolutive le pur encomiabili manifestazioni interne a Israele) capaci di indurre i responsabili a porre fine a quel massacro. Particolarmente preoccupante è apparsa in questo quadro, l’eccessiva cautela politico-valutativa dell’Unione Europea e dei paesi occidentali quando a violare quei paradigmi di civiltà è risultato essere un Paese democratico, Israele, sostenuto dal più forte dei paesi democratici. E ciò a dispetto, si direbbe, delle raccomandazioni e delle risoluzioni ONU, la cui inadempienza ha peraltro certificato l’impotenza effettiva di questa pur meritoria organizzazione (esattamente come era già avvenuto un secolo prima con la Società delle nazioni con l’avvento del nazismo), e nonostante sia ancora viva la memoria della mostruosità aberrante del secondo conflitto mondiale e la stessa l’UE abbia posto a proprio fondamento non solo il benessere dei propri membri, ma anche e soprattutto la cura e la difesa di valori quali l’equità, la libertà, la pace e la democrazia. Per ultima, in ordine di tempo, in perfetta coerenza logico-politica con il mancato rispetto delle regole del gioco democratico delle relazioni tra gli Stati e dell’uso arbitrario della forza, cui prima si è accennato, la dichiarazione minacciosa del nuovo presidente americano, Ronald Trump, nella sua recente conferenza stampa del 7 gennaio, di impossessarsi – se necessario con la forza, ha precisato – della Groenlandia, del Canale di Panama, che dovrebbe rinominarsi Canale d’America, di “scatenare” infine, l’inferno sulla striscia di Gaza” se prima del suo insediamento alla Casa bianca, non saranno stati liberati da Hamas i prigionieri israeliani. Dichiarazioni confermate, dopo che i giornalisti presenti avevano pensato ad uno scherzo, che possono ben rappresentare, tra l’altro, il viatico politico per l’annessione – senza clamore e senza la violazione delle “nuove norme” (sic!) – della Repubblica indipendente di Taiwan da parte della Cina.
Non è dunque per caso che il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso tenuto il 13 di questo gennaio 2025 all’incontro nel Palazzo del Quirinale con i vincitori del concorso per Segretari di Legazione, primo grado della carriera diplomatica, – di cui qui si riporta uno stralcio – abbia insistito sull’importanza e il rispetto delle norme che regolano la civiltà dei rapporti tra Stati, anche al fine di “promuovere la collaborazione e la reciproca comprensione”, “trovare soluzioni condivise” e pacifiche ai conflitti e far fronte alle “sfide che il mondo ha davanti”:
“ Questo è un periodo pieno di grandi incertezze e tensioni nella vita internazionale, di grandi tensioni a causa dei conflitti e a causa di ritorni ottocenteschi a una politica di potenza. Sembra quasi che siamo in presenza di una sorta di ritorno a una visione di politica di potenza, estranea ai tempi, ed estranea alla coscienza comune maturata dalla civiltà in questo nostro tempo.(corsivo ns)
È una condizione di conflitto stridente, di stridente contrasto tra le esigenze che il mondo ha davanti, le sfide che deve affrontare: da quella della salute globale, come la pandemia ci ha insegnato, a quella del mutamento climatico, a quella delle distanze abissali di carattere alimentare nel mondo, a quella della difficoltà provocata dagli squilibri che nel mondo vi sono, che richiederebbero risposte comuni e condivise. E, dall’altra parte, le tensioni, le guerre, le aggressioni, la volontà di imporre agli altri Stati la propria volontà con la forza.
È davvero una singolare contraddizione tra esigenze dell’umanità e condizioni che, in questo periodo, presenta la comunità internazionale. Anche per questo, contro questa deriva internazionale di violenza, di rifiuto del dialogo e dell’attitudine alla collaborazione, alla reciproca comprensione, la nostra diplomazia è sempre stata impegnata nella ricerca della pace, della collaborazione, della comprensione reciproca, appunto, dell’intendimento di trovare soluzioni condivise nelle difficoltà che inevitabilmente si pongono nei rapporti internazionali. E questo compito viene svolto dai nostri diplomatici con grande sagacia, che merita riconoscenza.”
Parimenti rilevante risulta – sul piano dei mutamenti “genetici”, si direbbe, rilevati in questi anni – il superamento in corso dei “tradizionali” modelli paradigmatici di analisi valutativa delle modalità d’uso e di governo dei sistemi informativi e della comunicazione via via diffusi o adottabili dai diversi Paesi. Un superamento dei vecchi modelli di riferimento accentuato e accelerato dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) e dell’IA-generativa, e dal moltiplicarsi dei loro fronti applicativi (da quello del lavoro a quello dello svago e del divertimento, passando per quello culturale, educativo, eccetera). L’imprevedibilità del mutamento registrato e percepito, ma anche e soprattutto la negatività di alcuni degli effetti che esso ha fin qui prodotto e ancor più, forse, la percezione di impotenza nei processi di orientamento e di governo dello stesso cambiamento, ha incrementato, non già ridotto, come alcuni speravano, l’incertezza del futuro.
Il pericolo maggiore parrebbe, ora, almeno per i Paesi democratici e per le loro reciproche relazioni – qualunque sia il loro grado di democraticità – l’influenza decisiva dell’uso commerciale privatistico delle informazioni e della comunicazione, ovvero di costellazioni di satelliti per l’accesso a internet globale, soprattutto nella determinazione dei processi e dei risultati elettorali. Si teme, non a torto, che possa così venir indebolito, se non abolito, quell’elemento costitutivo di ogni democrazia che è dato dalla libera costruzione e strutturazione della volontà e dell’orientamento politico dei singoli cittadini e/o di gruppi organizzati di essi. Il consenso, parrebbe ormai che venga promosso primariamente – ahi noi impercettibilmente e inconsapevolmente – dalla moderna tecnologia dell’informazione e della comunicazione a livello globale, posseduta da singoli oligarchi del potere informativo (il cui numero a livello mondiale non supera le dita di una mano), ovvero da quello che è stato definito “capitalismo post democratico”. Un consenso non più promosso, perciò, attraverso uno spazio o foro pubblico pluralista, con cui secondo i vecchi paradigmi, si favoriva la composizione –certo non perfetta, ma abbastanza fedele – dell’opinione pubblica.
Emblematiche, su questo versante, le ormai frequenti ingerenze politiche nella vita democratica degli Stati esercitate da parte di detentori privati, spesso monopolistici, delle più moderne e pervasive tecnologie della comunicazione. Ingerenze che a differenza di quelle sempre esistite, ora, anche in forza dell’Intelligenza artificiale, si caratterizzano come strumentalmente capaci di creare, strutturare e sostenere una vera e propria opinione pubblica in grado di determinare a sua volta processi e esiti elettorali. Paradigmatiche, di questa fattispecie, sono, per fare qualche esempio, le richieste, le esortazioni, gli inviti e i comunicati politici a livello globale oltre che dei singoli Paesi, da parte del proprietario di Starlink e di X (il social network già noto come Twitter), ora il più organico e ascoltato consigliere del nuovo presidente degli USA, alcuni dei quali si sintetizzano qui di seguito: la richiesta di dimissioni e di arresto del premier britannico per reati abominevoli, non comprovati; l’invito a licenziare e incarcerare come indegni i giudici italiani che in piena autonomia – quella giudiziaria è garantita dalla nostra Costituzione – hanno assunto decisioni indipendenti, non congruenti con quelle governative, su alcuni delicati problemi dell’immigrazione; la “denuncia” di “incapacità mentale e politica” del cancelliere tedesco – con contemporanea intervista ed esaltazione della segretaria del più potente partito neonazista della Germania – e si potrebbe continuare, fino a quelli che hanno orientato le stesse elezioni americane.
Certamente, i contagiosi deliri di onnipotenza manifestatisi in questi anni recenti stanno contribuendo non poco a far regredire a stadi antecedenti il grado avanzato di civiltà raggiunto dall’uomo seppur in maniera disomogenea sul nostro pianeta. La drammaticità degli effetti sta tuttavia favorendo l’avvio di una analisi critica tanto del problema della strutturazione democratica delle decisioni politiche nei singoli Paesi e nelle organizzazioni internazionali, quanto degli assetti proprietari e di impiego di beni e strumenti che per quanto risultato dell’opera dell’ingegno umano, individuale e non, possono diventare, se lasciati al governo di pochi o di singoli soggetti, mezzo di asservimento quanto non di possibile causa diretta o indiretta di auto-distruzione della civiltà umana.
I rischi possibili del cambiamento tecnologico davvero epocale che da qualche anno stiamo vivendo non sono intrinsecamente organici alla modernità, ma derivano, ancora, dall’uso che dei nuovi mezzi viene fatto. Orientare e contribuire a governarne l’uso in modo democratico dentro e tra i Paesi del nostro pianeta riveste dunque un rilievo fondamentale. A parere di molti esperti – uno per tutti, il Rettore dell’Università dell’ONU, Tshilidzi Marwala che gode di un osservatorio politico-culturale straordinario per cogliere i fatti salienti del mondo – è proprio nei contesti appena descritti che emerge la necessità, diventata già urgente, di promuovere le condizioni educative, soprattutto formali, affinché venga incentivata la promozione, la fioritura e la diffusione più estesa possibile del pensiero critico. Si impone dunque una “rivisitazione critico-propositiva”, come è stata definita, delle funzioni e delle strutture educative deputate in genere, a istruire e a formare le nuove generazioni, magari a cominciare dall’Italia e dai Paesi UE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA








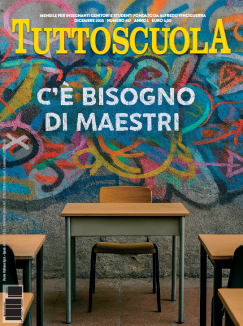




Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via